Gli psicologi, l’antipsichiatria e la legge 180
È noto, anche se non ci si fa più caso, il grave ritardo che contraddistinse la nascita in Italia della psicologia e delle altre scienze umane. Due furono gli elementi che determinarono in maniera confluente questa nascita postuma: da una parte la nefasta influenza esercitata fino al boom economico dell’inizio degli anni ’60 sul nostro ordinamento accademico dal pensiero gentiliano e crociano, che non attribuiva valore scientifico alla psicologia, così come alla sociologia etc.; dall’altra l’arretratezza della nostra società che – sempre fino al boom – poté fare a meno degli apporti che in altre nazioni le scienze umane avevano saputo fornire ai governi, alla società e all’economia. È meno noto che uno degli elementi che condussero nel 1962 alla nascita a Trento della prima facoltà di sociologia – dalla quale una decina di anni dopo per gemmazione vedrà la luce a Padova la prima facoltà di psicologia – fu la spinta che derivò dalla parte più avanzata della Confindustria.
Sempre all’inizio degli anni ’60 Basaglia e la sua équipe, in polemica esplicita con la psichiatria accademica, cominciano a sperimentare sul campo a Gorizia quei metodi di cura della malattia mentale che poi costituirono il fondamento dell’antipsichiatria italiana. Ed è dall’incontro nel ’68 fra gli antipsichiatri e il movimento studentesco italiano che nasce quella tendenza che vide coinvolta, al fianco dei primi antipsichiatri, una generazione di giovani laureati non medici che costituirono il nucleo iniziale degli psicologi che poi operarono all’interno del movimento antipsichiatrico.
Non si trattava ancora di laureati in psicologia, poiché le due facoltà di psicologia di Padova e Roma erano appena nate, ma di giovani pedagogisti, sociologi, filosofi, inquadrati negli organici dell’antipsichiatria come “psicologi” grazie a quell’alleanza fra operatori critici e amministratori locali accorti, che già prima del varo della 180 «avevano cercato di organizzare alternative al manicomio», come ha scritto recentemente Maria Grazia Giannichedda (https://volerelaluna.it/rimbalzi/2020/08/31/dopo-basaglia-la-riforma-psichiatrica-tradita/) e – mi permetto di aggiungere – che avevano permesso la prosecuzione di questa, come delle altre sperimentazioni figlie del ’68 anche quando i movimenti politici e sociali che in fondo le avevano promosse entrarono in crisi. Giovani che una comune propensione iniziale al “missionariato sociale” spinse a operare insieme ai loro coetanei psichiatri, infermieri, educatori, ma anche a stretto contatto con gli operatori della sanità, della scuola, dei nidi, delle scuole per l’infanzia e di ogni altro luogo di sperimentazione nato fra la fine degli anni ’60 e l’inizio negli anni ’70.
Giovani psicologi, ai quali subito si aggiunsero i primi laureati in psicologia, che però – al contrario dei medici che si opponevano a una tradizione consolidata nel tempo, pietrificata nell’istituzione “manicomio” che i loro colleghi psichiatri dirigevano da oltre cent’anni, e a un’accademia dalla quale erano stati espulsi – non trovarono dall’altra parte né i rappresentanti di un mestiere consolidato nel tempo, né un’accademia psicologica portatrice di una qualsiasi tradizione, e tantomeno una pratica clinica psicologica cui riferirsi o giustapporsi. Per cui da una parte i giovani psicologi che operarono nei territori dell’antipsichiatria per oltre un ventennio e fino a che fu possibile (magari coniugando i postulati antipsichiatrici con altri assunti psy) poterono pensare e sperimentare sul campo un approccio con i pazienti che era dialogico, personale e dinamico, e non più diagnostico, oggettivante e segregante; un metodo basato su uno stretto rapporto con le loro famiglie, i loro luoghi di vita, di studio e di lavoro e volto alla dinamica predisposizione di strutture intermedie che ne favorissero il reinserimento. E in sottofondo una disposizione al lavoro poli-professionale che aveva nella orizzontalità dell’équipe il momento principe di riflessione, programmazione e verifica; nella formazione del personale operante delle vecchie istituzioni totali un metodo che permetteva loro d’inserirsi gradualmente e a pieno titolo nei territori della sperimentazione; e da ultimo nell’ancoraggio al “pubblico” l’elemento che permetteva il solidificarsi nel tempo dell’alleanza con quella generazione di amministratori.
D’altra parte però l’accademia psicologica continuò a formare decine di migliaia di psicologi che alla fine del processo formativo si aspettavano di diventare Sigmund Freud e non solo si ritrovavano Billy il Coyote – come ebbero a dire in un simpatico libretto alcuni neolaureati una ventina d’anni fa – ma soprattutto si avviarono a frequentare percorsi formativi post lauream che, al contrario di quelli degli psichiatri, furono fin da subito affidati a scuole di formazione private costosissime, cresciute come funghi sotto lo sguardo perlomeno distratto del Miur, e capaci solo di formare psicoterapeuti: cioè gente in grado di svolgere solo un lavoro monoprofessionale.
Così quando all’inizio degli anni ’90, con la seconda repubblica, venne meno l’alleanza fra operatori critici e amministratori accorti, poiché questi ultimi furono sostituiti da una nuova generazione che aveva i suoi caposaldi nell’aziendalizzazione e nella privatizzazione, si innescò una serie di fenomeni che nell’arco di una decina d’anni aprirono la strada alla liquidazione dell’esperienza antipsichiatrica e alla giubilazione della 180; così come del resto a tutte le conquiste degli anni ’70.
Pier Francesco Galli in un’intervista risalente a quel periodo già accennava ai pericoli insiti in un settore come la psichiatria per l’emergere di una doppia leadership: la prima «che si muove per piani esclusivamente burocratico-amministrativi, completamente sganciata dalla linea operativa, che è assegnata alla seconda, composta dai dirigenti di primo livello, che rimangono ancora sul campo a operare e che assieme al proprio personale devono prendere delle decisioni nella quotidianità e che su questa base non hanno più nessuna identificazione con quegli stessi colleghi che si muovono nei livelli burocratico-amministrativi del sistema».
Ebbene quegli psichiatri che si muovevano nei livelli burocratico amministrativi del sistema oggi hanno preso il sopravvento; hanno privatizzato in direzione del privato sociale d’area, laddove come dice Maria Grazia Giannichedda, «cresce una pletora di “residenze” variamente denominate in cui il tempo passa senza progetto, né senso […] creando focolai d’infelicità».
Mentre, a causa della rinuncia alla definizione di un pensiero critico sulla malattia mentale da parte dell’accademia psicologica, così come delle associazioni degli psicologi e ovviamente delle scuole di psicoterapia, gli attuali giovani psicoterapeuti ormai sono, spero non definitivamente, fuori gioco. E lo sono poiché in questi decenni hanno acquisito una propensione a lavorare in solitudine che li porta lontano dal “pubblico”, alla ricerca solo di pazienti disponibili e frequentare i loro ambulatori e a sposare i loro metodi claustrofilici. Nell’assenza dei quali poi si ritrovano spesso puntualmente demansionati e sottopagati a lavorare in queste “residenze” private che della struttura intermedia hanno solo la facciata; in cui il lavoro poli-professionale torna a essere un lavoro in batteria, l’équipe di fatto non esiste più, così come latita qualsiasi cenno alla formazione continua; ognuno fa la propria parte, e i manager del privato, che hanno ricevuto l’appalto da questa nuova leadership, curano i rapporti col politico di turno.
Leonardo (Dino) Angelini
17/9/2020 https://volerelaluna.it



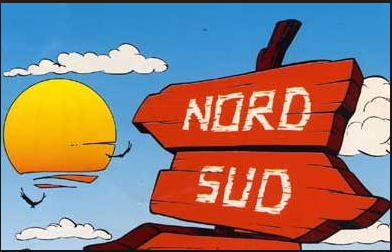


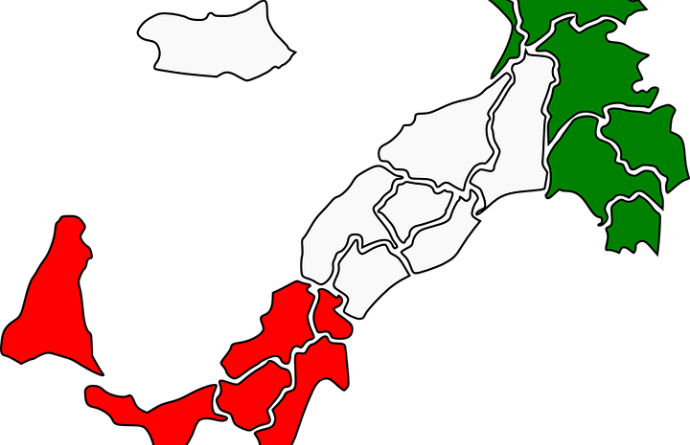



Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!