I salari in Italia e in Europa negli ultimi 30 anni
Ogni tanto i mezzi di comunicazione e la ricerca sindacale ed accademica italiana scopre che da decenni (almeno tre) l’Italia è l’unica tra le economie avanzate dove i salari sono diminuiti. Quello che però raramente viene detto è che la polarizzazione verso il basso in termini salariali e occupazionali è il risultato di politiche economiche decise dai governi e dall’Unione Europea e implementate dalle imprese con l’obiettivo di recuperare competitività attraverso la compressione salariale nell’ambito del processo di globalizzazione neoliberista. La pandemia da CoVid-19 ha fatto emergere nuovi orientamenti in ambito governativo ed europeo, ora la sfida è quella di fare sì che nel breve periodo si consolidino in un nuovo paradigma quantomeno di stampo socialdemocratico.
Bassi salari: guardare a prima della pandemia
In Italia esiste una questione salariale grande come una casa, ma di cui poco si parla. Mentre negli ultimi 30 anni in tutto il continente europeo i salari medi annuali1 sono andati progressivamente aumentando (in alcuni casi in maniera molto evidente), come ha evidenziato un’analisi recente, oggi in Italia si guadagna meno che nel 1990.
Non si tratta solo dell’effetto negativo della pandemia da CoVid-19 (che pure c’è stato), ma del risultato di anni di politiche governative tese a promuovere la moderazione e anche la compressione salariale che sono state implementate dalle imprese con l’obiettivo di recuperare competitività.
La pandemia ha certamente avuto effetti significativi sul mondo del lavoro: ha creato più disoccupazione e inasprito molte disuguaglianze socio-economiche preesistenti. Anche in Europa molti posti di lavoro sono andati perduti e il numero di ore lavorate in media ha registrato un calo, soprattutto per quanto riguarda le professioni meno retribuite. Mediamente nel 2020 la massa salariale, con cui si intende il totale dei salari lordi non standardizzati, è infatti diminuita rispetto al 2019.
Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), la pandemia da CoVid-19 ha creato enormi difficoltà per i lavoratori e ha contribuito al peggioramento delle loro condizioni di vita in tutto il mondo. Nell’Unione Europea, il problema più rilevante è stato il taglio delle ore lavorative, mentre quello della perdita del lavoro è stato in buona parte arginato da misure di salvaguardia a livello nazionale, che sono riuscite a contenerne gli effetti più negativi. Questo in Italia si è concretizzato con il blocco dei licenziamenti, in vigore da febbraio 2020 a fine giugno 2021 (fine ottobre per le aziende che accedono agli ammortizzatori sociali introdotti dal Decreto sostegni e fine dicembre per i datori di lavoro che accederanno alla Cassa integrazione).
Durante la pandemia, anche la perdita di massa salariale è stata limitata grazie a misure statali. In particolare, i sussidi, messi in campo da gran parte dei Paesi europei, avrebbero dimezzato secondo l’OIL l’impatto della crisi, riportando la perdita effettiva a -3,1% (rispetto al -6,5% iniziale)2. Addirittura, secondo l’OCSE, in alcuni Paesi europei tra il 2019 e il 2020, nonostante la pandemia, i salari medi annuali sarebbero lievemente aumentati. È, per esempio, il caso dei Paesi Bassi (+2,4%), e di alcune nazioni dell’Europa centrale tra cui la Slovenia (+2,3%), ma anche dei Paesi baltici (soprattutto la Lettonia, con un aumento pari al 7,1%). Mentre nei Paesi del sud Europa, come Francia, Spagna e Italia si è registrato un lieve calo, pari rispettivamente al 3,2% per la Francia, al 2,9% per la Spagna e al 5,9% per l’Italia.
Nel 2020, nel mezzo della pandemia, il salario medio annuale di un cittadino lussemburghese era il doppio di quello di un greco, e quasi tre volte quello di uno slovacco. In generale, ad avere i salari medi più alti sono i Paesi dell’Europa nord occidentale (Lussemburgo, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca), mentre quelli più bassi li registrano Stati membri dell’Europa centrale (Slovacchia e Ungheria) e meridionale (Grecia e Portogallo).
L’andamento dei salari negli ultimi 30 anni
In tutti i Paesi europei OCSE, fatta eccezione per l’Italia, dal 1990 ad oggi il salario medio annuale è aumentato. L’aumento maggiore si è registrato nei Paesi dell’Europa centrale e orientale. In Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, ad esempio, il salario medio annuale è raddoppiato. Ma, le percentuali più alte si riscontrano nei Paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), dove tra il 1995 e il 2020 i salari sono più che triplicati. Si tratta di Paesi in cui i salari medi annuali, 30 anni fa, erano molto più bassi rispetto a quelli degli altri Paesi europei. La Lituania, ad esempio, è il Paese europeo OCSE che ha registrato il più grande miglioramento in questo senso, nel 1995 la retribuzione era pari a poco più di 8 mila dollari l’anno. Nel 2020, invece, è salita a circa 32 mila.
I Paesi dell’Europa meridionale, come Spagna e Portogallo e in misura minore la Grecia hanno invece registrato degli aumenti decisamente più modesti (13,7% per il Portogallo e 6,2% per la Spagna). Rispetto ai Paesi dell’Europa centrale e orientale, i Paesi dell’Europa meridionale hanno registrato degli incrementi piuttosto modesti negli anni. In Spagna, ad esempio, il salario medio annuale nel 1990 era pari a circa 36 mila dollari, mentre nel 2020 è arrivato a 38 mila. Una situazione analoga è quella del Portogallo, passato da 25 mila dollari di salario medio nel 1995 a poco più di 28 mila nel 2020. Un po’ diverso invece il caso della Grecia che, partendo da circa 21 mila dollari nel 1995, ha registrato un aumento piuttosto importante fino al 2009 (34 mila), per poi calare progressivamente. Rispetto sia ai Paesi dell’Europa settentrionale e occidentale che a quelli dell’Europa centrale ed orientale, nei Paesi europei più meridionali c’è stata quindi una sostanziale stagnazione dei salari.
Questo fenomeno è stato particolarmente evidente in Italia3. Qui, il maggiore aumento in quanto ad entità della retribuzione si è registrato negli anni tra il 1995 e il 2010, in cui si è progressivamente passati da un salario medio annuale di circa 37 mila dollari ad uno di 42 mila. Un aumento comunque molto lontano da quello delle altre nazioni europee, se pensiamo che il salario medio irlandese, per esempio, è passato negli stessi anni da circa 31 mila a quasi 50 mila dollari. Tra il 2012 e il 2019 poi la variazione è stata minima, mentre tra il 2019 e il 2020 c’è stata una diminuzione piuttosto importante, che ha riportato i salari italiani al di sotto dei livelli del 1990. Se all’inizio degli anni ’90 l’Italia era il settimo stato europeo subito dopo la Germania per salari medi annuali, nel 2020 è infatti scesa al tredicesimo posto, sotto a Paesi come Francia, Irlanda, Svezia (che negli anni ’90 avevano salari più bassi) e Spagna.
Alle radici dei bassi salari: il fallimento della politica e della classe imprenditoriale
Per capire come mai il secondo Paese industriale dell’Unione Europea (il 18% del PIL viene dal manifatturiero, in Germania il 22%, in Spagna il 14% e in Francia l’11%), la terza economia dell’Eurozona (l’Italia oggi rappresenta il 15,4% del PIL della zona euro e il 23,4% del debito pubblico del blocco), nonché l’ottava potenza del commercio globale (con una quota del 3,3%, sebbene l’Italia rappresenti solo il 2,4% del PIL globale), abbia avuto una vita grama, con bassi salari stagnanti, con tassi di produttività (in media dello 0,4% annuo tra il 1995 e il 2020, ossia un quarto di quelli di Francia e Germania) e di crescita economica minimi o addirittura negativi, bisogna tornare indietro alle decisioni politiche economiche attuate in questo ultimo trentennio.
La firma del Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) e l’ingresso nell’euro (1º gennaio 2001), così fortemente voluti dall’élite politica ed economica, è stato pesantemente pagato dal Paese. Non ha comportato un rilancio dell’economia italiana, che nel suo complesso non è stata in grado di cogliere le opportunità che avrebbero dovuto derivare dalla globalizzazione neoliberista e dalla moneta unica.
La classe politica della cosiddetta Seconda Repubblica – ciclo della vita politica italiana apertosi nel triennio 1992-94 con la crisi della “Repubblica dei partiti” che aveva governato il Paese dal dopoguerra, travolta dall’esplosione di una crisi finanziaria senza precedenti e dallo svelamento di una colossale tangentopoli da parte della magistratura – ha perseguito due obiettivi principali: “entrare in Europa” e cercare di restarci, da una parte, e riformare gli assetti istituzionali e costituzionali che avevano consentito l’applicazione del paradigma Fordista-Keynesiano a partire dagli anni ’60 e impedito “la democrazia dell’alternanza”, dall’altra. I risultati e gli effetti di questo duplice impegno sono stati a dir poco fallimentari sia per la qualità e vitalità della democrazia sia per il benessere e la crescita economica del Paese, per cui negli anni di espansione della globalizzazione neoliberista l’Italia, pur essendo un forte Paese esportatore di prodotti industriali, non è veramente riuscito a cavalcare l’onda, ma ha galleggiato e annaspato, finendo spesso sott’acqua, rischiando più volte di affogare.
La classe politica che ha governato in questi 30 anni porta la responsabilità di non aver fatto quasi nulla per cercare di frenare il declino industriale e porre le premesse di un suo rilancio e che, anzi, per decenni ha fatto a pezzi la scuola e l’università e non sa da tempo cosa significhi investire davvero in formazione e ricerca.
Dopo il 2000 l’espansione dell’attività produttiva è stata pressoché nulla, con modifiche profonde della struttura industriale. Dal 2000 al 2016, la produzione industriale, a prezzi costanti, è diminuita del 25,5% (del 19,5% tra il 2007 e il 2016), di contro un aumento di quella mondiale del 36,1%. Il tasso di produttività è restato troppo basso perché l’organizzazione del lavoro non è stata efficiente, si è smesso di investire e si è continuato a lavorare con impianti superati, e si è continuato a produrre prodotti o servizi che oramai il mercato non voleva più.
Molte imprese hanno cercato e continuano a cercano di recuperare i margini di profitto utilizzando tutta la flessibilità disponibile, abbassando il costo del lavoro o non pagando gli straordinari, invece che innovando l’organizzazione produttiva, adottando nuove tecnologie, investendo per crescere in dimensioni e qualità o per elevare le competenze dei propri collaboratori. L’assenza di una dinamica salariale ha spinto le imprese a puntare sulla concorrenza dei costi piuttosto che sulla concorrenza sulla produttività stimolata dagli investimenti.
Dai primi anni 2000 – secondo il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco: “le imprese si sono mantenute competitive non innovando, ma sostituendo persone che andavano in pensione con compensi elevati con giovani magari più preparati e produttivi, ma pagati meno e con contratti precari. E quando c’è una crisi, sono loro i primi a perdere il lavoro”.
Il vincolo esterno e i bassi salari
Al momento della firma del Trattato di Maastricht, l’Italia non rispettava nessuno dei parametri e criteri previsti: il tasso di inflazione era del 6,9%, il deficit di bilancio al 9,9% del PIL, il debito pubblico al 103% del PIL, il tasso di interesse a lungo termine l’11,9%. Inoltre, lo Stato italiano era il più grande datore di lavoro del Paese, garantendo quasi il 20% dell’occupazione complessiva nazionale. Controllava il settore del credito, attraverso la proprietà diretta o indiretta dell’80% delle banche. Era azionista totalitario di compagnie aeree, treni, traghetti, autostrade e strade provinciali. Produceva acciaio, alluminio, prodotti chimici, ma anche panettoni, gelati, pomodori pelati e cioccolato che vendeva nei supermercati e nelle aree di servizio autostradali. Costruiva aerei, carri armati, navi da guerra e da crociera. Produceva e distribuiva carburanti e, attraverso una fitta rete di utilities, distribuiva acqua, elettricità e gas. Gestiva miniere e il servizio telefonico. Era il principale editore radio-televisivo del Paese (RAI).
La scelta europeista della classe politica italiana implicava una svolta radicale, il doversi impegnare in modo coerente e continuativo per cambiare drasticamente la rotta delle politiche economiche (sul versante della spesa pubblica) e monetarie in senso neoliberista. Di questo era totalmente consapevole Guido Carli, ministro del Tesoro tra il 1989 e il 1992, che rappresentò l’Italia nei negoziati per la definizione dei contenuti del Trattato. L’ex governatore della Banca d’Italia riteneva che il Trattato di Maastricht avrebbe imposto “all’Europa la Costituzione monetaria della Repubblica Federale di Germania”, quindi “un mutamento sostanziale, profondo, di carattere ‘costituzionale’”. Ma lo apprezzava proprio per questo, perché avrebbe finalmente comportato “la ridefinizione delle modalità di composizione della spesa, una redistribuzione delle responsabilità che restringa il potere delle assemblee parlamentari e aumenti quelle dei governi”, per poi “ripensare in profondità le leggi con le quali si è realizzato in Italia il cosiddetto Stato sociale”.
Nel libro Cinquant’anni di vita italiana (a cura di Peluffo P., Laterza, Roma-Bari, 1993:436), Guido Carli ha delineato lucidamente e in modo brutale le principali implicazioni per un Paese come l’Italia, di fatto facendo equivalere l’adesione al Trattato ad un vero e proprio “colpo di Stato” perché consentiva un completo aggiramento del Parlamento sovrano della Repubblica per innestare nella società italiana una serie di ordinamenti economico-politici che questa non era stata capace di darsi da sola: “L’Unione Europea implica la concezione dello ‘Stato minimo’, l’abbandono dell’economia mista, l’abbandono della programmazione economica, la ridefinizione delle modalità di composizione della spesa, una redistribuzione delle responsabilità che restringa il potere delle assemblee parlamentari e aumenti quelle dei governi, l’autonomia impositiva degli enti locali, il ripudio del principio della gratuità diffusa (con la conseguente riforma della sanità e del sistema previdenziale), l’abolizione della scala mobile (con la sconfessione del principio del recupero automatico dell’inflazione reale passata e l’aggancio della dinamica retributiva all’inflazione programmata), la drastica riduzione delle aree di privilegio, la mobilità dei fattori produttivi, la riduzione della presenza dello Stato nel sistema del credito e nell’industria, l’abbandono di comportamenti inflazionistici non soltanto da parte dei lavoratori, ma anche da parte dei produttori di servizi, l’abolizione delle normative che stabiliscono prezzi amministrati e tariffe. In una parola: un nuovo patto tra Stato e cittadini, a favore di questi ultimi” [o meglio, di una parte di questi ultimi].
Dalla firma del trattato in avanti, la necessità di rispettare i parametri e criteri di Maastricht che secondo Guido Carli avrebbe dovuto “salvare l’Italia da sé stessa” – il cosiddetto “vincolo esterno” del “ce lo chiede l’Europa” con cui chi ha governato ha potuto smantellare pezzo dopo pezzo il precario e confuso edificio costruito con il compromesso Fordista-Keynesiano all’italiana, scaricando sull’Unione Europea il peso di scelte impopolari (un falso, dato che le decisioni sui temi principali debbono essere prese all’unanimità nel Consiglio Europeo) – è divenuta la stella polare della politica italiana grazie all’azione di una ristretta élite di esponenti dell’alta tecnocrazia politicizzata, appartenente soprattutto al centro-sinistra (Giuliano Amato, Carlo Azelio Ciampi, Beniamino Andreatta, Lamberto Dini, Mario Draghi, Romano Prodi, Tommaso Padoa-Schioppa, Sabino Cassese, Antonio Maccanico, Piero Barucci, Paolo Savona, Mario Monti, etc.), che considerava l’obiettivo di “entrare in Europa” e poi rimanerci come condizione sine qua non affinché la crescita economica potesse ripartire, e che è riuscita, per l’abbandono delle aspirazioni socialiste e per l’assenza o inconsistenza di validi scenari di futuro alternativi a quello neoliberista europeo, a portarsi dietro la stragrande maggioranza della classe politica di centro-sinistra (ormai liberal-democratica) e una parte di quella di centro-destra (meno interessata all’Europa e agli equilibri di bilancio, e più al taglio delle imposte) e a beneficiare di una “luna di miele” con i cittadini che hanno visto a lungo questi “tecnici” come dei “salvatori” e dei “modernizzatori” rispetto all’inconcludenza e all’immobilismo della politica nazionale del passato.
Molti cittadini hanno pensato che spostare il potere da Roma a Bruxelles fosse l’unico modo possibile per avere un governo efficiente, onesto, responsabile e attento alle loro esigenze. Così, un ristretto gruppo di alti tecnocrati ed esperti economici e finanziari (che si erano spesso formati nella Banca d’Italia o nel Ministero del Tesoro) ha usato il processo di integrazione europeo come “vincolo esterno” per aggirare i limiti di culture politiche italiane diffidenti nei confronti delle classi dirigenti tradizionali e del capitalismo, e per modificare il modello sociale italiano, introducendo anche in Italia una società di mercato regolata dal neoliberismo.
Almeno fino a dopo la crisi della globalizzazione neoliberista del 2007-2008, infatti, nonostante gli enormi costi politici, sociali ed economici sostenuti dal Paese per perseguire questo obiettivo, le sole forze politiche che hanno apertamente proposto politiche anti-liberiste sono state la sinistra radicale di matrice comunista e l’estrema destra di matrice neofascista, ma entrambe hanno avuto poco seguito, la sinistra perché, dopo gli eventi internazionali del 1989-1991, legata a un tipo di organizzazione sociale e a discorsi che sapevano di passato, la destra perché ancora reggeva il bando etico sul fascismo nato dalla Seconda Guerra Mondiale e dalla resistenza partigiana.
Questo ha voluto dire che sul piano politico i governi hanno governato senza vere opposizioni esterne, ossia hanno avuto ampi margini di manovra per operare interventi drastici, dolorosi ed impopolari per riportare i conti pubblici sotto controllo ed entro un sentiero di sostenibilità, recuperare credibilità sui mercati, alleggerire il peso degli interessi che cresceva a ritmo esponenziale facendo volare deficit e debito (si pensi che dal 1980 al 2007 lo Stato italiano ha contratto 1.335,54 miliardi di euro di debito, sui quali ha pagato ben 1.740,24 miliardi di euro di interessi), ma anche per imporre provvedimenti – le cosiddette piccole e grandi “riforme” – tesi ad adeguare (a rendere “compatibili”, così come previsto da Guido Carli) il mercato del lavoro, il sistema delle relazioni industriali, il sistema previdenziale e sanitario, i trasferimenti agli enti locali, il sistema bancario e dell’industria a partecipazione statale, l’amministrazione e financo il sistema elettorale e l’assetto costituzionale dello Stato, alle nuove esigenze e ai nuovi requisiti del capitalismo globale così come è stato declinato nell’ambito dell’Unione Europea, sperando che questi interventi, il nuovo riformismo e le produzioni ad alto valore intellettuale aggiunto fossero in grado di far ripartire la crescita, permettendo così alle classi popolari e medie di non abbassare i loro standard di vita.
Un percorso “riformistico” per diventare “europei” che è stato realizzato attraverso l’utilizzo ordinario della decretazione emergenziale e della legislazione delegata (che ha riformato in particolare la finanza pubblica e regionale e introdotto riforme chiave come quelle delle pensioni e del lavoro) da parte dei governi e, quindi, attraverso il rafforzamento dell’esecutivo a scapito del Parlamento. Nel 1992 sono stati emanati 139 decreti legge, che sono diventati 259 nel 1993, 327 nel 1994, 294 nel 1995 e 362 nel 1996. Numeri che, anche grazie ad una sentenza di censura della Corte di Cassazione (1996), non sono stati mai più raggiunti, ma che tuttavia segnano un mutamento di ordine strutturale nell’apparato statale: è in questi anni che l’esecutivo, tramite decreti legge e decreti legislativi, supera la legislazione parlamentare.
Di fatto, oggi sappiamo che questo “riformismo dall’alto” è stato più un tentativo di gestione razionale della declino e del contenimento della “democrazia distributiva” che del rilancio dello sviluppo. Un tentativo che solo in parte ha assicurato la tenuta socio-economica del Paese e la protezione dei diritti sociali (uguaglianza, tutela del lavoro, salari adeguati, pensioni dignitose), lasciando sul campo di battaglia una società ferita nel profondo, dove il welfare è diminuito, il lavoro è diventato precario, la demografia ha reso insostenibili i sistemi pensionistici e le classi medie e popolari hanno perso potere di acquisto.
L’antipasto è stato servito il 10 luglio 1992 dal governo Amato (1992-1993) con una “manovra correttiva” da 30 mila miliardi di lire, da ricavarsi tanto da tagli di spesa quanto da nuove tasse, con tanto di patrimoniale del 6 per mille sui depositi bancari e postali. Dalla Banca d’Italia, il governatore Ciampi ha messo mano alle riserve, aumentato il tasso di sconto, ma per sua stessa ammissione la credibilità del Paese sui mercati internazionali aveva ormai toccato il suo minimo storico. Proprio in quelle settimane, Amato ha giocato anche la carta della politica dei redditi e il 31 luglio ha raggiunto un’intesa con le parti sociali – sindacati e rappresentanze delle imprese – sul costo del lavoro e sulla soppressione della scala mobile (che dal 1975 garantiva il mantenimento del potere d’acquisto dei salari), sostituita con l’elemento distinto della retribuzione (costituito da una somma mensile fissa erogata per tredici mensilità).
L’accordo ha avuto l’effetto di mettere in moto un’ondata di proteste e scioperi dei lavoratori dipendenti contro i tagli, contro il governo e contro i dirigenti sindacali (il segretario della CGIL, Bruno Trentin, si dimise subito dopo aver firmato l’intesa nella quale non credeva, ma che firmò spinto dal timore che il fallimento della trattativa con il governo avrebbe avuto “effetti incalcolabili sulla situazione finanziaria del Paese”), colpevoli di averlo firmato, che ha rischiato di trasformarsi in un nuovo “autunno caldo”.
E’ importante sottolineare che a partire dall’accordo del 31 luglio 1993 si è passati da una indicizzazione trimestrale automatica dei salari per mezzo della scala mobile, ad una indicizzazione biennale teorica attraverso la contrattazione. Teorica, sia perché gli incrementi salariali sono stati legati alla inflazione programmata, che è risultata quasi sempre sensibilmente inferiore alla inflazione reale. Ma anche perché la stessa inflazione reale è stata misurata sulla base dell’indice Istat dei consumi che aveva poco a che fare con i consumi effettivi delle famiglie dei lavoratori e quindi con il potere d’acquisto dei salari. Infine, teorica perché gran parte dei lavoratori italiani e stranieri con contratti precari e di lavoro autonomo (il cui numero è stato in continuo aumento dal 1993) e la maggior parte di quelli addetti ai servizi all’impresa (sempre più decentrati fuori dalle aziende) sono stati, di fatto, esclusi dalla contrattazione. Questo spiega perché il salario reale è continuato a diminuire nei decenni successivi, facendo emergere una questione salariale in grado di accrescere inquietudini, sofferenza sociale ed effetti negativi della crisi e stagnazione economica.
L’Europa di Maastricht: perdita di sovranità, bassi salari e svalutazioni interne
Nel contesto del processo di globalizzazione neoliberista, l’Unione Europea nata con il Trattato di Maastricht rappresenta un caso emblematico di perdita di sovranità e potere reale da parte degli Stati nazionali sulle rispettive economie e società. Sappiamo che Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi e Robert Schuman (tutti nati nel cuore di quell’Europa centrale che aveva visto secolari tragedie frutto dello scontro fra Stati nazionali e multinazionali), ma anche Paul-Henri Spaak, Walter Hallstein e Jean Monnet, gli statisti padri fondatori dell’Europa post-bellica (quasi tutti democratico-cristiani cattolici e quindi con un legame con la struttura sovraterritoriale della Chiesa, il più antico soggetto “sovra” in Europa), avevano un disegno geopolitico ambizioso, così come lo avevano Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni ed Ursula Hirschmann, i federalisti europei di orientamento socialista riformista che avevano scritto e promosso il Manifesto di Ventotene per un’Europa libera e unita (1941) mentre due di loro erano stati condannati dal regime fascista al confino sull’isola di Ventotene tra il 1939 e il 1943: la pacificazione del continente attraverso la neutralizzazione della Germania (che aveva rappresentato il problema irrisolto della storia europea dalla guerra franco-prussiana del 1870-1871 in poi), il superamento dell’ostilità franco-tedesca e l’unione politica (un sistema istituzionale dotato di una sua autonomia costituzionale dagli Stati che l’avrebbero costruito), in modo da far convivere in pace, in democrazia e nel benessere i popoli europei.
Sappiamo anche che la Comunità Europea è stato un progetto della Guerra Fredda realizzato con il sostegno del Dipartimento di Stato USA per rafforzare le economie capitaliste del continente contro la minaccia sovietica, ma per i suoi fondatori ha anche incarnato sia il tentativo di addomesticare i nazionalismi tedesco e francese e di legarli alla più ampia comunità europea, sia la speranza dell’Europa come terza forza, indipendente sia dagli USA sia dall’URSS.
Infine, sappiamo che già nel 1939, Friedrich von Hayek, uno di padri dell’ortodossia neoliberista, difendeva lucidamente l’idea di una federazione e dell’abrogazione della sovranità nazionale, quali mezzi utili a implementare la sua concezione di società di mercato. Secondo l’economista austriaco, “l’abrogazione delle sovranità nazionali, e la creazione di un efficace ordinamento legislativo internazionale, costituiscono il necessario complemento e il logico compimento del programma liberale” (1939). Von Hayek sosteneva che il superamento della sovranità nazionale costituiva una condizione imprescindibile per promuovere la causa della pace, ma nel suo pensiero non doveva portare solamente a un’unione politica, bensì anche e soprattutto a un’unione economica, entrambe da realizzare nell’ambito di una “federazione interstatale”. Compito di questa costruzione era consentire la libera circolazione dei fattori produttivi – beni, persone e capitali – celebrata in quanto capace di spoliticizzare il mercato: di vanificare l’azione dei pubblici poteri volta a influenzare la formazione dei prezzi, proteggere lavoratori ed imprese dal “capitalismo rovinoso” e ad interferire ed ostacolare con ciò lo sviluppo del mercato autoregolato. Hayek celebrava il “vincolo esterno” rappresentato dalla forza condizionante di un mercato unico, che avrebbe impedito ai singoli Stati di promuovere anche politiche di emancipazione sociale: “sarà difficile produrre persino le normative concernenti i limiti al lavoro dei fanciulli o all’orario di lavoro”. Secondo Hayek, una federazione interstatuale avrebbe vanificato il conflitto redistributivo in quanto motore di scelte non allineate all’ortodossia neoliberista. “Una volta che le frontiere cessano di essere chiuse e la libera circolazione è assicurata, tutte … [le] organizzazioni nazionali, siano esse sindacati, cartelli o associazioni professionali, perderanno la loro posizione monopolistica e quindi, quali organizzazioni nazionali, il loro potere di controllare l’offerta dei loro servizi o prodotti.”
Dopo il fallimento della Comunità Europea di Difesa (CED), organismo previsto da un trattato firmato nel 1952 dagli stessi sei Paesi aderenti alla Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio – CECA (Belgio, Francia, Repubblica Federale di Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda), ma mai entrato in vigore a causa della mancata ratifica da parte dell’Assemblea francese (votarono contro gollisti e comunisti) nel 1954 (da allora la difesa dell’Europa occidentale è stata affidata completamente alla NATO), e a pochi mesi dalla sconfitta della spedizione anglo-francese di Suez (29 ottobre-7 novembre 1956), il Trattato di Roma, con cui il 25 marzo 1957 si istituì la Comunità Economica Europea (CEE), si era limitato a creare un mercato unico più ampio di quelli nazionali – una zona di libero scambio per la libera circolazione dei fattori della produzione (beni, servizi, persone e capitali), e tariffe doganali comuni nei rapporti con i Paesi terzi (un obiettivo raggiunto il 1° luglio 1968), un “liberismo temperato” che gli stessi promotori dichiaravano del tutto compatibile con una pianificazione economica nazionale di tipo francese o italiana (il cosiddetto “Piano Vanoni”, ossia lo “Schema decennale di sviluppo dei redditi e della occupazione” del 1954, ad esempio, venne inserito nel corpo del Trattato di Roma come protocollo allegato) -, con la speranza che con il tempo un analogo processo unitario si sarebbe trasferito anche alla politica.
Ci si aspettava che la rimozione delle tariffe interne e la nuova unione doganale portassero guadagni economici significativi per tutti gli Stati membri. Intensificando la concorrenza tra le imprese, si sosteneva che l’integrazione economica avrebbe costretto a migliorare la loro efficienza (rendendole in grado di rispondere positivamente alla “sfida americana”), mentre una maggiore specializzazione in conformità con la legge del vantaggio comparato avrebbe aumentato l’efficienza complessiva. Inoltre, l’espansione delle dimensioni del mercato avrebbe reso più facile sfruttare le economie di scala, portando a livelli più elevati di produzione. L’articolo 2 del Trattato di Roma stabiliva che “La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano.”
La CEE era il prodotto della fase Fordista-Keynesiana di piena occupazione e di crescita dei salari medi, di affermazione della democrazia rappresentativa e di sviluppo di sistemi pubblici nazionali di ridistribuzione. Ciascuno Stato-nazione aveva acconsentito a rinunciare a una limitata porzione di sovranità al fine di rafforzare le basi materiali della propria potenza. Non si parlava ancora di unione economica e monetaria, ma di mero coordinamento delle politiche economiche nazionali, oltretutto a partire da due finalità per molti aspetti contrastanti: la piena occupazione e la stabilità dei prezzi. Il che legittimava politiche di matrice neoliberale, ossessionate dal controllo dell’inflazione, ma anche politiche redistributive incentrale sul sostegno della domanda, ovvero di tipo keynesiano. Inoltre, mentre le merci si spostavano liberamente, non così i capitali, sottoposti a penetranti controlli statali fino all’Atto Unico Europeo del febbraio 1986, che si poneva l’obiettivo di “completare il mercato interno” attraverso la deregulation e le privatizzazioni (fissando le quattro libertà di circolazione: persone, merci, capitali e servizi), e all’entrata in vigore della direttiva sulla libera circolazione dei capitali nel 1988 che diedero inizio alla marcia verso il Trattato di Maastricht del 1992, per poi passare al “Patto di stabilità e crescita” del 1997 e alle sue successive varianti (“Fiscal Compact”, “Two Pack”, “Six Pack”), che hanno reso più stringenti e centralizzati i vincoli e le procedure intergovernative di coordinamento del Patto, e all’euro come moneta unica nel 2001. Accordi, decisioni e vincoli che insieme costituiscono i capisaldi del modo di regolazione neoliberista europeo che negli ultimi anni ha istituzionalizzato l’egemonia della Germania e del suo modello di capitalismo, attraverso la sua ideologia ordoliberista, sull’Unione Europea, e reso pressoché impossibile per gli Stati membri più in difficoltà di fare fronte alla crisi e stagnazione economica con il sostegno della domanda pubblica, contribuendo a determinare una strisciante divergenza all’interno dell’Europa e una crisi di legittimità dell’Unione Europea stessa.
Probabilmente il punto di svolta c’è stato a fine 1979 con l’istituzione del Sistema Monetario Europeo, antesignano dell’attuale Unione Monetaria. Dal punto di vista interno lo SME offrì l’ancoraggio ai processi deflazionistici che nel giro di breve tempo avrebbero portato al ridimensionamento e poi all’annullamento della forza del movimento dei lavoratori in tutti i Paesi europei. Dal punto di vista internazionale, il varo di un sistema di coordinamento monetario regionale per la Germania rappresentò – come ha osservato Marcello De Cecco – l’accantonamento alle velleità di competizione diretta con gli Stati Uniti per la leadership monetaria globale e al contempo significò per gli altri Paesi europei la convergenza verso il modello Bundesbank caratterizzato da moneta forte e bassa inflazione. Da fine anni ‘70 in poi, l’affermarsi del dogma dell’indipendenza delle banche centrali, in sinergia con il trasferimento di sovranità verso istituzioni sovranazionali come la Comunità Europea, ha rappresentato uno strumento di costruzione di uno spazio politico in cui le voci democratiche alternative e contestatrici del neoliberismo sono state rese del tutto ininfluenti.
Dopo gli anni ‘80, l’Unione Europea ha fatto un salto nel buio, adottando un’ambiziosa agenda del mercato unico – una sorta di “globalizzazione in miniatura” – che puntava a unificare le economie europee, indebolendo le politiche nazionali che intralciavano la libera circolazione non solo di beni, ma anche di servizi, persone e capitali. L’eliminazione delle barriere protettive significava promuovere economie di scala per le imprese spingendole a competere con i maggiori attori economici del mondo. Allo stesso tempo, questa evoluzione ha significato esporre i settori meno produttivi e competitivi a crescenti pressioni concorrenziali legate, oltreché alla necessità di introdurre nuove tecnologie, anche a quella di liquidare i diritti sociali passibili di ridurre la competitività (livelli salariali, accordi collettivi, coperture pensionistiche e protezioni sociali). A questo proposito, come non ricordare il rapporto Cecchini della Commissione europea (1988) che, come premio per il completamento del mercato unico interno previsto per il 1992, aveva promesso ai cittadini europei un aumento della prosperità dell’ordine del 5% del PIL dell’Unione Europea, una riduzione media del 6% dei prezzi dei beni di consumo, nonché milioni di nuovi posti di lavoro e un miglioramento delle finanze pubbliche del 2,2% del PIL. Il rapporto evidenziava anche come la non realizzazione del mercato unico sarebbe continuata a costare centinaia di migliaia di miliardi di lire ai cittadini europei sotto forma di spese superflue e di occasioni mancate.
L’euro è stato la logica prosecuzione di questa linea di pensiero e ha scatenato una sorta di processo di iper-globalizzazione su scala europea. L’unione economica e una moneta comune hanno offerto alle imprese la libertà di muoversi senza attrito oltre i confini degli Stati membri, contribuendo a integrare le catene di produzione su scala continentale. Ma, dopo la crisi finanziaria del 2007-08 e dopo il 2010 quando è esplosa la crisi dell’Eurozona, è stato stimato che, per far sì che i Paesi del Sud dell’Unione Europea (come la Grecia, l’Italia, il Portogallo, la Spagna e in parte la Francia) riconquistassero la competitività e riequilibrassero le loro bilance commerciali e le partite correnti, questi dovessero abbattere i salari del 20-30% rispetto ai loro partner commerciali. Invece di affrontare il problema attraverso una politica industriale attiva a livello europeo, Merkel e il suo ministro delle finanze Wolfgang Schäuble hanno trattato le economie strutturalmente in deficit della periferia europea come se il debito pubblico e i livelli salariali fossero il problema. La questione è stata trasformata in un giudizio essenzialmente di tipo morale, come se gli Stati periferici fossero degli “spendaccioni” che vivessero al di sopra delle loro possibilità e, in nome della competitività, la strategia perseguita è stata indirizzata verso una politica di austerità e di “svalutazione interna” del costo del lavoro.
In mancanza di politiche fiscali (ossia di meccanismi di redistribuzione) e di una politica industriale attiva a livello europeo (con un’industra europea che conta centinaia di migliaia di imprese e oltre 61 milioni di dipendenti), ed essendo stata finora in gran parte vietata quest’ultima forma di intervento a livello statale per la volontà di creare una concorrenza reale sul mercato europeo, mentre le imprese hanno goduto del diritto di acquistare o investire a loro piacimento in altri Paesi in base alle regole del libero mercato, i Paesi in crisi della zona euro non potendo più migliorare la loro competitività attraverso le politiche nazionali di sostegno a determinate aziende e il deprezzamento delle valute (la “svalutazione competitiva”), hanno potuto cercare di rimanere “attrattivi” solo riducendo il prelievo fiscale sulle imprese – facendo concorrenza ad altri Stati e minando la progressività dell’imposizione fiscale – e/o attraverso la cosiddetta “svalutazione interna”, che è l’equivalente contemporaneo della politica di deflazione applicata durante la Grande Depressione negli anni Venti e Trenta per difendere il sistema del gold standard. Non a caso, la dimensione e la durata del crollo economico nei Paesi dell’Eurozona maggiormente colpiti dalla crisi, quelli del Sud Europa, sono paragonabili e, in alcuni casi, anche più profondi rispetto a quanto accaduto durante la Grande Depressione. Purtroppo, l’applicazione di questa ricetta ricorda la favola del padrone che prova ad insegnare al proprio asino a non mangiare e che quando pensa di esserci riuscito, l’asino muore. Una strategia mercantilista export oriented che può funzionare temporaneamente in tempi di crescita della globalizzazione e mercati aperti, ma che comunque comporta la crisi del mercato interno (con il blocco dei consumi), la riduzione degli investimenti pubblici in infrastrutture, servizi e ricerca scientifica, l’aumento del debito pubblico. In ogni caso, c’è un limite alla “corsa verso il basso“, ossia alla compressione dei salari che può essere imposta ai lavoratori europei per far recuperare competitività alle imprese perché questi lavoratori devono sostenere maggiori costi di alloggio, istruzione, servizi medici e trasporti rispetto a quelli dei Paesi oggi concorrenti nell’economia globale. Senza contare che l’assenza di una politica industriale europea ha fatto perdere all’Europa il treno delle rivoluzioni tecnologiche degli ultimi due decenni (dall’intelligenza artificiale al 5G). L’Economist segnala che un decennio fa 10 delle 40 maggiori società quotate al mondo per valore di mercato avevano sede nell’UE, mentre ora sono solo 2 (al 32° e 36° posto). Inoltre, pochissime sono le startup europee leader nel mondo.
Il Trattato di Maastricht (così come gli accordi intergovernativi successivi) ha incluso principalmente parametri inflattivi e fiscali (massimali per deficit, debito e inflazione), i quali hanno condotto all’austerità, ad una progressiva riduzione dello stato sociale e all’introduzione di forme di governance neoliberiste in tutta Europa. “Svalutazioni interne” realizzate attraverso politiche salariali restrittive (riduzione dei salari reali e nominali), tagli alla spesa pubblica e successive ondate di riforme pensionistiche, miranti a ridurre i deficit dei sistemi previdenziali (aumento dell’età pensionabile minima, riduzione dell’ammontare delle pensioni, introduzione forzata di fondi previdenziali privati, etc.) sono divenute gradualmente la norma in tutti i Paesi dell’Unione Europea, anche se con gradazioni diverse.
Al contempo, le politiche del mercato comune europeo, dagli anni ‘90 hanno consentito ulteriori privatizzazioni per mezzo dell’apertura forzata dei mercati delle telecomunicazioni, dell’energia e degli appalti pubblici. La cosiddetta “Strategia di Lisbona”, lanciata nel 2000, mirava a fare dell’UE “l’economia della conoscenza più competitiva e dinamica al mondo, in grado di raggiungere la crescita economica insieme a migliori opportunità di impiego e maggiore coesione sociale”. Ma, già a metà a degli anni 2000, il suo insuccesso era ormai evidente, anche se alcuni Paesi, come la Germania, manifestavano una maggiore competitività, specialmente all’interno dell’Unione Europea. Poco o nulla di costruttivo si è fatto rispetto a quanto si era proclamato a Lisbona per rilanciare la competitività economica europea. I grandi Paesi industriali europei – Germania, Italia, Francia – sono rimasti inchiodati al modello industriale tradizionale, centrato soprattutto sull’automobile, che dal 2015 è rimasto intrappolato nello scandalo delle emissioni del gas di scarico dei motori diesel (dieselgate).
Negli anni ’70, gli europei avevano perso la loro posizione di leadership nel settore dell’elettronica di intrattenimento a favore di Paesi come il Giappone e la Corea del Sud. Da allora, questa perdita si è dimostrata apparentemente definitiva e questo ha contribuito all’incapacità dell’Europa di avere una presenza significativa nei nuovi campi della tecnologia delle telecomunicazioni, dell’elettronica dei computer (inclusi smartphone, tablet, etc.) e delle piattaforme del capitalismo digitale. Negli ultimi due decenni, per “migliorare la competitività”, invece di esplorare le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica e dell’economia della conoscenza, l’Europa ha preferito cercare di ammodernare i settori industriali tradizionali e di applicare sistematicamente un modello di precarizzazione del lavoro (le riforme Hartz in Germania, il Jobs Act in Italia, etc.) e di deflazione salariale.
Oggi, dopo quasi 20 anni di moneta unica, di “svalutazioni interne” (ovvero di schiacciamenti dei prezzi e salari) e di politiche di bilancio in linea con il “paradigma dell’austerity” ordoliberista, che presuppone che la crescita economica debba essere trainata dal settore privato e che a tal fine l’intervento pubblico interferisce con i meccanismi di “autoregolazione” del mercato (a meno che non si tratti di “salvare” il mercato), sappiamo bene che tutto quello che avviene a Bruxelles, a Strasburgo o a Francoforte ha un referente privilegiato, che è il mercato, per cui l’intervento dello Stato nell’economia è stato limitato per legge, la moneta unica è stata strenuamente difesa dalla BCE attraverso politiche monetarie “non convenzionali” iperespansive in funzione anticiclica (che ora, in presenza di una nuova possibile recessione, la Banca si è dichiarata pronta ad utilizzare di nuovo), mentre è stata dichiarata illegale la politica economica keynesiana, imponendo il pareggio di bilancio in costituzione.
In questi anni, le politiche dell’Unione Europea si sono essenzialmente basate su tre princìpi dichiaratamente neoliberisti, applicati in modo particolarmente rigido ed incisivo, che hanno alimentato le principali preoccupazioni della popolazione, riguardanti l’austerità, la perdita di sovranità e l’immigrazione, provocando contro-movimenti e manifestazioni di ostilità nei confronti del sistema europeo: la riduzione e privatizzazione dei servizi pubblici; il progressivo indebolimento del controllo democratico e della rappresentanza; la deregolamentazione dei fattori produttivi. Nel frattempo, il contesto competitivo globale è cambiato ed è diventato sempre più evidente che la continua riduzione della quota dei salari (ottenuta anche con le delocalizzazioni nei Paesi dell’Europa dell’Est) non è sufficiente per assicurare la competitività di un sistema industriale che è rimasto in larga parte concentrato su settori che nel nuovo capitalismo digitale globale sono ormai divenuti tradizionali.
Fin dai primi passi dell’Europa i motori dell’integrazione sono stati economici: il carbone e l’acciaio con la CECA, fondata nel 1950, due settori industriali che allora condizionavano in misura rilevante l’intero sviluppo economico, l’energia nucleare con l’Euratom nel 1957, il mercato comune (prima MEC e poi CEE), l’agricoltura. Adenauer, De Gasperi e Schuman erano politici troppo accorti per non capire che proprio da lì occorresse cominciare (promuovere una “fusione di interessi necessari all’instaurazione di una comunità economica”, come si legge nella Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950), ma solo per poi giungere ad una unione politica. Che finora non c’è mai stata e oggi un numero crescente di cittadini europei percepisce l’Unione Europea come un’istituzione che ha ben poco a che fare con i popoli e la democrazia, dominata com’è dai governi e da una oligarchia sovranazionale apparentemente lontana dalla vita reale delle persone comuni e composta da lobbisti delle imprese globali, economisti, programmatori, tecnocrati e burocrati (anche se la UE impiega meno persone di una città di medie dimensioni – 32 mila tra funzionari e dipendenti). Nata dichiaratamente per riconciliare gli europei tra di loro, seppellire i regimi autoritari ed evitare nuove guerre nell’area europea, manca ancora quasi del tutto di una democrazia basata sulla volontà dei cittadini e non solo sugli accordi che vengono assunti sulla base degli interessi dei governi e delle grandi imprese globali.
Nel Trattato di Lisbona (2009), l’Unione aveva indicato degli obiettivi politici fondamentali da perseguire in modo coerente: promozione di benessere diffuso per i cittadini, una crescita equilibrata e sostenibile, un’economia competitiva che assicurasse piena occupazione, coesione territoriale, progresso e giustizia sociale (intesa come equa e giusta distribuzione di diritti, opportunità e risorse). Ricordiamo che secondo l’articolo 2 (TUE), i valori su cui poggia la UE sono: dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani. Questi valori sono riconosciuti come condivisi da tutti gli Stati membri “in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”. Sono state anche previste una serie di norme e misure volte a promuovere l’occupazione e l’inclusione e ad arricchire i sistemi nazionali di protezione con politiche di “investimento sociale” (politiche per l’infanzia, per la conciliazione, per l’istruzione e la formazione, per l’impiego, etc.). La Commissione Europea ha ribadito di recente l’impegno dell’Unione a perseguire il Pilastro europeo dei diritti sociali – una serie di princìpi e diritti fondamentali per sostenere equi e ben funzionanti mercati del lavoro e sistemi di welfare; 20 princìpi chiave strutturati intorno a tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro (diritto alla formazione e all’apprendimento permanente, tutela del lavoratore e sostegno attivo all’occupazione), condizioni di lavoro eque (giusta retribuzione, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, dialogo sociale e partecipazione dei lavoratori), protezione e inclusione sociale (sussidi di disoccupazione, reddito minimo, pensioni adeguate a una vita dignitosa, assistenza sanitaria, etc.) -, che devono servire da quadro di riferimento per l’occupazione e la politica sociale a livello nazionale ed europeo, stabilendo un’ambiziosa agenda per realizzare economie più performanti e società più eque e resilienti, con l’obiettivo di promuovere un rinnovato processo di convergenza verso migliori condizioni di lavoro e di vita in tutta Europa.
Ma, questa serie di princìpi, diritti, misure e agende finora sono stati implementati in modi e con risorse insufficienti per contrastare gli effetti sociali dell’applicazione dei princìpi neoliberisti, della globalizzazione e della sua crisi, per cui dal 2007-2008 ad oggi sono cresciute non solo povertà, disuguaglianza e disoccupazione, ma anche i divari fra generazioni, fra profili occupazionali, fra insiders e outsiders all’interno di ciascun Paese. Inoltre, si è creata anche una Europa con differenti velocità, con una polarizzazione molto marcata tra Paesi del Nord e del Sud Europa, invertendo un trend storico di convergenza verso livelli di vita più elevati, mentre si è apparentemente interrotto il percorso di avvicinamento fra Europa occidentale e orientale. In passato, la convergenza verso l’alto è avvenuta quasi automaticamente attraverso il mercato interno e il sostegno da fondi dell’UE, tanto che la Banca Mondiale aveva definito l’UE come “macchina di convergenza”. Nell’ultimo decennio, gli effetti della crisi e stagnazione economica, insieme agli effetti delle riforme strutturali (realizzate o mancate) e alla stagnazione del progetto politico europeo, hanno rallentato notevolmente e arrestato la convergenza e generato disaffezione, delusione, sfiducia e finanche antipatia e repulsione verso l’Unione Europea. Hanno via via alimentato la nascita e la crescita di movimenti politici antieuropei di destra e di sinistra, in tutti i 28 Paesi dell’Unione che, come nel caso Brexit, propongono l’uscita dei rispettivi Stati o quanto meno il ristabilimento delle frontiere nazionali, la supremazia dei diritti nazionali su quelli comunitari e la restaurazione della sovranità monetaria nazionale.
Sul piano economico, l’Unione Europea si trova imprigionata in una trappola, spaccata com’è tra un gruppo di Paesi apparentemente “virtuosi” (Germania, Olanda, Finlandia, Austria, Polonia, Ungheria) in grado di rispettare i parametri e regole fissati dal Trattato di Maastricht e dai successivi patti sul livello consentito del debito e del deficit, e un gruppo di Paesi (Grecia, Italia, Spagna, Portogallo e Francia) che si dimostrano incapaci di rispettarli e che avrebbero bisogno di un allentamento dei vincoli (di quell’insieme di regole sui bilanci pubblici che prevede il pareggio strutturale di bilancio e l’impegno a ridurre la parte del debito pubblico eccedente il 60% del PIL) e, quindi, di essere autorizzati ad indebitarsi ancora di più, per irrobustire la loro crescita. Questi ultimi, secondo le indicazioni della Commissione, dovrebbero ulteriormente sottoporsi a “svalutazioni interne”, ossia ridurre salari e spesa pubblica soprattutto in materia di previdenza, sanità e altri servizi erogati dallo Stato, ma questo sarebbe dannoso per la crescita, l’occupazione, le condizioni di vita delle famiglie e la riduzione del debito pubblico, facendo crescere il malcontento dei cittadini verso i governi e soprattutto il loro risentimento verso l’Unione, favorendo i contro-movimenti e le forze populiste nazionaliste di opposizione. Nell’interesse della costruzione europea, quindi, i governi dei Paesi che hanno i conti in ordine dovrebbero adottare una linea più flessibile, comprensiva e conciliante, ma in questo modo correrebbero il rischio di diventare anch’essi bersaglio dei loro rispettivi contro-movimenti populisti nazionalisti di opposizione. Nel 2015 il governo Renzi ottenne la “flessibilità” di bilancio (circa 40 miliardi di euro) dalla Commissione Europea sostenendo che aveva bisogno di fare deficit per contrastare l’ascesa del Movimento 5 Stelle e della Lega. Una decisione che ha contribuito ad irritare l’opinione pubblica tedesca e ad alimentare la propaganda del partito di estrema destra (AfD) contro il governo Merkel. D’altra parte, poco prima la stessa irritazione degli elettori tedeschi aveva spinto il governo Merkel a imporre un rigore draconiano sulla Grecia, facendo divampare un rivolta popolare in Grecia nel 2015.
La pandemia da CoVid-19 e i nuovi orientamenti nell’ambito dell’Unione Europea
Nel corso del 2020-21, a partire dalla fine di gennaio 2020, la pandemia da CoVid-19, con i suoi drammatici impatti su salute, economia, società e politica, soprattutto nel secondo trimestre del 20204, ha costretto l’establishment politico europeo a rivedere drasticamente le sue posizioni in materia di intervento dell’Unione Europea in campo economico e sociale.
In tutta Europa, durante la pandemia la vita pubblica è stata fermata, ma il dibattito pubblico ha accelerato, investendo moltissimi temi critici: i compromessi tra un’economia in rovina e la salute pubblica, le virtù relative dei sistemi sanitari centralizzati o regionalizzati/territorializzati, le fragilità della globalizzazione, il futuro dell’Unione Europea, le disuguaglianze socio-economiche (tra coloro con lavoro e reddito garantito e coloro privi di sicurezza, alla mercé dei “capricci del mercato”), i sistemi di reddito universale di base, il populismo, il nazionalismo, il vantaggio intrinseco dell’autoritarismo nella gestione dello stato di emergenza.
La diffusione della pandemia ha creato una situazione di emergenza che ha reso necessario un tempestivo intervento pubblico per sostenere il settore sanitario e l’economia nel suo complesso. I cittadini si sono aggrappati allo Stato come ad un salvagente in un mare in tempesta. Politici e Stati sono stati costretti a compiere una torsione violenta, ad agire in modi che solo poche settimane prima sembravano impensabili. Come ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron il 12 marzo 2020, la pandemia ha rivelato che ci sono beni e servizi che devono essere collocati al di fuori delle leggi del mercato. L’ortodossia fiscale, la tradizionale politica neoliberista di austerità, è stata abbandonata, almeno temporaneamente, per praticare un attivismo fiscale che ha fatto crescere il ruolo economico dello Stato con una sorta di “keynesismo di guerra”. Attraverso misure di spesa d’emergenza in deficit, garanzie, prestiti, aiuti finanziari ed erogazioni a fondo perduto da parte dello Stato, blocco dei licenziamenti, nazionalizzazioni (tese ad evitare la bancarotta di alcune grandi aziende) e norme anti-scalate ostili di aziende nazionali considerate strategiche, si è cercato di compensare l’improvvisa e colossale crisi nell’attività economica, tentando di salvare e tutelare imprese e posti di lavoro.
La Banca Centrale Europea (BCE) e gli Stati non hanno mostrato incertezze (whatever it takes) quando si è trattato di dispensare risorse senza limiti per la “salvezza dell’economia”, mentre pochi giorni prima della pandemia opponevano, a tutte le richieste di aumento della forza lavoro degli ospedali e del numero di letti nei reparti di emergenza, il rispetto ossessivo dei vincoli di bilancio e dei limiti al debito pubblico. Governi e Stati, sostenuti dall’intervento monetario della BCE5, hanno tutelato generosamente banche, investitori nei mercati azionari e imprese in un battito di ciglia, quando sul fronte della salute, per decenni hanno sottofinanziato e privatizzato il sistema sanitario.
Con interi grandi Paesi – Italia e Spagna – bloccati in quarantena e con la strategia “ognuno per sé” che ha inizialmente prevalso sulla solidarietà, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha assicurato che “faremo tutto il necessario per sostenere l’economia europea“. Ogni spesa necessaria per la risposta alla pandemia è stata esclusa per definizione dal calcolo del deficit strutturale. In più le regole sugli aiuti di Stato sono state congelate per consentire ai Paesi colpiti dalla pandemia di sospendere i versamenti fiscali, sostenere la liquidità delle imprese, compensare i settori fermi e garantire ammortizzatori sociali ai lavoratori. La Commissione e l’Ecofin (il coordinamento dei ministri economici) hanno deciso la sospensione tout court dei vincoli di bilancio, applicando la “clausola di salvaguardia” (general escape clause) del Patto di Stabilità, prevista per casi eccezionali, consentendo ai governi di “pompare nel sistema denaro finché serve“. Un passo storico che ha congelato almeno temporaneamente (almeno sino al 1° gennaio 2023) il vero architrave delle politiche neoliberiste di austerità seguite nell’Unione Europea.
Si è avuto un cambiamento di orientamento politico-economico – caratterizzato da molti politici ed osservatori come un “momento hamiltoniano“6 – che nell’ambito dell’Unione Europea ha prodotto il programma SURE e il Next Generation UE, e che ha anche rimesso al centro della politica il Pilastro europeo dei diritti sociali, portando la Commissione ad elaborare numerose direttive e un Piano d’Azione che è stato discusso nel vertice sociale di Porto del 7 maggio 2021.
La pandemia ha dunque aperto un possibile processo di revisione delle regole della governance economica e sociale e del ruolo della Banca Centrale Europea, che dovrebbe essere diretto a superare il dogma dell’austerità che, dalla firma del Trattato di Maastricht, ha fatto da perno alle politiche implementate nell’Unione Europea in campo sociale ed economico.
E’ nel quadro dei nuovo scenario politico-culturale revisionista ed interventista indotto dalla crisi determinata dalla pandemia da CoVid-19, che Commissione e Parlamento Europeo sono tornati ad occuparsi intensamente del cosiddetto Pilastro europeo dei diritti sociali che era stato approvato dai capi di governo (in via inter-istituzionale e, quindi, privo di valore normativo) al vertice di novembre 2017 a Göteborg, con la proclamazione del Pilastro (senza però aver fissato una dotazione di strumenti normativi e finanziari per realizzarlo, né indicato chiaramente chi fosse tenuto a garantirlo, se cioè l’UE o gli Stati nazionali). Il Pilastro identifica 20 princìpi e diritti essenziali per mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi e ben funzionanti nell’Europa del XXI secolo. La struttura del pilastro ruota attorno a tre categorie: 1) pari opportunità e accesso al mercato del lavoro (4 princìpi); 2) condizioni di lavoro eque (6 princìpi); 3) protezione sociale e inclusione (10 princìpi).
Seppure con qualche resistenza, sta acquisendo consenso l’idea che per contrastare la crisi e stagnazione economica, il declassamento di interi settori della popolazione e le disuguaglianze crescenti che stanno minacciando le democrazie rappresentative dei Paesi europei, sia indispensabile rilanciare a livello di Unione Europea:
- una crescita economica inclusiva e sostenibile che vada oltre le politiche di consolidamento fiscale e lo sviluppo basato su esportazioni, bassi salari e avanzi commerciali seguite negli ultimi tre decenni;
- comprendere un rilancio del mercato interno attraverso la green economy, come capitalismo che incorpora il limite ambientale nel suo processo di accumulazione, più elevati salari, un’occupazione più qualificata e stabile;
- l’adeguamento e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture realizzate dal dopoguerra in poi;
- la messa in sicurezza e manutenzione del territorio, gli alloggi popolari, il welfare, la modernizzazione e il rafforzamento dei sistemi sanitari;
- un rafforzamento dei sistemi scolastici, della formazione e della produzione e diffusione della cultura che restano gli strumenti più validi per promuovere l’occupazione, far ripartire l’ascensore sociale, “educare il popolo” e, quindi, preparare cittadini responsabili, resilienti e consapevoli.
La delusione che si è percepita verso l’UE da parte di molti cittadini europei in questi ultimi anni, è stata data dalla grande distanza tra le promesse (ad esempio, quella della “Europa sociale” in grado di proteggere i deboli e costruire la solidarietà, promessa da Jacques Delors negli anni ’90) e quanto viene realizzato. Passare dalle parole ai fatti con alcune azioni concrete significa investire nell’Europa sociale. Questo è particolarmente importante in un momento storico in cui la pandemia ha mostrato tutte le debolezze e inadeguatezze dei sistemi socio-sanitari nazionali, si registra una tendenza negativa sulle proiezioni demografiche (vedi denatalità e invecchiamento della popolazione) ed è necessario fronteggiare radicali mutamenti nel mercato del lavoro. Per essere all’altezza della sfida occorre prospettare la creazione di un sistema unico di welfare, un social compact, un patto sociale e istituzionale in grado di intervenire sui bisogni più urgenti delle persone a cominciare da un’assicurazione europea (non temporanea, come il SURE) contro la disoccupazione e un maggior sostegno all’occupazione femminile.
La sfida dei prossimi anni dovrebbe essere quella di usare in modo creativo il potere politico per bilanciare domande di protezione sociale e imperativi economici. Il Trattato di Lisbona colloca la politica sociale fra le competenze concorrenti: gli Stati membri possono legiferare autonomamente nella misura in cui l’Unione non esercita le proprie prerogative. Occorre riequilibrare la dimensione economica e la dimensione sociale, riconoscendo loro pari dignità come missioni generali dell’Unione e allineandone, ove ragionevole, le modalità di governance e le procedure decisionali. Occorre uscire da quell’ambito ristretto in cui le politiche sociali sono state finora relegate, poiché, erroneamente, si continua a considerarle quell’insieme di servizi e interventi rivolti a uno strato “marginale” della popolazione, alla sola area dell’esclusione e del disagio, e pertanto qualificate meramente come voce di spesa (alla quale si preferisce anteporre politiche di risanamento economico o di investimenti produttivi o in infrastrutture), più che di investimento.
Le politiche sociali sono, invece, investimenti per lo sviluppo e la competitività, in quanto creano, al pari della ricerca scientifica o delle politiche educative e formative, i presupposti al progresso sociale e civile di un Paese. Come le altre politiche, infatti, quelle sociali sono generatrici di sviluppo economico, potenziale di impresa e di incremento della base occupazionale. In particolare, i servizi sociali producono saperi, attivano essi stessi l’economia e l’occupazione, rendono fruibili risorse altrimenti non utilizzabili e sono un contesto e uno strumento di governance territoriale.
Investire sulla persona, sulle sue capacità, sulla sua autonomia, sulla capacità di autorganizzarsi, significa produrre ricchezza economica e sociale indispensabile allo sviluppo (le “dimensioni sociali della competitività”). Non solo lo sviluppo economico dei Paesi e dell’Unione, ma anche il necessario rinnovamento del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini e lo stretto legame di solidarietà, sicurezza e legalità, si realizzano con l’affermazione dei diritti fondamentali e, quindi, di politiche orientate alla riduzione delle disuguaglianze, che garantiscano diritti e tutele e incrementino la qualità sociale, la capacità cooperativa e il grado di coesione.
A dicembre 2020, nell’Unione Europea si contavano 16 milioni di persone senza lavoro e la disoccupazione giovanile era pari al 17,8%, molto più elevata della disoccupazione generale. I lavoratori scarsamente qualificati, scarsamente retribuiti e a tempo determinato sono stati i primi a essere licenziati a causa della pandemia di CoVid-19. Anche la partecipazione dei migranti al mercato del lavoro ha risentito in modo sproporzionato della pandemia. Sebbene le competenze siano essenziali per preparare i lavoratori ai nuovi posti di lavoro verdi e digitali e contribuiscano a proteggerli dalla disoccupazione, meno del 40% degli adulti partecipa annualmente ad attività formative di qualsiasi tipo e sono ancora troppi i giovani con competenze scarse o che non raggiungono il livello di istruzione secondaria superiore. Le donne, che nel 2018 guadagnavano ancora in media il 14% in meno degli uomini, continuano a farsi carico delle responsabilità di cura familiare e hanno difficoltà a entrare e rimanere nel mercato del lavoro, con conseguenze che si ripercuotono anche a livello pensionistico. Prima della pandemia, 91 milioni di persone erano a rischio di povertà o di esclusione sociale e il 22,2 % dei bambini viveva in famiglie povere. Si stima che siano circa 700 mila le persone che dormono per strada in tutta Europa ogni notte.
La Commissione europea nel 2021
Gli anni finali della Commissione Juncker e soprattutto l’anno e mezzo della nuova Commissione von der Leyen, invece, hanno visto un proliferare di iniziative legislative tese a potenziare la dimensione sociale della UE, con un esplicito richiamo alle categorie e ai princìpi definiti nel Pilastro europeo dei diritti sociali. Nel 2019 si è concluso il processo di generalizzazione della misura del reddito minimo garantito (uno dei diritti sanciti nel Pilastro sociale e nella Carta di Nizza) che oggi, sia pure in forme molto dissimili ed in molti casi inadeguate, è un istituto presente in tutti i 27 Stati UE, quasi a suggellare la tutela della dignità delle persone intesa come una tradizione costituzionale comune. Sempre nel 2019 si è completata la procedura della ricezione della nuova direttiva sul distacco transnazionale che ha regolamentato in modo molto incisivo l’insidioso fenomeno del distacco a catena, allargando di molto il campo di applicazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori distaccati e non. Su questo tema, una recente sentenza della Corte di Giustizia UE ha valorizzato tale direttiva, alla luce del principio della proibizione di ogni forma di “frode alla legge comunitaria”: giurisprudenza e legislatore UE stanno demolendo alcuni santuari di social dumping tra Stati.
La Commissione von der Leyen ha già presentato una serie di azioni derivanti dal Pilastro su cui può richiedere l’impegno degli Stati nazionali, quali l’agenda per le competenze per l’Europa (principio 1), la strategia per la parità di genere (principio 2), una direttiva sulla trasparenza retributiva (principio 2), il piano d’azione dell’UE contro il razzismo (principio 3), il pacchetto a sostegno dell’occupazione giovanile (principio 4) e la proposta di direttiva relativa a salari minimi adeguati (principio 6), una nuova strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (principio 17). Sempre nel quadro del Pilastro, sono state già approvate diverse altre iniziative, tra cui: la direttiva relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, la direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’UE; il regolamento per l’istituzione di un’Autorità europea del lavoro; la direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Nel 2021 è inoltre previsto il varo di altre azioni della Commissione, tra cui la garanzia europea per l’infanzia (principio 11), un nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (principio 10), e una proposta di direttiva per migliorare le condizioni di lavoro delle persone che lavorano attraverso le piattaforme digitali (princìpi 5 e 12) presentata il 25 febbraio e un Piano d’Azione per l’economia sociale. Il 27 gennaio è stato reso pubblico il libro verde sull’invecchiamento.
Il 4 marzo è stato presentato il Piano d’Azione per l’attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali da Nicolas Schmit (Lussemburgo), Commissario per il Lavoro e gli Affari Sociali che lavora sotto la guida del Vicepresidente esecutivo per un’economia al servizio delle persone, Valdis Dombrovskis, e a stretto contatto con gli Stati membri, dovendo rispettare il principio di sussidiarietà. L’effettiva attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali dipende in larga misura dalla determinazione e dall’azione degli Stati membri, che sono i principali responsabili in tema di occupazione, competenze e politiche sociali. Le azioni a livello dell’UE possono integrare le azioni nazionali e questo Piano d’Azione costituisce il contributo della Commissione all’attuazione dei princìpi del Pilastro sociale, in linea con gli inviti dei leader europei e del Parlamento europeo.7
Nel Piano d’Azione la Commissione ha proposto tre obiettivi principali dell’UE da raggiungere entro la fine di questo decennio nei settori dell’occupazione, delle competenze e della protezione sociale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Insieme a quanto sancito nei princìpi del Pilastro, al sostegno finanziario del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 e al programma Next Generation EU, gli obiettivi dovranno guidare gli sforzi congiunti verso un’Europa sociale forte e il raggiungimento di un impatto sostenibile. Gli obiettivi fissati sono i seguenti:
- almeno il 78% della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni dovrebbe avere un lavoro entro il 2030. Con un tasso di occupazione nell’UE che nel 2019 raggiungeva il 73,1%, l’obiettivo relativo al tasso di occupazione di Europa 2020 del 75% è stato quasi raggiunto. Nonostante gli sforzi dell’UE, la crisi COVID-19 ha arrestato l’andamento positivo in materia di occupazione degli ultimi 6 anni, con un tasso di occupazione pari al 78,3% per gli uomini e al 66,6% per le donne nel terzo trimestre del 2020. Fissando un nuovo obiettivo principale per il 2030, l’UE ribadisce il suo impegno a favore di un tasso di occupazione alto e inclusivo. Per raggiungere questo traguardo globale, l’Europa deve puntare a:
- dimezzare il divario di genere a livello occupazionale rispetto al 2019. Ciò sarà di fondamentale importanza per compiere progressi in materia di parità di genere e conseguire l’obiettivo occupazionale per l’intera popolazione in età lavorativa;
- aumentare l’offerta di servizi formali di educazione e cura della prima infanzia (ECEC), contribuendo in tal modo a una migliore conciliazione tra vita professionale e vita privata e favorendo una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- ridurre il tasso di giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) di età compresa tra i 15 e i 29 anni dal 12,6 % (2019) al 9 %, migliorando in particolare le loro prospettive occupazionali.
- almeno il 60% di tutti gli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione. Nel contesto della ripresa e della duplice transizione verde e digitale, aumentare al 60% la partecipazione degli adulti alla formazione è fondamentale per favorire l’occupabilità, stimolare l’innovazione, garantire l’equità sociale e colmare il divario nel campo delle competenze digitali. Tuttavia fino al 2016 solo il 37% degli adulti partecipava ogni anno ad attività di apprendimento. Per gli adulti scarsamente qualificati tale tasso raggiungeva solo il 18%. In particolare:
- almeno l’80% delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni dovrebbe possedere competenze digitali di base, che sono una condizione preliminare per l’inclusione e la partecipazione al mercato del lavoro e alla società in un’Europa digitalmente trasformata;
- l’abbandono scolastico precoce dovrebbe essere ulteriormente ridotto e la partecipazione all’istruzione secondaria superiore dovrebbe essere aumentata.
- Il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale dovrebbe essere ridotto di almeno 15 milioni entro il 2030. Secondo i dati ufficiali, negli ultimi dieci anni la povertà e l’esclusione sociale nell’UE sono diminuite. Nel 2019 circa 91 milioni di persone (di cui 17,9 milioni erano minori di età compresa tra 0 e 17 anni) erano a rischio di povertà o di esclusione sociale nell’UE, quasi 12 milioni in meno rispetto al 2008 e circa 17 milioni in meno rispetto al picco raggiunto nel 2012. Tuttavia l’ambizioso obiettivo sociale di Europa 2020, ossia una riduzione di 20 milioni di persone, non è stato raggiunto. Si prevede che la pandemia di CoVid-19 peggiorerà la situazione, aumentando l’insicurezza finanziaria, la povertà e la disparità di reddito nel breve termine. Dei 15 milioni di persone da sottrarre allo stato di povertà o di esclusione sociale, almeno 5 milioni dovrebbero essere bambini. L’attenzione rivolta ai bambini consentirà non solo di offrire loro l’accesso a nuove opportunità, ma contribuirà anche a spezzare il circolo vizioso intergenerazionale della povertà, evitando che diventino adulti a rischio di povertà o di esclusione sociale con conseguenti effetti sistemici a lungo termine.
Nelle intenzioni della Commissione, la realizzazione degli obiettivi del Piano d’Azione per l’attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali è un impegno politico e una responsabilità che condividono le istituzioni dell’UE, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali e la società civile, tutti chiamati a svolgere un ruolo in linea con le rispettive competenze. La Commissione sostiene di avere l’intenzione di sostenere questo sforzo con tutti gli strumenti disponibili: sostegno finanziario attraverso vari fondi dell’UE per investire in una ripresa equa e nella duplice transizione verde e digitale; promuovendo l’impegno di tutti gli attori; fornendo orientamenti e coordinamento delle politiche economiche e sociali nazionali attraverso il semestre europeo; attuando la legislazione dell’UE; sfruttando il suo ruolo di leader globale in campo economico.
A questo proposito, secondo la Commissione, gli Stati membri dovrebbero utilizzare appieno i fondi senza precedenti che l’UE ha messo a disposizione per sostenere le riforme e gli investimenti in linea con il Pilastro europeo dei diritti sociali. Il bilancio a lungo termine dell’UE per il periodo 2021-2027, unitamente allo strumento per la ripresa Next Generation EU, è il più grande pacchetto di incentivi mai finanziato dal bilancio dell’UE. Un totale di 1.800 miliardi di euro (di cui 88 per il FSE+) che dovrebbe aiutare l’Europa a riprendersi dalla crisi CoVid-19 e a diventare più verde, più digitale e socialmente giusta.
Contestualmente alla presentazione del Piano d’Azione, Schmit ha presentato una raccomandazione relativa a un sostegno attivo all’occupazione (EASE), quale azione concreta nel quadro del principio 4 del pilastro, tramite la quale fornisce agli Stati membri orientamenti concreti sulle misure strategiche, sostenute dalle opportunità di finanziamento dell’UE, per passare gradualmente dalle misure di emergenza adottate per mantenere i posti di lavoro durante la crisi in corso alle nuove misure necessarie per una ripresa che sia fonte di occupazione. Questa raccomandazione promuove la creazione di posti di lavoro e le transizioni professionali dai settori in declino a quelli in espansione, in particolare i settori verde e digitale. Le nuove misure degli Stati nazionali dovrebbero prevedere tre elementi: 1) incentivi all’assunzione e sostegno all’imprenditorialità; 2) opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione; 3) maggiore sostegno da parte dei servizi per l’impiego, comprendente consulenza, orientamento e mentoring, valutazione e convalida delle competenze, assistenza alla ricerca lavoro. I fondi UE, tra cui il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il FSE+, sono disponibili per aiutare gli Stati membri a finanziare le loro misure EASE.
Il vertice sociale a Porto il 7 maggio 2021, organizzato dal primo ministro portoghese António Costa, presiedente di turno del Consiglio UE nel primo semestre 2021, e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, è stato incentrato sulle modalità atte a rafforzare la dimensione sociale dell’Europa per far fronte alle sfide connesse all’esigenza di una ripresa equa, inclusiva e resiliente e alla transizione verde e digitale. Il vertice ha rappresentato un’opportunità per mobilitare le forze – capi di Stato o di governo dell’UE, istituzioni dell’UE, parti sociali e altre parti interessate – al fine di rinnovare, al più alto livello politico, l’impegno relativo all’attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali. Il Piano d’Azione sul Pilastro è stato il contributo della Commissione al vertice sociale di Porto.
Si tratta ora di convincere gli scettici che ritengono che il Pilastro sociale resterà solo una buona intenzione fino a quando non si stabiliranno nel Trattato le competenze esclusive degli Stati membri e quelle esclusive dell’Unione. I diritti sociali hanno un costo in termini di intervento pubblico, per cui bisogna stabilire in modo chiaro le politiche che si devono fare a livello di UE e con quali risorse autonome e quali politiche devono fare gli Stati con le risorse dei loro bilanci. Da questo punto di vista, per dare un contenuto concreto al Pilastro dei diritti sociali sarebbe necessaria una riforma dell’architettura istituzionale.
Le resistenze a questo tipo di percorso ci sono. Alla vigilia del vertice di Porto, 11 Paesi membri (alcuni con sistemi pubblici di welfare robusti, altri piuttosto gracili) – Austria, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Olanda e Svezia – hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui avvertono Lisbona – e la Commissione di Bruxelles – di rispettare l’autorità nazionale sulla definizione delle politiche in settori come il lavoro e l’occupazione, le pensioni, l’istruzione e l’assistenza all’infanzia. “Qualsiasi iniziativa dell’UE in questi settori dovrebbe essere in linea con i princìpi di sussidiarietà e proporzionalità e necessita di un’attenta considerazione di diversi punti di partenza nazionali, sfide e assetti istituzionali. La definizione di obiettivi principali a livello di UE potrebbe aiutare a guidare i dibattiti, le politiche e le riforme.” Alcuni di questi Stati sono sinceramente preoccupati di salvaguardare sistemi di welfare pubblici relativamente efficienti che sono stati costruiti in decenni di politiche socialdemocratiche. Temono che un protagonismo della Commissione possa diventare una sorta di cavallo di Troia utilizzato per imporre standard inferiori rispetto a quelli esistenti a livello nazionale, contribuendo quindi ad erodere legittimazione, consenso politico e risorse finanziarie ai rispettivi sistemi pubblici di welfare. Stampa PDF
- I salari medi sono ottenuti dividendo la massa salariale nazionale per il numero di lavoratori nell’economia totale, moltiplicato poi per il rapporto tra ore settimanali di lavoro per i lavoratori a tempo pieno e ore settimanali di tutti i lavoratori.[]
- Gli Stati hanno cercato di tenere in coma farmacologico le economie (con espedienti di natura monetaria e fiscale) in attesa che si ricreassero le condizioni sanitarie per farle ripartire e sono arrivati a pagare fino al 60% dei salari dei lavoratori che le aziende avevano sospeso a zero ore senza licenziarli (si stima che questi programmi di sostegno abbiano raggiunto almeno 54 milioni di lavoratori nell’Unione Europea). Hanno dovuto aiutare i salariati, i lavoratori autonomi, i contadini, le famiglie e le imprese allo scopo di evitare l’implosione del sistema ed impedire che la pandemia causasse più poveri che morti, provocando una grande esplosione di rabbia popolare. Questo anche se coloro che avevano un impiego intellettuale ben remunerato (colletti bianchi) spesso hanno dovuto affrontare solo i fastidi del telelavoro da casa (ridefinito smart-working), mentre i lavoratori meno pagati e tutelati, che lavoravano in settori considerati “essenziali”, hanno conservato il loro impiego spesso a rischio della vita, come le badanti e gli operatori sanitari, ma anche i magazzinieri, i camionisti, gli addetti della grande distribuzione, i lavoratori delle filiere agro-alimentari, gli addetti alle pulizie. A loro è stato chiesto di sacrificarsi in nome del primato dell’economia.[]
- Uno studio su Lavoro e capitale negli anni della crisi: l’Italia nel contesto europeo della Fondazione Di Vittorio (CGIL) aveva già certificato gli effetti delle “svalutazioni del lavoro” avvenute in Italia tra il 2001 e il 2017: nell’intero periodo c’è stata una sostanziale stazionarietà dei salari, mentre dal 2010 al 2017, a prezzi costanti, si sono ristretti di circa mille euro (il 3,5%), mentre in Germania e Francia, seppure di poco, sono saliti. Se nel 2010 la retribuzione media lorda in Italia era di 30,272 euro (in Germania era 35.825 e in Francia 35.724), nel 2017 è scesa a 29.214 (in Germania è salita a 39.446 e in Francia a 37.622). Un milione in meno di posti stabili, moderazione dei contratti di lavoro (con una crescente presenza dei cosiddetti “contratti pirata”), ma anche part-time involontario (cresciuto del 131% dal 2008, da 1,195 milioni a 2,757), lavori discontinui e una riduzione dei dirigenti e dei lavoratori ad elevata qualificazione, hanno consentito la deflazione salariale. Su 15 milioni di lavoratori dipendenti, relativi al solo settore privato, ben 12 milioni avevano una retribuzione lorda sotto i 20 mila euro, di questi circa 4,2 milioni erano sotto i 10 mila euro annui lordi. Si trattava di working poors, soprattutto giovani e donne residenti al Sud (in Calabria sono il 45%, in Sicilia, Puglia e Campania il 40%. Lavoravano soprattutto tra hotel e ristoranti, per attività sportive e di intrattenimento, con contratti di apprendistato, stagionali, part-time e a tempo determinato. Queste risultanze sulle dinamiche salariali e occupazionali sono state confermate da un successivo studio di Nicolò Giangrande pubblicato nella collana Working Paper della Fondazione Di Vittorio nel 2020. Dal quadro presentato, l’Italia, in divergenza rispetto all’Eurozona, si caratterizzava per una stagnazione salariale di lungo periodo e da una maggiore presenza delle professioni meno qualificate. Infine, si segnala il libro di Fana M. e Fana S., Basta salari da fame! (Editori Laterza, Roma-Bari, 2019) che denunciava il fatto che in Italia si guadagnava meno di trent’anni fa, a parità di professione, di livello di istruzione, di carriera. Una condizione che valeva per tutti, tranne per quella minoranza che sta in alto. I Fana sostenevano che il mercato del lavoro era ormai una giungla con la sola certezza di stipendi bassi e precari; paghe da fame per un lavoro povero, e auspicavano una ripresa della lotta salariale.[]
- Nel secondo trimestre del 2020, la pandemia ha portato, almeno temporaneamente, alla chiusura dei confini, al congelamento delle economie (con un enorme aumento della liquidità e un crollo verticale di investimenti e consumi), alla sospensione nella bolla digitale delle vite quotidiane e delle abitudini di miliardi di persone (condannando alcuni milioni alla morte per malattia e fame), al blocco del ritmo della crescita della globalizzazione economica (commercio, catene del valore, investimenti diretti esteri, flussi finanziari, migrazioni, etc.), all’emersione di una profonda crisi antropologica (sociale, economica, politica e culturale) dei ceti medi, e forse a spegnere per sempre la speranza nella modernità e la fede del progresso liberale che il domani può essere progettato per essere migliore di oggi. []
- Nella notte del 18 marzo 2020, la Banca Centrale Europea – sola istituzione sovranazionale federale con un reale potere di intervento paneuropeo, anche se limitato alla politica monetaria – ha messo in campo un nuovo programma di acquisto di titoli del settore pubblico (compreso quelli del debito greco) e privato con una dotazione complessiva di 750 miliardi di euro, potenziando il quantitative easing, già in atto da settembre 2019. Gli acquisti nell’ambito di questo nuovo Programma di Acquisto di Emergenza Pandemica (PEPP) saranno condotti almeno fino a giugno 2021 “e in ogni caso finché non giudicherà la fase di crisi da coronavirus superata”, e includono tutte le categorie di attività ammissibili nell’ambito del programma di acquisto esistente, ma permette di superare il 33% di acquisti sulle emissioni di un singolo Paese e la clausola che prevede acquisti per ciascun Paese proporzionati alla quota nel capitale della BCE (la cosiddetta capital key), con l’obiettivo di contenere gli spreads tra i Paesi dell’Eurozona. Una deroga che in parte compensa il fatto che alla BCE è vietato acquistare direttamente il debito di nuova emissione di un Paese membro (lo deve acquistare da intermediari sul mercato secondario). Il programma mira a contrastare “i gravi rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e le prospettive per l’area dell’euro rappresentate dall’epidemia e dalla crescente diffusione del coronavirus.” “Tempi straordinari richiedono un’azione straordinaria. Non ci sono limiti al nostro impegno nei confronti dell’euro. Come parte del nostro mandato, siamo determinati ad utilizzare tutto il potenziale dei nostri strumenti.” ha scritto Christine Lagarde su Twitter. Il “there are no limits” era quanto richiesto dagli operatori dei mercati e dai governi, simbolicamente simile al “whatever it takes” (qualsiasi cosa necessaria) pronunciato dal predecessore Mario Draghi nella crisi dell’euro del 2012. La BCE, attraverso la gestione del tasso di interesse, ha anche deciso di pagare le banche per prelevare denaro (di fatto un helicopter money per le banche). Considerati i programmi già in corso, la BCE ha pompato 1,1 trilioni di euro (pari al 6% del valore del PIL dell’Eurozona) nel sistema finanziario nel 2020 e continua a pompare anche nel 2021. Il bilancio della BCE è salito a quasi 7 mila miliardi (pari a quasi il 60% del PIL dell’Eurozona), arrivando a detenere circa il 30% del debito pubblico dell’Eurozona. Lagarde ha annunciato che anche la BCE, come la FED, permetterà che l’inflazione superi la soglia del 2% (fissata nel 2003): “Tale target era adeguato a un periodo in cui la BCE stava cercando di affermare la propria credibilità e un’inflazione troppo alta era la principale preoccupazione.”[]
- In relazione al riuscito sforzo nel 1790 di Alexander Hamilton, segretario del Tesoro USA dal 1789 al 1795, di far sì che il governo federale statunitense di recente formazione si assumesse tutti i debiti esistenti dei singoli 13 Stati che avevano firmato la dichiarazione d’indipendenza, creando così un’unica unione fiscale.[]
- Il Piano d’Azione sul Pilastro è basato su una consultazione pubblica di ampia portata, con cui sono stati raccolti oltre mille contributi scritti di Stati membri, istituzioni e organi dell’UE, regioni, città, parti sociali, organizzazioni della società civile, organizzazioni internazionali, gruppi di riflessione e cittadini. La Commissione ha inoltre organizzato seminari online ad hoc con oltre 1.500 portatori di interessi.[]
Alessandro Scassellati
20/10/2021 https://transform-italia.it

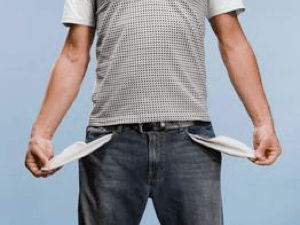








Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!