Il cambiamento climatico è un moltiplicatore di tutte le forme di disuguaglianza sociale

Quando pensiamo al cambiamento climatico crediamo che i suoi impatti siano indiscriminati, che gli effetti della crisi climatica possano riguardare tutti allo stesso modo, spesso in un futuro lontano dal nostro orizzonte temporale. Ricchi e poveri, abitanti dei centri storici e delle periferie, metropoli e comuni rurali dell’entroterra.
Ma così non è. Quando l’uragano Katrina ha devastato New Orleans nel 2005, sono stati i quartieri neri della città a subire il peso maggiore della tempesta. Dodici anni dopo, furono i quartieri neri di Houston a essere colpiti da tutta la forza dell’uragano Harvey. In entrambi i casi, i disastri naturali hanno aggravato i problemi di quartieri già duramente provati.
Quando la crisi climatica colpisce, lo fa più duramente su chi è già svantaggiato, inasprendo disuguaglianze tra Stati e tra fasce della popolazione all’interno di una stessa nazione. In questo senso, scrive Jeremy Williams in un articolo sulla BBC, il cambiamento climatico è intrinsecamente razzista.
Il primo divario è tra chi ha causato il cambiamento climatico e chi ne sta subendo gli effetti. Le persone di tutto il sud del mondo sono quelle che saranno maggiormente colpite dalla crisi climatica, anche se le loro impronte di carbonio sono generalmente molto basse.
Lo Zambia è uno degli esempi più emblematici di questa ingiustizia del cambiamento climatico. L’impronta di carbonio media in Zambia è molto bassa, arrivando a sole 0,36 tonnellate per persona all’anno, meno di un decimo della media del Regno Unito. Tuttavia, il paese sta affrontando una siccità prolungata che ha lasciato oltre un milione di persone bisognose di assistenza alimentare nel 2021.
«L’impatto maggiore è stato l’aumento della temperatura e la riduzione delle precipitazioni, con conseguenti shock climatici che includono siccità e inondazioni», spiega lo scienziato del clima zambiano Mulako Kabisa. Questi cambiamenti hanno portato all’impoverimento dei raccolti, alla morte del bestiame e alla riduzione del PIL del paese, aggiunge.
«La crisi climatica colpisce alcune parti del pianeta più di altre», afferma l’attivista climatica zambiana Veronica Mulenga. «Le ingiustizie storiche e attuali hanno lasciato le comunità composte da persone di colore, nere e indigene esposte a rischi per la salute ambientale di gran lunga maggiori rispetto alle comunità bianche. Le più colpite dai cambiamenti climatici sono le comunità nere e povere. Come continente siamo uno dei più colpiti dagli impatti dei cambiamenti climatici e siamo lasciati indietro mentre il mondo progredisce verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Se non teniamo conto delle persone più colpite, le soluzioni climatiche si trasformeranno in esclusione climatica». Questa esclusione si estende ai negoziati internazionali, dove Mulenga afferma che il suo paese è stato emarginato.
Poi ci sono i divari interni alle varie nazioni. Negli Stati Uniti le più esposte ai disastri ambientali legati alla crisi climatica sono ancora una volta le comunità nere, ispaniche o di altra origine etnica che hanno visto costruire nei pressi dei loro insediamenti anche discariche e inceneritori. In questi casi, i danni dei fenomeni meteorologici estremi associati al cambiamento climatico si sovrappongono alla devastazione ambientale delle aree dove vivono queste comunità e agli effetti della loro maggiore esposizione all’inquinamento industriale.
Questi problemi travalicano gli Stati Uniti e le categorie razziali. Il cambiamento climatico è un moltiplicatore di tutte le forme di disuguaglianza sociale, con dislivelli in base alla classe, al genere, all’età e molto altro ancora. In India sono le caste inferiori che rischiano di essere più colpite dal cambiamento climatico. A livello globale, le popolazioni indigene e le tribù nomadi sono spesso più vulnerabili. Come osserva ancora Veronica Mulenga, «giustizia climatica, giustizia sociale e giustizia razziale sono tutte interconnesse».
«Il nostro sistema economico ruota intorno al concetto che, nella ricerca dell’accumulazione del capitale e del profitto, alcune persone possano essere sacrificate. E queste persone sono state gli abitanti del sud del mondo. Non possiamo individuare delle soluzioni se ignoriamo la connessione tra schiavitù, colonialismo e capitalismo razzializzato che crea le condizioni per la crisi climatica», riflette l’attivista per la giustizia climatica Asad Rehman, attualmente direttore esecutivo dell’organizzazione benefica per la povertà e la giustizia War on Want.
Proprio la scorsa settimana uno studio pubblicato su Nature Sustainability è giunto alla conclusione che portare centinaia di milioni di persone – che vivono con meno di 1,9 dollari USA al giorno – oltre la soglia di povertà estrema richiederebbe un aumento minimo delle emissioni globali, inferiore all’1%, e non avrebbe alcun impatto sul cambiamento climatico in corso.
I risultati della ricerca sono impietosi e mostrano l’evidente disuguaglianza tra paesi ricchi e poveri, fasce della popolazione più ricche e più povere. La mappa delle emissioni globali ricalca quella della distribuzione della ricchezza. La distribuzione delle emissioni è diseguale, poiché sono prodotte in modo sproporzionato da persone dei paesi più ricchi che in genere vivono stili di vita ad alta intensità di carbonio.

All’interno di ciascun paese, gli autori hanno suddiviso la popolazione in gruppi in base a quanto spendono, in media. Per fare un esempio, l’impronta di carbonio media di una persona che vive nell’Africa subsahariana è di 0,6 tonnellate di anidride carbonica (tCO2), mentre un cittadino medio statunitense produce 14,5 tCO2 all’anno. In estrema sintesi, l’impronta di carbonio media dell’1% più ricco degli emettitori è oltre 75 volte superiore a quella del 50% più povero.
Secondo lo studio, più di un miliardo di persone viveva al di sotto della soglia di povertà estrema di 1,90 dollari al giorno nel 2014. La “povertà estrema” all’epoca era concentrata principalmente in Africa e nell’Asia meridionale, dove le emissioni di CO2 pro capite sono generalmente le più basse.

“La disuguaglianza di carbonio è uno specchio dell’estrema disuguaglianza di reddito e ricchezza sperimentata oggi a livello nazionale e globale”, afferma lo studio. “Questa disparità è semplicemente folle”, aggiunge a Carbon Brief l’autore principale dello studio, Benedikt Bruckner, dell’Università di Groningen, in Olanda. “Se vogliamo ridurre le nostre emissioni di carbonio, dobbiamo davvero fare qualcosa per i modelli di consumo dei super ricchi”.
Negli Stati Uniti, il presidente Joe Biden sia in campagna elettorale che all’inizio del suo mandato aveva promesso di affrontare la questione dell’esposizione di neri, ispanici e altre persone di colore ai rischi ambientali. Ma, i funzionari dell’amministrazione statunitense – preoccupati che usare esplicitamente la razza per identificare le comunità svantaggiate e assegnare loro benefici federali possa innescare azioni legali che di fatto pregiudicherebbero ogni sforzo (anche alla luce di una Corte Suprema di tendenza conservatrice) – hanno deciso di affrontare la questione del razzismo ambientale senza menzionare la questione razziale. E così la Casa Bianca si concentrerà sulle comunità economicamente svantaggiate.
Tuttavia, racconta Lisa Friedman sul New York Times, molti attivisti sono preoccupati considerato che “decenni di esposizione ai rischi ambientali, radicati in torti storici come la zonizzazione razzista e le politiche abitative, non possono essere affrontati efficacemente con un approccio neutrale rispetto alla razza”.
«È quasi come cercare di affrontare la discriminazione abitativa, ma senza poter dire chi è discriminato», spiega sempre al New York Times Robert Bullard, professore di pianificazione urbana e politica ambientale alla Texas Southern University e tra i pionieri del movimento per la giustizia ambientale. «Non il reddito, non i valori immobiliari, ma la razza è il criterio più significativo per individuare chi è più esposto all’inquinamento industriale. Se escludi la razza dai criteri, come puoi pensare di risolvere questo problema?».
Nature Climate Change: decine di siti patrimonio dell’umanità lungo la costa africana a rischio per gli effetti dei cambiamenti climatici
Da importanti siti archeologici alle rotte migratorie degli uccelli o corsi d’acqua fondamentali per le comunità di pescatori costieri: la costa africana ospita molti siti culturali e naturali che sono patrimonio dell’umanità. Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Climate Change, entro il 2050 diversi luoghi iconici della costa africana saranno tre volte a rischio di più per gli effetti dei cambiamenti climatici.
Sulla base degli scenari prefigurati dallo studio, il sito Carbon Brief ha realizzato una mappa interattiva che esplora i rischi che corrono i 284 siti, patrimonio culturale e naturalistico, identificati dalla ricerca. Tra i luoghi a rischio, Sabratha, una stazione commerciale del II secolo in Libia, le cascate di Lobé, un insieme unico al mondo di cascate di grande importanza culturale per i Batanga, Maabi e Pigmei in Camerun, l’isola di Kunta Kinteh, in Gambia, memoria storica della tratta degli schiavi, il delta del Niger.

“Il cambiamento climatico potrebbe determinare perdite e danni ‘tangibili e intangibili’ nel sud del mondo”, ha dichiarato uno degli autori dello studio a Carbon Brief.

“In Africa, il nostro patrimonio naturale e culturale racconta e traccia la nostra storia. Una volta perduto, non potrà essere né sostituito né ripristinato. Perderlo potrebbe significare cancellare la nostra storia”, ha aggiunto un giovane attivista nigeriano.
Oltre 100 paesi si sono impegnati ad adottare misure per preservare gli oceani dai danni fatti dall’uomo
Durante il vertice di One Ocean a Brest, rappresentanti di oltre 100 paesi si sono impegnati ad attuare diverse iniziative per preservare gli oceani dai danni arrecati dall’uomo, tra cui la lotta contro la pesca illegale, la riduzione dell’inquinamento da plastica e una migliore protezione delle acque internazionali.
I 27 paesi UE e altri 16 Stati hanno concordato di raggiungere entro la fine dell’anno un accordo globale per regolamentare l’uso sostenibile delle acque d’alto mare (al di fuori della giurisdizione di ogni nazione) e preservare la loro biodiversità.
Altri sei paesi hanno aderito a un “impegno globale per l’economia della plastica” sostenuto dal programma ambientale delle Nazioni Unite per aiutare i governi e le imprese a passare a un’economia circolare mirata al riciclaggio o al riutilizzo del 100% di tutta la plastica. Mentre un’altra dozzina di Stati si è impegnata a ratificare l’accordo di Città del Capo dell’Organizzazione marittima internazionale per frenare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Intanto, 22 armatori europei hanno annunciato il loro impegno per ridurre il rumore subacqueo, le emissioni, i residui e gli scarichi di petrolio, e i paesi del Mediterraneo, insieme all’Unione Europea, hanno dichiarato di voler trasformare il Mar Mediterraneo in un’area a basso contenuto di emissioni di zolfo entro il 2025.
Francia e Colombia avvieranno una coalizione globale per il “carbonio blu” per finanziare il ripristino degli ecosistemi costieri come saline, praterie di fanerogame e mangrovie che sono in grado di assorbire e immagazzinare grandi quantità di carbonio.
Bosch spenderà 2 miliardi di euro per riqualificare i lavoratori dell’industria automobilistica in transizione all’elettrico
Bosch, il più grande fornitore europeo di componenti per auto, spenderà un totale di circa 2 miliardi di euro per riqualificare alcuni dei suoi 400.000 dipendenti per frenare le perdite di posti di lavoro nella decarbonizzazione del settore dei trasporti e la transizione dell’industria automobilistica dai motori a combustione alla tecnologia elettrica.
Il gruppo tedesco ha già speso un miliardo di euro per riqualificare i lavoratori dei settori non automobilistici in programmi sull’intelligenza artificiale e una somma simile verrà investita nei prossimi cinque anni, ha dichiarato il direttore delle risorse umane di Bosch, Filiz Albrecht, “in modo che gli ingegneri meccanici diventino sviluppatori di software e i lavoratori qualificati della tecnologia di combustione siano riqualificati per lavorare nel passaggio alle auto elettriche”. L’importo è di circa 500 euro per dipendente all’anno.
L’annuncio arriva in un momento di grave carenza di manodopera qualificata in Germania e oltre. All’inizio di febbraio, le aziende dell’area euro hanno riferito che la perdita di manodopera ha raggiunto il livello più alto almeno dal 1982.
Eni moltiplica i profitti anche grazie ai prezzi del gas. E li reinveste nel fossile
Il 17 febbraio 2022 il Consiglio di amministrazione di ENI ha approvato i risultati consolidati dell’esercizio e del quarto trimestre 2021. L’utile operativo adjusted è stato di 4,7 miliardi di euro, “il più alto dal 2012”, ha commentato l’amministratore delegato della multinazionale degli idrocarburi, Claudio Descalzi. Nell’ultimo trimestre 2021 gli utili sono cresciuti del 53% (pari a 3,8 miliardi di euro) rispetto ai tre mesi precedenti, anche grazie all’aumento dei prezzi del gas, tornando così ai livelli pre-pandemia.
Nel 2021 “gli utili del settore ‘Exploration and Production’ – riporta Altreconomia – pesano per 9,3 miliardi sui 9,7 complessivi”. Che sono stati poi reinvestiti perlopiù nel settore fossile. Dei 5,3 miliardi di euro di investimenti tecnici, 3,4 sono stati utilizzati, infatti, per lo sviluppo di giacimenti di idrocarburi, in particolare Egitto, Angola, Stati Uniti, Messico, Emirati Arabi Uniti, Italia, Indonesia e Iraq. Mentre alle fonti rinnovabili sono stati destinati 366 milioni di euro.
E se rispetto alle alle “iniziative di decarbonizzazione”, ENI continua a parlare in termini di “progetti”, “passi in avanti”, “attività di ricerca e sviluppo” e “significativi avanzamenti”, prosegue Altreconomia, nel frattempo il portafoglio esplorativo di idrocarburi è stato “rinnovato con circa 15.800 chilometri quadrati di nuovi permessi in Angola, Costa d’Avorio, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Norvegia, Regno Unito e Vietnam”. E sono state aggiudicate “cinque licenze esplorative in Egitto”.
“È l’ennesima prova di come ENI sia nel pieno dell’economia fossile, contrariamente a quel che racconta”, commenta Antonio Tricarico, campaigner finanza pubblica e multinazionali di ReCommon. “Del resto ENI ha dichiarato di puntare a un picco di produzione di idrocarburi pari a 2,1 milioni di boe/giorno nel 2025. Dubito che a marzo presentino un piano industriale che cambi l’orientamento. È puro effetto lock-in, ENI è cioè intrappolata nel fossile e al governo va bene così”.

Angela Romano
21/2/2022 https://www.valigiablu.it
Immagine in anteprima: Felton Davis, CC BY 2.0, via Flickr.com






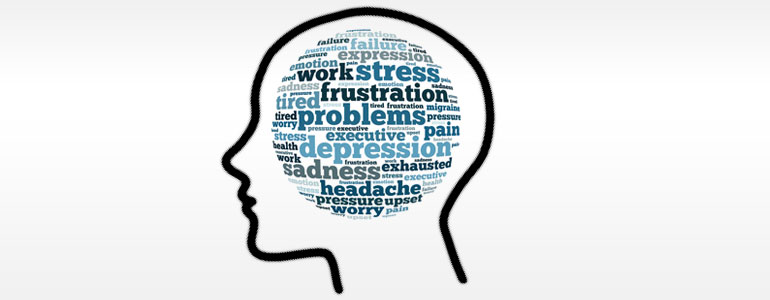

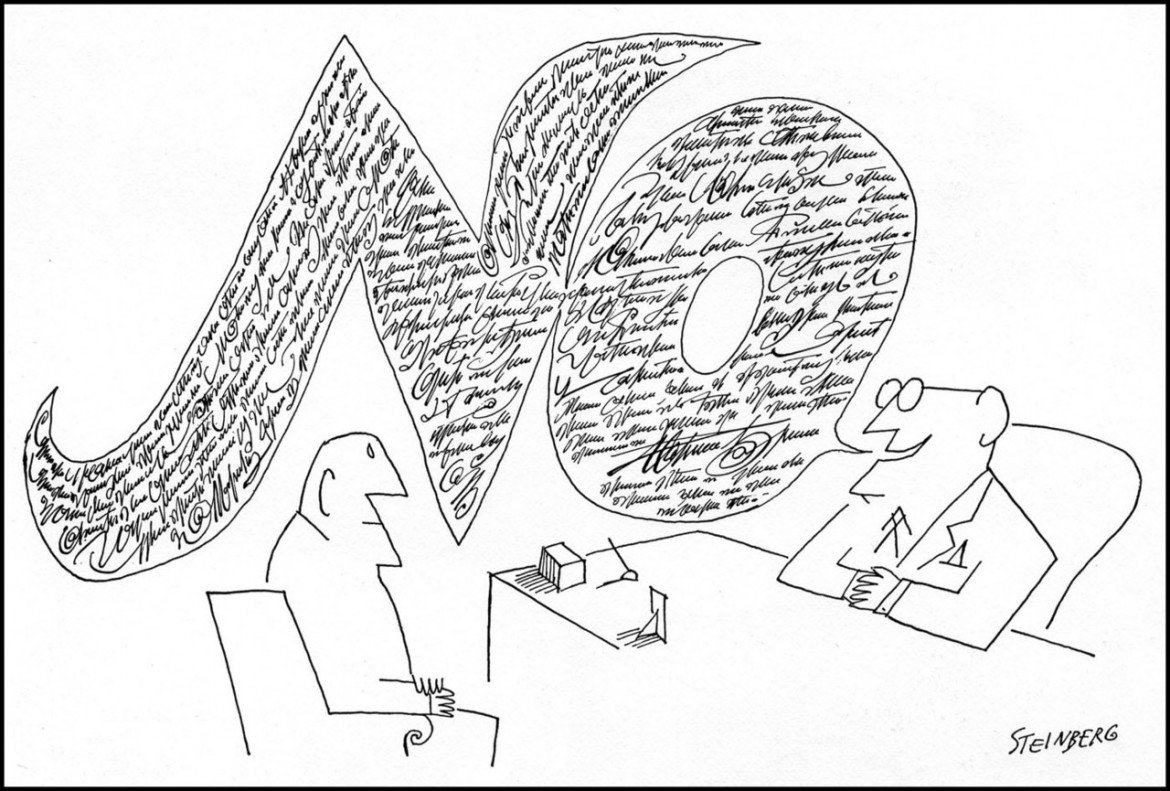


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!