DIRITTO DEL LAVORO: L’EUROPA E LE BUFALE ITALIANE

Già in numerose altre occasioni ho denunciato il subdolo e reiterato tentativo di lasciar credere ai nostri connazionali che l’appartenenza all’Ue richiedesse, di per sé, l’adeguamento della nostra legislazione nazionale a regole e norme vincolanti; che non consentivano alcuno spazio di manovra autonoma.
Ciò è sempre avvenuto, da parte di esponenti politici e di prezzolati consulenti – che (di norma) si presentano, addirittura, sotto le mentite spoglie di “indipendenti” al servizio dei lavoratori – quando si è ritenuto opportuno procedere con delle vere e proprie contro/riforme.
Quella realizzatasi, negli ultimi venti anni, in tema di Legislazione e Mercato del lavoro, ne è la rappresentazione più evidente.
In più occasioni, infatti, ci è stato somministrato quello che, in breve, è diventato un assordante slogan: “Ce lo chiede l’Europa”!
In virtù, quindi, di queste ipotetiche e ineludibili imposizioni dell’Ue, siamo stati costretti, tra l’altro, a subire quelli che, nel tempo, si sono rivelati veri e propri attentati alla complessa struttura legislativa che tutelava i lavoratori italiani.
Senza bisogno di eccedere in esempi pratici, è sufficiente il riferimento a quanto (di negativo) prodotto dalle nuove norme; in particolare, in materia di contratti a tempo determinato e art. 18 dello Statuto.
Nascevano, così, in Italia, rapporti di lavoro a termine “a/casuali” e reiterati nel tempo; cioè senza prevedere alcuna indicazione del motivo per il quale si ricorreva al T.D. piuttosto che a un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con ampie possibilità di rinnovi e proroghe.
Cosa del tutto diversa succedeva, ad esempio, in Spagna che, fino a prova contraria, appartiene, al pari dell’Italia, alla stessa Ue. In quel paese, infatti, all’abuso della reiterazione del ricorso ingiustificato ai contratti a termine, corrisponde ancora la trasformazione a tempo indeterminato.
In Italia, quindi, di là delle chiacchiere e delle pseudo ingiunzioni europee, era prevalso – per scelta politica – l’interesse delle aziende, piuttosto che una maggiore tutela dei lavoratori.
Così come, nel caso dei licenziamenti individuali, si procedeva con l’abrogazione della c.d. “giusta causa” e – cose che l’Ue non si era mai sognata di chiedere espressamente -all’esautorazione del ruolo del giudice del lavoro.
In questo contesto, come era lecito attendersi, la recente sentenza, attraverso la quale la Corte Costituzionale è intervenuta sulla nuova disciplina dei licenziamenti individuali, restituendo alla discrezionalità del giudice la possibilità di stabilire l’entità dell’indennità di licenziamento – non più rigidamente pre/determinata in virtù dell’anzianità di servizio, fermi restando il limite minimo e quello massimo – ha prodotto effetti e commenti di diversa natura.
Alla soddisfazione di chi ha ritenuto che fosse cosa buona e logica procedere, da parte del giudice, alla determinazione dell’indennità da corrispondere al lavoratore licenziato, non più e solo facendo unicamente riferimento all’anzianità di servizio, ma anche ad altri parametri (quali, presumibilmente: carico di famiglia, condizioni del mercato del lavoro locale e comportamenti tenuti dalle parti) – che, inevitabilmente, in considerazione dell’esistenza dei due limiti, finiranno per essere più favorevoli ai lavoratori con minore anzianità lavorativa – hanno fatto da contrappeso la contrarietà e i mugugni di chi, in particolare, quell’impianto aveva progettato e visto affermarsi.
In effetti, senza dimenticare che il c.d. “Contratto a tutele crescenti”, di cui all’art. 3 del decreto legislativo 23/2015, aveva già un illustre precedente in quello che venne denominato “Contratto unico” – a cura dell’attuale Presidente dell’Inps Tito Boeri e di Pietro Garibaldi – è opportuno rilevare che la versione vigente dei contratti a tempo indeterminato costituiti dopo il 6 marzo 2015, sui quali sembrerebbe calata la scure della Suprema Corte, è quella prodotta da Pietro Ichino; il “Licenziatore”, tra i giuslavoristi italiani!
Non a caso, è da parte di Ichino che si sono levate le prime proteste e i giudizi più negativi rispetto all’aumento – da 24 a 36 mensilità dell’ultima retribuzione – dell’indennità massima, per un licenziamento comunque ingiustificato.
Tra l’altro, è opportuno evidenziare che – applicandosi la disposizione a tutti coloro che sono stati assunti a partire dal 7 marzo 2015 – le nuove norme cominceranno ad essere applicate non prima di circa dieci anni.
C’è un punto, però, molto importante; che non è opportuno sottacere.
Nel mentre Pietro Ichino afferma[i]:” Una delle informazioni più importanti che gli investitori chiedono prima di scegliere un paese per dislocarvi un proprio piano industriale è costituito dal severance cost, cioè dal costo che l’ordinamento imporrà loro per chiudere i rapporti di lavoro se ciò si renderà necessario. Con la riforma del 2012/2015 l’Italia si era posta in grado di dare alla domanda una risposta analoga per entità e precisione a quella degli altri maggiori ordinamenti nazionali europei. La sentenza della Consulta, torna a far dilatare l’alea circa l’esito dei giudizi”.
La realtà si scopre ben diversa!
Risulta, quindi, per lo meno, strano, che un giuslavorista del livello di Ichino non sappia, o, peggio, faccia finta di non sapere, che le cose, in Europa, non stanno come dice lui!
In realtà – mi si perdoni la lungaggine – se è vero che, in accoglimento all’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, “ogni lavoratore ha diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato”; è altrettanto vero che ciascun paese ha adottato una specifica normativa e quella che Ichino paventa, per l’Italia, come la “dilatazione dell’alea dei giudizi” è, invece, una condizione[ii] comune a quasi tutta l’area dell’Ue.
In Austria, a fronte di un licenziamento illegittimo, il lavoratore va reintegrato e percepisce un risarcimento, così come avveniva una volta in Italia. Il giudice, però, è anche tenuto a valutare la legittimità del provvedimento in base alle diverse esigenze dell’azienda e del lavoratore.
In Germania, è previsto che il lavoratore sia reintegrato. In alternativa, il datore di lavoro, motivandone le ragioni, può, risarcire il lavoratore con un’indennità.
In Francia, l’ordine del reintegro è previsto ma non può essere imposto. Il risarcimento va dalle 6 alle 24 mensilità. In alcuni casi, è prevista anche un’indennità per il danno subito dal lavoratore.
In Olanda, il datore di lavoro può scegliere tra la reintegra e il versamento di un’indennità. Il licenziamento di un lavoratore è sottoposto, però, a un’autorizzazione amministrativa che ne valuta la ragionevolezza.
In Danimarca, la legge ammette la reintegra del lavoratore licenziato ingiustamente e stabilisce un risarcimento pari a 12 mesi di retribuzione.
In Portogallo, il datore di lavoro ha l’obbligo di reintegrare il lavoratore ingiustamente licenziato.
Nel Regno Unito, è previsto un rimborso base pari a 6 mila sterline, un importo “compensatorio” pari a 12 mila sterline ed eventualmente, importi speciali. La discriminazione per motivi politici o razziali rappresenta un “motivo illecito” ed è, quindi, prevista la reintegra.
In Spagna, la reintegra è facoltativa. Il datore di lavoro può optare per un risarcimento pari a 33 giornate lavorative per ogni anno di anzianità, più gli arretrati.
In Svezia, infine, il licenziamento può avvenire solo per grave disobbedienza o per ristrutturazione dell’azienda. Il giudice può imporre la reintegra o il risarcimento del danno più tutte le retribuzioni maturate dal momento del licenziamento e fino alla sentenza (come, una volta, avveniva in Italia). Se il datore di lavoro nega la reintegra, deve corrispondere dalle 16 alle 48 mensilità.
Appare, quindi, fin troppo chiaro, che i lavoratori italiani – e non solo loro – sono rimasti vittima di una colossale truffa ai loro danni!
Quando Monti, la Fornero, Renzi e, più di tutti, Pietro Ichino, il fiero sostenitore e condottiero delle crociate contro l’art. 18, avverso la giusta causa e l’istituto della reintegra e, in sostanza, contro la stabilità occupazionale prevista dal vecchio contratto a tempo indeterminato – non l’aborto prodotto con il “contratto a tutele crescenti” – sollecitavano l’indispensabile necessità di procedere a riformare la Legislazione del lavoro in Italia, perché “Lo chiede l’Europa”, è evidente che mentivano sapendo di mentire!
Oggi, come allora.
NOTE
[1] Lavoro: L’Italia ritorna in mezzo al guado, in <Post di P. Ichino>, nr. 485/2018
2 Il licenziamento nei vari paesi europei, in <www Intrange>, 20/02/2015
Renato Fioretti
Esperto Diritti del Lavoro.
Collaboratore redazionale del periodico cartaceo Lavoro e Salute
4/10/2018


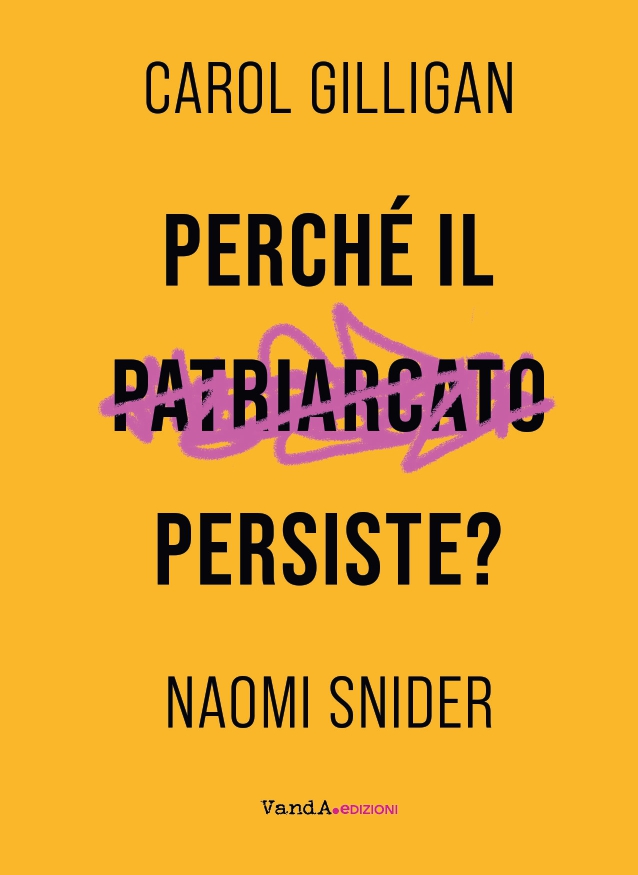






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!