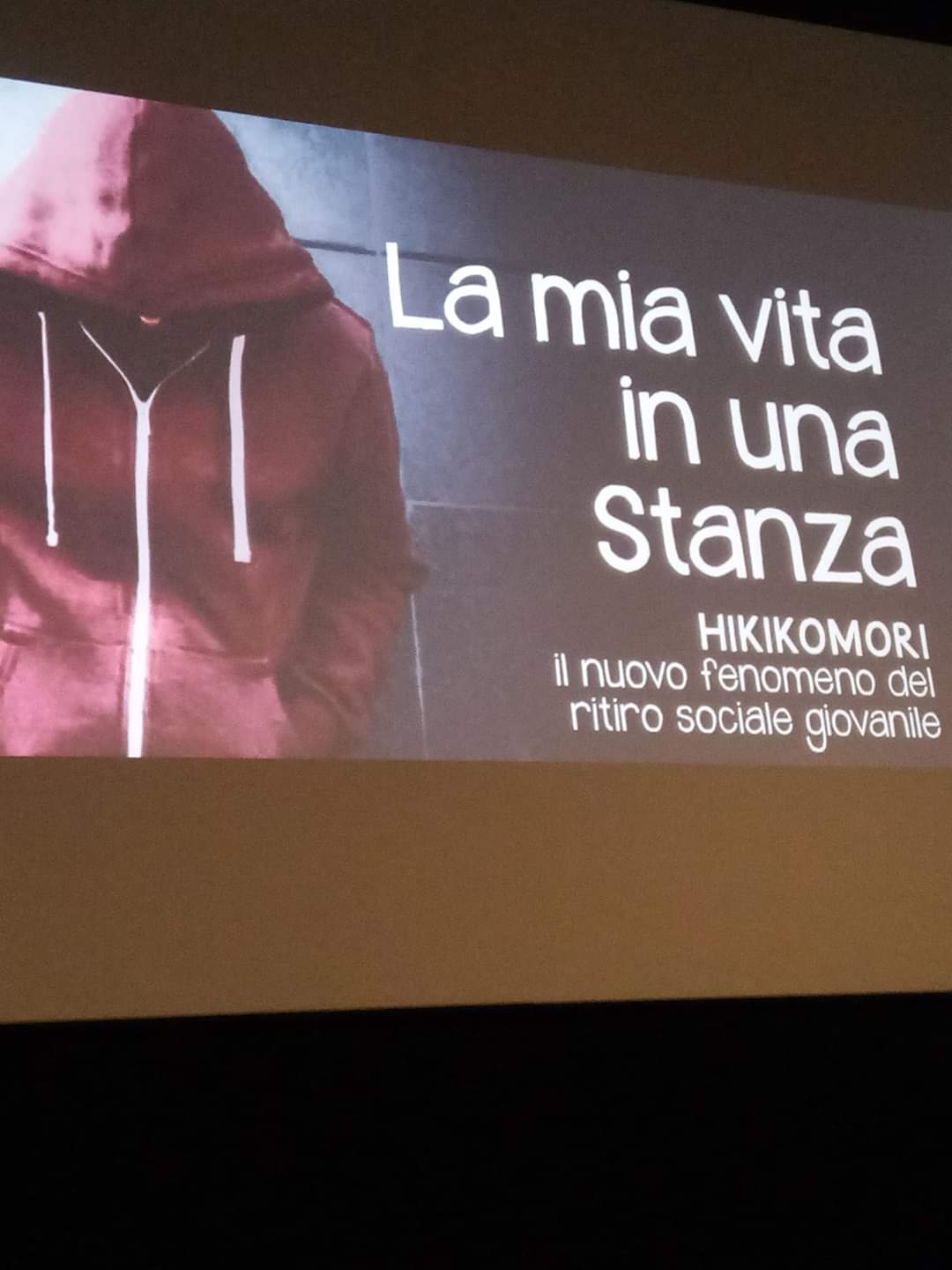
Hikikomori, è boom anche in Italia: migliaia di giovani si recludono in casa
Hanno tra i 14 e i 25 anni e non studiano né lavorano. Non hanno amici e trascorrono gran parte della giornata nella loro camera. A stento parlano con genitori e parenti. Dormono durante il giorno e vivono di notte per evitare qualsiasi confronto con il mondo esterno. Si rifugiano tra i meandri della Rete e dei social network con profili fittizi, unico contatto con la società che hanno abbandonato. Li chiamano hikikomori, termine giapponese che significa “stare in disparte”. Nel Paese del Sol Levante hanno da poco raggiunto la preoccupante cifra di un milione di casi, ma è sbagliato considerarlo un fenomeno limitato soltanto ai confini giapponesi.
“E’ un male che affligge tutte le economie sviluppate – spiega Marco Crepaldi, fondatore di Hikikomori Italia, la prima associazione nazionale di informazione e supporto sul tema – Le aspettative di realizzazione sociale sono una spada di Damocle per tutte le nuove generazioni degli anni Duemila: c’è chi riesce a sopportare la pressione della competizione scolastica e lavorativa e chi, invece, molla tutto e decide di auto-escludersi”.
Le ultime stime parlano di 100mila casi italiani di hikikomori, un esercito di reclusi che chiede aiuto. Un numero che è destinato ad aumentare se non si riuscirà a dare al fenomeno una precisa collocazione clinica e sociale.
Un fenomeno dai contorni ancora poco chiari
Associazioni come Hikikomori Italia ormai da anni stanno facendo il possibile per sensibilizzare l’opinione pubblica intorno ad un disagio che viene troppo spesso confuso con l’inettitudine e la mancanza di iniziativa delle nuove generazioni. Un equivoco che ha trovato terreno fertile nel dibattito politico, legislatura dopo legislatura, fornendo stereotipi come “bamboccioni”, definizione coniata nel 2007 dall’allora ministro dell’Economia, Tommaso Padoa-Schioppa, o “giovani italiani choosy” (schizzinosi) dell’ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, fino ad arrivare al mare magnum dell’acronimo Neet, i ragazzi “senza studio né lavoro”, che secondo un sondaggio dell’Università Cattolica del 2017 sarebbero 2 milioni in tutta la Penisola.
Anche dal punto di vista medico l’hikikomori soffre di una classificazione nebulosa. Nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM), la “Bibbia” della psichiatria, è ancora iscritto come sindrome culturale giapponese: un’imprecisione che tende a sottostimare la minaccia del disagio nel resto del mondo e che crea pericolose conseguenze.
Molto spesso viene confuso con sindromi depressive e nei peggiori casi al ragazzo viene affibbiata l’etichetta della dipendenza da internet. Una diagnosi di questo genere normalmente porta all’allontanamento forzato da qualsiasi dispositivo elettronico, eliminando, di fatto, l’unica fonte di comunicazione con il mondo esterno per il malato: una condanna per un ragazzo hikikomori”.
Come si diventa hikikomori?
L’ambiente scolastico è un luogo vissuto con particolare sofferenza dagli hikikomori, non a caso la maggior parte di loro propende per l’isolamento forzato proprio durante gli anni delle medie e delle superiori. E’ in questo periodo che di solito si verifica il cosiddetto “fattore precipitante”, ovvero l’evento chiave che dà il via al graduale allontanamento da amici e familiari. Può essere un episodio di bullismo o un brutto voto a scuola, ad esempio.
Un avvenimento innocuo agli occhi delle altre persone, ma che contestualizzato all’interno di un quadro psicologico fragile e vulnerabile, assume un’importanza estremamente rilevante. E’ la prima fase dell’hikikomori: il ragazzo comincia a saltare giorni di scuola utilizzando scuse di qualsiasi genere, abbandona tutte le attività sportive, inverte il ritmo sonno-veglia e si dedica a monotoni appuntamenti solitari come il consumo sregolato di serie TV e videogames.
E’ fondamentale intervenire proprio in questo primo stadio del disturbo, quando si manifestano i primi campanelli di allarme. In questa fase i genitori e gli insegnanti rivestono un ruolo cruciale in chiave prevenzione: indagare a fondo sulle motivazioni intime del disagio e, nel caso, cercare in breve tempo il supporto di un professionista esterno può evitare il passaggio ad una fase più critica, che richiederebbe un intervento lungo potenzialmente anche anni.
Italia e Giappone: due facce della stessa medaglia
È innegabile che la cultura giapponese sia storicamente caratterizzata da una serie di fattori che aumentano la portata del fenomeno, tanto da poter già parlare di due generazioni di hikikomori, la prima sviluppatasi negli anni Ottanta. Il sistema sociale e scolastico ultra competitivo e il ruolo della figura paterna spesso assente a causa di orari di lavoro estenuanti sono alla base di aspettative opprimenti, spesso non realizzate. Seppur con le dovute proporzioni anche in Italia le pressioni sociali sono molto forti. Determinanti fin dai primi casi di hikikomori diagnosticati nel 2007, sono il calo delle nascite con il conseguente aumento dei figli unici, di norma sottoposti a pressioni maggiori, la crisi economica che rende più lontano l’ingresso (reale) nel mondo del lavoro e l’esplosione della cultura dell’immagine, esasperata dalla diffusione capillare dei social network.
In Italia la sindrome non colpisce solo i maschi, come avviene in Giappone, ma riguarda anche un discreto numero di hikikomori-femmine, con un rapporto di 70 a 30. “Per una questione culturale le famiglie considerano, tuttavia, la reclusione della figlia come un problema minore. Probabilmente perché la vedono come una futura casalinga o sperano che un domani si sposi ed esca di casa.
All’interno del contesto italiano, ci sono poi differenze addirittura tra una regione e l’altra: gli hikikomori del Nord Italia hanno, infatti, delle caratteristiche diverse rispetto a quelli del Sud Italia.
M. 25 anni
“Il giorno e la notte erano identici, dormivo quando avevo voglia, mangiavo quando avevo voglia. Ho perso tutti gli amici e lo schermo era uno “stargate” per un altro universo. Il tempo si dilatava quando cliccavo sulla tastiera e non volevo mai smettere. Quando dovevo lavarmi fremevo sotto la doccia per rimettermi a giocare.
Ho passato così più di due anni giocando a Wow [World of Warcraft, un videogioco di strategia ndr] in totale isolamento. Non riuscivo neanche più a camminare. Tutto questo è successo senza che mia madre si accorgesse di nulla: lavorava dalle 8 alle 17 e io facevo finta di andare a scuola. Non avevo più voglia di tornarci. Troppa pressione.
L’isolamento è una battaglia che alla fine diventa una cura. Cresceva dentro di me come un’onda, lentamente, fino al momento in cui tutto iniziava a darmi fastidio, non sopportavo cosa facevo, non sopportavo chi ero.
Oggi ne sono fuori, vivo all’estero ed ho una fidanzata bellissima. Sono o sono stato un hikikomori? Non lo so, ma quello che so è che la forza per combattere quel demone sta e risiede solo dentro di voi, nessuno vi può aiutare, nella taverna di qualche montagna virtuale dove voi stessi vi siete persi, con la sensazione di pace che vi avvolge la mente. L’unico consiglio che mi sento di darvi è: scappate da quel computer”.
Marilena Pallareti
Docente, Forlì
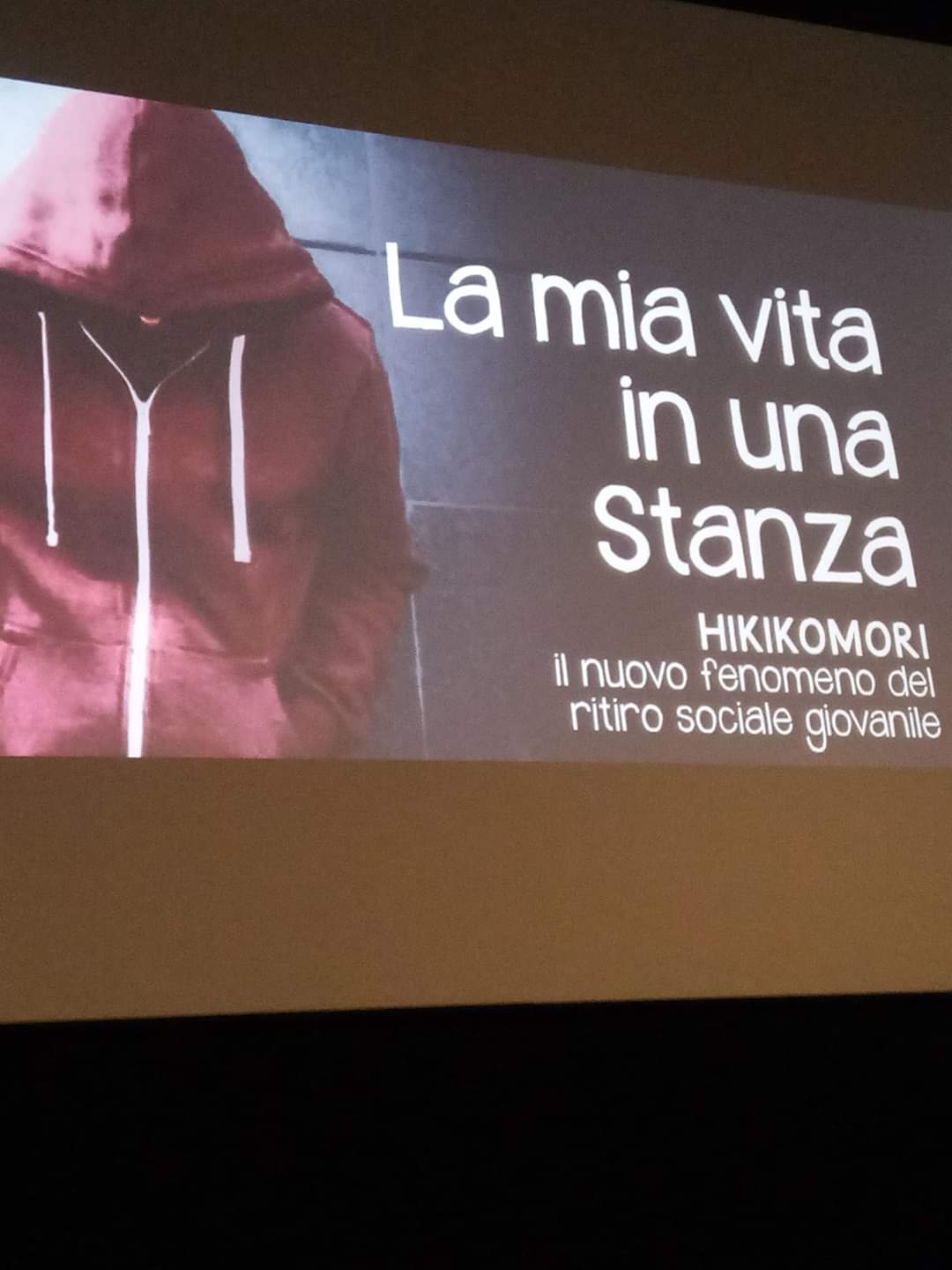
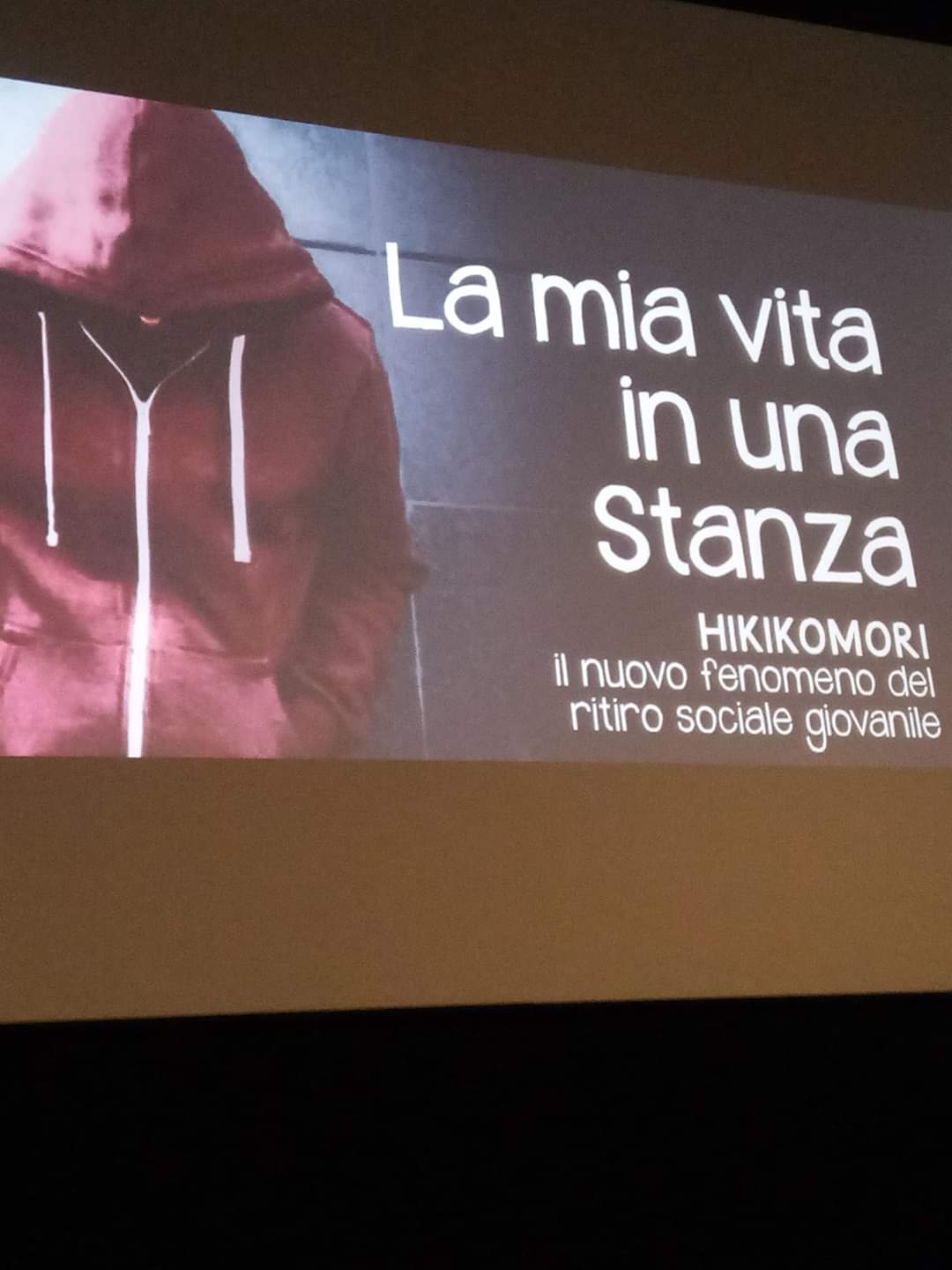

 TORINO. CARO RETTORE, L’INDIFFERENZA È IL PESO MORTO DELLA STORIA
TORINO. CARO RETTORE, L’INDIFFERENZA È IL PESO MORTO DELLA STORIA
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!