Violenza contro le donne: l’odio contro chi denuncia

L’odio contro le donne che decidono di denunciare la violenza rappresenta l’ennesima spira di una cultura oppressiva e consolidata, che coinvolge la società a tutti i livelli. Lo confermano gli ultimi casi di femminicidio, e le storie che si sono susseguite negli anni
A fronte dei periodici appelli a “denunciare al primo schiaffo” e a prendere parola sulle molteplici forme di violenza nelle relazioni di intimità, è diffusa la pratica sociale di “zittire” brutalmente proprio le donne e le ragazze che decidono di denunciare il partner violento, l’aggressore sessuale, il collega o datore di lavoro molesto o, partendo dalla propria esperienza personale, discriminazioni e pratiche sessiste sistemiche che affrontano nel paese, attraverso denigrazioni continue online e offline.
Nell’esperienza di accoglienza e ospitalità, l’associazione Differenza Donna, attiva a Roma dal 1989 con l’obiettivo di far emergere, combattere, prevenire e superare la violenza di genere, ha registrato negli ultimi anni una rilevante incidenza di quest’ulteriore forma di violenza, che nell’opinione di chi scrive costituisce una vera e propria manifestazione di repressione sociale nei confronti delle donne e delle ragazze che si ribellano alla violenza sessista e di genere.
L’odio irrefrenabile che si scatena contro le donne che si ribellano e rompono il silenzio di cui si alimenta la violenza nelle relazioni di intimità produce molteplici danni, non solo a coloro che ne sono bersaglio diretto, ma anche alle persone a loro vicine, poiché generano paura e una condizione di allarme permanente, che possono indurre a desistere dalle iniziative intraprese. Produce danno anche a tutte le altre donne, quindi danni sociali e intergenerazionali molto preoccupanti e sottovalutati.
Per comprendere meglio di cosa si tratta, è utile partire da esempi concreti emersi nel corso dell’accoglienza presso i centri antiviolenza che l’associazione Differenza Donna gestisce in Italia: il primo caso riguarda una ragazza ancora minorenne, aggredita dal suo ragazzo coetaneo per un litigio.
Il ragazzo prima l’ha insultata e poi l’ha colpita in viso con una testata, fratturandole il setto nasale. La versione dei fatti da lui imbastita nell’immediatezza dell’aggressione e del soccorso che le persone presenti hanno prestato alla ragazza è stata subito smentita da quest’ultima, che, sostenuta dai genitori, dopo aver ricevuto le cure mediche ha deciso di denunciare l’aggressore: ne è emerso un quadro di atti persecutori fra cui il controllo ossessivo del telefono e degli account social, l’intralcio continuo alle attività scolastiche ed extra-scolastiche, le discussioni per ogni iniziativa autonoma della ragazza per svago o per studio, fino all’aggressione fisica.
La giovane è stata immediatamente raggiunta da messaggi sui social, dapprima del suo ex ragazzo e poi dal suo gruppo di amici, che tentavano di dissuaderla dall’intraprendere iniziative legali. I messaggi si sono intensificati dopo la sua richiesta alla dirigente scolastica di adottare misure concrete di allontanamento del ragazzo dalla sede della scuola da lei frequentata. Ben presto, i messaggi sono diventati denigratori e molesti: inviti a “ragionare”, a “non esagerare”, sottolineando a più riprese che la responsabilità, se accadono queste cose, è da entrambe le parti.
Questo è un primo livello di discorsi di odio a cui sono esposte le donne che decidono di rendere pubblica una violenza nelle relazioni intime, che, oltre a scoraggiare nel portare avanti le decisioni maturate, producono l’effetto paradossale per cui a rimanere isolata è la persona che si ribella alla prevaricazione, non l’aggressore violento.
Un secondo livello è quello riservato a chi, dopo aver denunciato l’uomo violento da cui si è allontanata, viene attaccata sui social media da persone terze, sconosciute, che prospettano ritorsioni e ulteriori violenze.
Un caso esemplificativo è quello di una donna che si è recata d’urgenza in una casa rifugio gestita da Differenza Donna con il figlio di appena un anno, in seguito a mesi di persecuzione continua da parte dall’ex compagno, da cui si era già allontanata interrompendo la convivenza a causa dei maltrattamenti.
I comportamenti dell’uomo non si arrestavano, in un’escalation di pedinamenti, appostamenti e minacce di morte a lei e al figlio, che avrebbe fatto “la fine di quel bambino gettato nel Tevere tempo fa”.
Dopo l’ingresso della donna in casa rifugio, l’uomo ha pubblicato la foto del bambino con un annuncio di scomparsa e la preghiera rivolta alla donna di riportare il figlio da lui. Immediatamente si è attivata una tempesta di post che menzionavano la donna direttamente, rimandando al suo profilo personale. In poche ore il suo profilo e l’applicazione di messaggistica sono stati invasi di messaggi e post di persone sconosciute con insulti di ogni tipo a sfondo sessista e auguri di punizioni e violenze.
L’unica soluzione possibile per bloccare l’onda di odio che aveva amplificato la paura della donna di ulteriori violenze – questa volta non solo da parte dell’ex compagno, ma anche da parte di persone sconosciute – è stata quella di disattivare le utenze e non accedere più ai social network, assumendo così direttamente iniziative di autodifesa, che comunque non escludono la gravità della condotta subita.
Le ondate di odio online e offline non vengono risparmiate neppure a quelle donne che con determinazione prendono parola per denunciare, insieme ai comportamenti diretti di violenza e discriminazione che hanno subito, anche gli ostacoli incontrati sul percorso: le pratiche discriminatorie fino alla violenza istituzionale, ossia quelle forme gravi di vittimizzazione secondaria che spesso le donne sperimentano nel corso dei procedimenti penali e per la regolamentazione dell’affidamento dei figli e delle figlie.[1]
Bersaglio di forme di hate speech feroce e organizzato sono in particolare le donne che in molti paesi, compresa l’Italia, stanno portando avanti un’azione di sensibilizzazione e denuncia del doppio standard di valutazione giudiziaria che, in quanto donne e madri, subiscono nell’ambito dei procedimenti di regolamentazione della genitorialità.
Infatti, parallelamente all’avanzamento degli istituti introdotti in molti ordinamenti per la prevenzione e la protezione delle donne dalla violenza di genere, è stata veicolata in maniera diffusa e consolidata da presunti esperti della genitorialità una cornice di mother blaming, che mistifica e nega la rilevanza della violenza domestica nella determinazione del regime di affidamento dei figli e delle figlie, anche nei casi di esposizione alla violenza paterna, ignorandone la sofferenza e la paura e accusando le madri di manipolazione di bambini e bambine contro i padri.
Quando le donne osano rendere pubbliche – tramite iniziative personali, di dimostrazione e protesta, ma anche di documentazione o di semplice divulgazione delle determinazioni giudiziarie negative e positive che ottengono – le già difficili e dolorose procedure che devono affrontare, sono ostacolate da una vera e propria campagna denigratoria della loro immagine pubblica e privata, che viene lanciata contro di loro da gruppi informali e non, che generalmente si muovono nella cornice argomentativa sessista del Men’s rights movement (Mrm, movimento per i diritti degli uomini).[2]
Così si pone il problema di gestire non solo il percorso giudiziario personale, ma anche di doversi difendere da ondate di odio che mirano nell’insieme a sfiancare, impaurire fino a zittire definitivamente.
Le fattispecie incriminatrici che di volta in volta potrebbero essere presentate all’autorità giudiziaria per chiedere un freno contro l’odio che si scatena sui social network, con il rischio concreto di aggressioni fisiche, si rivelano infatti armi spuntate, poiché vanno a costituire oggetto di denunce che vengono sottovalutate e, spesso, archiviate.[3]
L’ultimo e più recente caso che l’associazione sta osservando in diretta è l’attacco che Elena Cecchettin sta subendo sui social network dopo aver preso parola sul femminicidio della sorella Giulia, rappresentando i fatti per quello che tutte ci abbiamo letto, ossia l’ultimo atto, letale, di un continuum di violenza patriarcale che Giulia ha cercato di allontanare da sé a prezzo della vita, nell’incapacità sociale diffusa di riconoscere la violenza che, come ha ben sottolineato Elena Cecchettin, è manifestazione di potere diseguale nelle relazioni.
Ma Elena, lo sappiamo, non si fermerà e le onde, comprese quelle di odio, presto o tardi perdono forma e consistenza e si infrangono irrimediabilmente contro la fermezza e il coraggio della parola femminile.
Note
[1] Per approfondire il tema è utile consultare la relazione del 2022 della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio del Senato della Repubblica e il report del 2023 delle Nazioni Unite.
[2] Il movimento per i diritti degli uomini è un ramo del movimento maschile costituito da una serie di gruppi e individui che si concentrano su questioni sociali generali e su specifici servizi governativi che, a loro avviso, avrebbero un impatto negativo e in alcuni casi discriminerebbero strutturalmente gli uomini e i ragazzi. Tra i temi più comuni discussi dal movimento ci sono quelli legati al diritto di famiglia, come la custodia dei figli, gli alimenti e la distribuzione dei beni coniugali. Molti studiosi e studiose descrivono il movimento come una reazione contro il femminismo.
[3] Per esempio, nel caso di Laura Massaro, che da anni pubblicamente denuncia la vittimizzazione secondaria che le donne subiscono nei procedimenti di regolamentazione dell’affidamento dei figli, da denigrazioni continue della sua persona in quanto donna e in quanto madre, gli odiatori digitali sono arrivati anche ad auspicare la morte, a indicare le coordinate per localizzare geograficamente lei e la sua famiglia.
Ilaria Boiano
23/11/2023 http://www.ingenere.it/




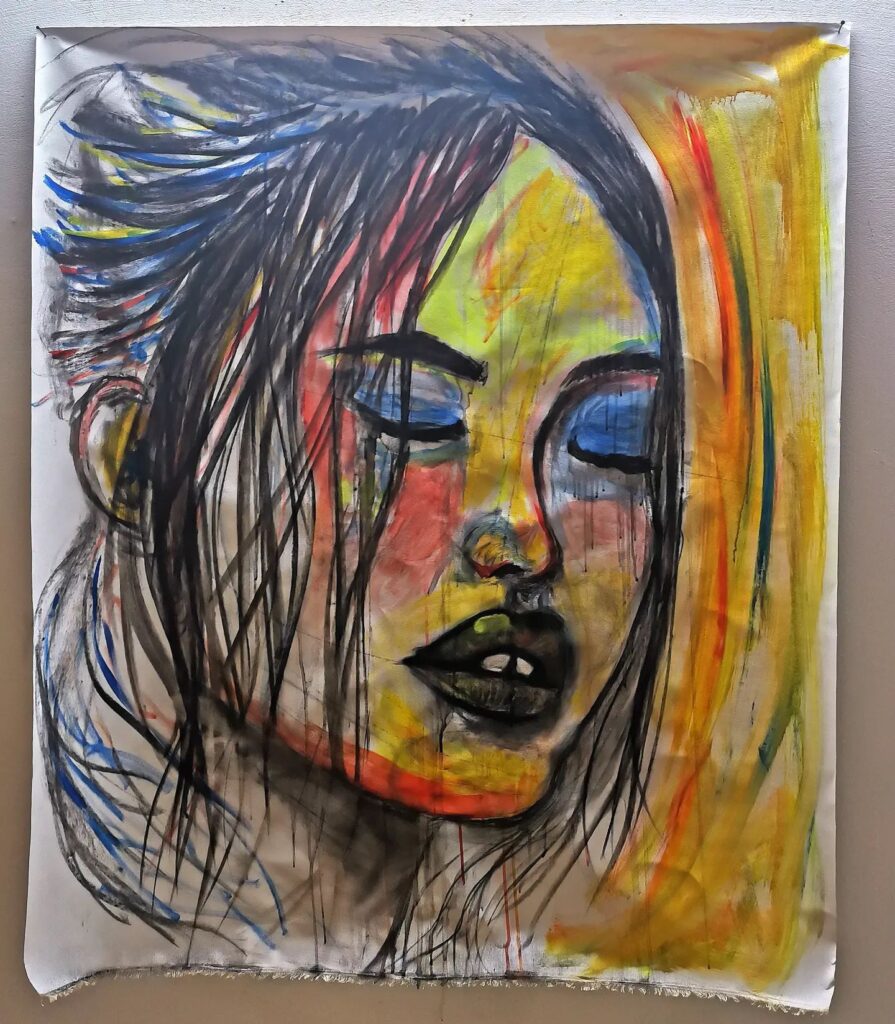




Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!