Economia, fisco, lavoro: nulla di nuovo sotto il sole
Come spesso accade in Italia per le cose che contano davvero, si sta parlando poco del cosiddetto “Piano nazionale di riforma” (PNR), una delle componenti fondamentali del Documento di Economia e Finanza (DEF), approvato in ritardo rispetto al calendario previsto dalle regole UE, ma importantissimo ai fini della definizione della strategia anti-crisi che il Governo dovrà presentare a settembre per accedere alle risorse finanziare che l’Europa dovrebbe mettere a disposizione.
Tutta l’attenzione mediatica, infatti, si sta concentrando in questi giorni sul cosiddetto “Decreto Semplificazioni” – il provvedimento con cui si dovrebbero sbloccare 130 opere di media e grande dimensione nel Paese –, che, nondimeno, costituisce una sorta di appendice del “Piano Nazionale di Riforma”, essendo la logica della liberalizzazione del sistema degli appalti (e di ciò che ne consegue per quanto riguarda l’ambiente e il lavoro) e quella delle grandi opere impattanti perfettamente in linea con la sua filosofia neoliberista e pro-business, solo goffamente camuffata con banali enunciazioni di principio sulla solidarietà, l’equità, l’inclusione sociale.
La prima nota dolente del documento è data dalla contraddizione tra l’esigenza di rilancio dell’economia e l’impegno, che fa seguito alle raccomandazioni di Bruxelles, di abbattere il debito pubblico con una nuova stagione di tagli alla spesa e di svendita di assets pubblici. Un piano di rientro decennale, per riportare i conti pubblici entro le soglie fissate dai Trattati. A ben vedere, un impegno folle, considerando il debito pregresso, i nuovi sforamenti del deficit fatti tra marzo e maggio (gli 80 miliardi) e i nuovi debiti che si contrarranno con il Next Generation EU e, eventualmente, con il MES. Lo chiamano “rientro”, si legge “austerità”.
Al secondo posto, tra gli obiettivi del Piano, troviamo la riforma del fisco. Una «riforma del sistema fiscale improntata all’efficienza, all’equità e alla progressività», si legge nel testo. Invero, l’ulteriore riduzione delle aliquote (siamo passati dalle 32 aliquote del 1974 alle attuali 5), per come è stata anticipata dal Governo, non potrà che favorire i redditi medio-alti. Che poi è quello che lo stesso Governo ammette, quando dice che la riforma servirà a «ridurre in particolare la pressione fiscale sui ceti medi». Un classico della cultura della destra: se si tagliano le tasse a chi ha di più, qualcosa sgocciolerà anche per i più poveri. D’altronde, per i ceti popolari, il problema non sono state mai le imposte sul reddito, ma il reddito stesso e il costo sempre più elevato dei servizi essenziali (rifiuti, acqua, luce, gas, trasporti ecc.).
Tra gli obiettivi, naturalmente, non poteva mancare la «produttività del lavoro», totem indistruttibile dell’ideologia che serve gli interessi del capitale, dietro il quale si fanno scomparire tutte le ragioni dei lavoratori in merito alle loro retribuzioni. La regoletta: il problema non è costituito dai bassi salari, ma dalla produttività del lavoro, che, proprio perché non cresce, tiene basse le retribuzioni. Eppure, la storia degli ultimi decenni, in Italia e nei Paesi più industrializzati, è stata un’altra. Si è assistito a una vistosa diminuzione della quota di reddito nazionale destinata ai lavoratori, benché la produttività del lavoro sia generalmente aumentata. Insomma, i capitalisti si sono appropriati di quote crescenti del valore prodotto dal lavoro. In altri tempi, avremmo parlato di maggiore sfruttamento del lavoro vivo. Perché l’Europa raccomanda all’Italia di “investire” nella produttività? Perché su questo terreno si tutela il profitto a scapito dei salari. Dunque il tema della produttività è in assoluto un tema sbagliato? No. Se lo sviluppo tecnologico e altri miglioramenti produttivi consentono di produrre più beni a parità di ore lavorate, si potrebbe lasciare più tempo libero ai lavoratori senza colpirli nei diritti e nella retribuzione, consentendo loro anche di andare in pensione anticipatamente. Il problema è che nello schema dominante, il mantra della produttività del lavoro serve solo a tenere il sistema in un equilibrio permanente di sottoccupazione, di precarietà e di bassi salari.
E poi le imprese, attorno a cui tutto ruota e tutto bisogna far continuare a ruotare. Incentivi, sgravi, meno tasse. L’impresa crea la ricchezza, l’impresa crea il lavoro, l’impresa ci porterà via dalla crisi. Il film degli ultimi trent’anni. Beninteso, l’impresa ha la sua funzione in una economia aperta come la nostra, peraltro tutelata dalla Costituzione. Ma, se da un lato ci sono ambiti in cui l’impresa non dovrebbe entrare (scuola, università, sanità, più o meno le “autonomie separate” di cui parlava J.M. Keynes), dall’altro si possono creare le condizioni per cui lo Stato imprenditore si sostituisca all’imprenditore privato. Soprattutto in momenti di crisi, di grave difficoltà dell’economia.
Quindi il Piano è tutto sbagliato? Tra le righe si può anche rintracciare qualche intervento positivo, come ad esempio il richiamo a una qualche forma di salario minimo. Ma è la filosofia d’insieme che ci tiene inchiodati, maledettamente, a questo eterno presente. Il problema è che il Covid-19 ha messo a nudo tutte le fragilità e le ingiustizie di questo nostro Paese. Dice bene Marco Revelli che questa pandemia ha funzionato come il luminol, facendo emergere tutto quello che non vedevamo o facevamo finta di non vedere nella nostra società. Il motivo per cui in tanti chiedono, chiediamo, una svolta vera. Un vero cambiamento di paradigma, affinché dalla crisi non si esca allo stesso modo in cui ci siamo entrati.
In pratica, quello che nella testa di chi ci governa purtroppo non c’è.
Eppure, basterebbero due o tre cose per cambiare registro.
Riforma del fisco? Certamente, ripristinando la progressività delle imposte e introducendo una tassa straordinaria sui grandi patrimoni, per redistribuire verso il basso la ricchezza del Paese, oggi maggiormente concentrata nelle mani di una minoranza, che con la precedente crisi anziché rimetterci ci ha guadagnato. Si aiuterebbe l’economia con una medicina nuova: la giustizia sociale.
Produttività del lavoro? Ma certo, per redistribuire il lavoro che c’è, riducendo l’orario a parità di salario, e per crearne di nuovo.
Inclusione sociale? Una priorità, istituendo un reddito di base incondizionato senza alleggerire lo Stato sociale. Perché barattando il sussidio con la diminuzione dei servizi del welfare si farebbero piombare i cittadini nella difficile condizione di dover scegliere tra carità di Stato e salari di fame.
Il debito? Sarebbe venuto il momento di porre la questione al centro del dibattito sul futuro dell’Europa. Anziché parlare di MES, bisognerebbe costruire un’alleanza europea per modificare l’attuale architettura dell’euro. Anche sui limiti dell’attuale modello di integrazione il Covid19 ha funzionato e sta funzionando come il luminol. Ha fatto emergere con più forza l’insostenibilità di un sistema che condanna gli Stati sovrani a un’eterna dannazione nel loro rapporto perverso, rovesciato, con i mercati finanziari. E con loro i cittadini, che pagano questo rapporto perverso con meno servizi, meno occupazione, meno opportunità.
Il guaio è che dal basso, ancora, non si muove granchè…
Luigi Pandolfi
9/7/2020 https://volerelaluna.it





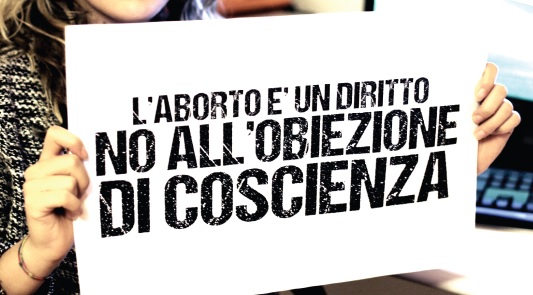




Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!