I buttasangue

Ne I buttasangue la crisi è la vera protagonista del romanzo: una crisi narrata in diretta, in prima persona, da un’anonima, ordinaria, invisibile vittima, trascinata nel tritacarne di questi tempi feroci. Non c’è pietismo o retorica nel raccontare le gesta convulse del protagonista che attraversa le pagine del racconto. Leggendo, più che dentro una crisi economica, veniamo calati dentro una grande trasformazione antropologica, che dissesta i territori, le comunità, la vita dei piccoli uomini che ne vengono travolti. È una crisi che non si misura solo attraverso gli indicatori economici: è crisi delle coscienze, rottura dell’etica collettiva, implosione del sistema di vita e di valori su cui tutti, per decenni, avevano fondato e giustificato le loro esistenze.
Il racconto si apre con una morte sul lavoro, il simbolo di un’epoca in cui “di lavoro ne girava tanto ed era normale che ogni tanto qualcuno ci lasciasse dentro una mano o peggio” e finisce con una carrellata dolente sull’Emilia terremotata , due anni dopo l’inizio della storia. “La bassa” a pezzi, tappezzata di attendamenti, è una buona metafora dello smottamento generale di senso in realtà già all’opera da qualche tempo dentro questi territori. Il terremoto, per certi versi, ha soltanto spinto sull’acceleratore della storia, così come era accaduto per il terremoto irpino del 1980 al centro del romanzo precedente dell’autore (G. Iozzoli, I terremotati, Manifestolibri, 2009 – Recensito su Carmilla). Proprio come in quel caso le scosse telluriche si rilevano presto anche un terremoto sociale. L’opera precedente presentava una galleria di personaggi condannati al fallimento, con il giovane adolescente protagonista costretto dagli eventi a rifugiarsi verso Nord, verso terre e comunità disposte ad accogliere il nuovo arrivato soltanto tra una marcatura del cartellino e l’altra. L’adolescente, irpino, che si trasferisce al Nord del romanzo precedente non è certo il protagonista, pugliese, de I Buttasangue, ma per certi versi ad essere la stessa è la storia di questo paese, la storia di chi fatica ad arrivare a fine mese e si vede crollare il mondo addosso, la storia di chi si guarda attorno e percepisce di non avere una comunità su cui contare, di essere un individuo senza relazioni vere e durature con altri esseri umani. È per certi versi il trionfo del motto thatcheriano: “La società non esiste. Ci sono solo individui”. Questi sono i risultati.
Antonio, il protagonista, operaio allo sbando, solitario e sfortunato, vive alla giornata in quella “diffusa officina padana”, un tempo orgoglio e perno delle comunità, oggi grande residuo meccanico malato, testimone occasionale della morte sul lavoro di un collega, dal giorno di quell’evento tragico, la sua vita sembra precipitare anche a causa dell’incontro con una ragazzina misteriosa che scombussolerà ulteriormente la sua esistenza. Su di uno sfondo in cui si collocano il cadavere del collega e la codardia davanti alle responsabilità aziendali, di cui è stato testimone, Antonio si trova catapultato in un tunnel senza via d’uscita popolato da sbirri, esorcisti, assessori e disavventure strampalate, incalzanti come un nodo che stringe alla gola, rappresentazione estrema di un mal di vivere che si manifesta nel dolore e nello spaesamento quotidiano diffuso. Ad essere narrata è la storia di un operaio costretto ad arrabattarsi per dimostrare la propria innocenza e tenere in piedi una parvenza di integrità, mentre intorno tutto crolla, un disgraziato in fuga da volantini, responsabilità sindacali, ragionamenti sul futuro, in cerca solo di sopravvivere in un mondo pericoloso che sembra inseguirlo e stringerlo all’angolo. In tale contesto sembra quasi che il protagonista avverta la necessità di una maggiore solitudine, di rifugiarsi in essa, di ritagliarsi uno spazio ed un tempo fuori dall’inospitalità del mondo. La tana, il mondo chiuso all’esterno, può essere l’abitacolo dell’automobile con cui girovaga senza meta la notte o l’abitazione: “E pensare che questo atto semplice di chiudersi dentro, e lasciare il resto del mondo fuori, qualche volta mi dava delle belle sensazioni […] girare quella chiave in faccia alla notte era un rituale che dava sicurezza, ti faceva sentire dentro un micromondo protetto, che ti eri costruito tu e che per 48 ore nessuno poteva disturbare.” Per certi versi, in alcune circostanze, la stessa stramaledetta fabbrica svolge una funzione di rifugio, tanto che, sul finire del libro, lo stesso Antonio deve ammettere a se stesso che: “Questa fabbrica l’ho sempre vista come una casa, un posto noioso e faticoso, ma dentro cui trovarvi riparo dalle cose brutte del mondo”.
Gli “anni buoni”, quelli del lavoro, dell’integrazione, delle speranze ingenue, sono ormai alle spalle, ed erano anni bugiardi, in cui la crisi, “come i brividi di freddo prima della febbre”, proiettava già la sua ombra minacciosa. Nel libro si racconta anche l’ultimo ciclo di emigrazione interna, il sempre più difficoltoso processo di insediamento ed integrazione, il cambiamento vorticoso di un tessuto di piccola provincia industriale violentemente modernizzata, in pochissimi anni, dai flussi economici globali. Il normale cittadino/operaio, eroe e protagonista della stabilità sociale, della coesione, del consenso dentro il modello emiliano, piano piano declina verso una condizione di precarietà e povertà, estraneità civica, rifiuto: quel cittadino operaio diventa il “buttasangue” (epiteto che il giornalista Giuseppe D’Avanzo aveva coniato per descrivere l’ultimo e più precario ciclo di emigrazione dal Sud); “butta sangue” come italianizzazione del “jetta ò sanghe” che è espressione universale di sofferenza, di mal di vivere, che la crisi esalta e amplifica, a partire dalla condizione migrante, per allargarsi alla stragrande maggioranza della società.
La crisi è ormai arrivata al Nord, accompagnata da una colonna sonora ritmata sui tragici botti delle scosse sismiche che hanno improvvisamente svelato il castello di carta su cui si fondavano questi territori: “Per i laboriosi locali, sarebbe stato molto più doloroso e complicato. Loro erano cresciuti con l’idea che c’era una morale, una specie di lieto fine, nella storia: lavori, lavori, lavori come un somaro dalla mattina alla sera per anni e anni, e risparmi, e sei un buon cittadino, e ti presti alla comunità, e alla fine sarai premiato. Questa era la convinzione che aveva spinto tre generazioni a chiudersi nelle officine da quando avevano quattordici anni. Tutti erano sempre stati convinti che il gioco valesse la candela.” Il terremoto ha presentato il conto, ha fatto crollare tante certezze costruite nel dopoguerra insieme alle case edificate “da generazioni di formiche infaticabili, mattoni, valore, patrimonio, ascesa sociale, stabilizzazione. E adesso sono chiuse, e i proprietari sono vecchi e dispersi – tra figli, parenti, sistemazioni di fortuna – e la grande epopea finisce con quei vecchi che come in un gioco dell’oca tornano alla casella di partenza, al freddo, alla precarietà, alla mancanza di ogni sicurezza – come un ritorno fasullo alla loro giovinezza, ma senza più energia, senza speranze, senza futuro. Quanta fatica, centinaia di milioni di ore di tornio, di fresa, di saldatura, di presse, di vernici – e commerci, edilizia, capannoni e centri direzionali di paese -, tutto frullato e fottuto in un semplice minuto.”
Sembra non salvarsi nessuno da questa deriva, il romanzo non risparmia nemmeno coloro che si prodigano in attività di “volontariato in divisa”, una sorta di ipocrita ed esibito tentativo di redenzione. Quegli abitanti operosi, cittadini perbene, colonne civiche della comunità che “si impegnano al massimo; un po’ perché sono brave persone; un po’ perché non c’hanno un cazzo da fare e questa è la situazione ideale per uscire dalla routine quotidiana […] con piena soddisfazione perché sanno di essere schierati dalla parte giusta, dalla parte del bene, e ci tengono a farsi riprendere dalle telecamere mentre esibiscono la loro scelta di campo. […] L’esercito del bene schiera i suoi reparti migliori per estrarre dal suo seno lo scandalo del male”.
Chi vive la crudezza della realtà dei nostri giorni, riconoscerà qualcosa di sé nella ricerca disperata e goffa del protagonista, alla perenne ricerca di una legittimazione, di un’integrazione, di una redenzione impossibile. Chi vive nei territori della storia, un luogo imprecisato tra la bassa modenese e quella mantovana, riconoscerà questo o quel personaggio, dentro la cartografia di facce e storie vere che il panorama propone. Sulla “bassa” presentata dal romanzo incombe davvero un cielo di piombo e, con questo, l’ispettore Callaghan ed i proiettili delle armi da fuoco non hanno nulla che fare. È una cappa che si è costruita e sedimentata in decenni di accumulazione e produzione forsennata, una cappa di piombo che sembra davvero non lasciare spazio a spiragli di luce in quelle terre che avevano sputato sangue anche pensando ad un sole dell’avvenire che all’orizzonte non sembra più poter far capolino. Qua è lo stesso orizzonte che sembra essere scomparso.
Il finale è aperto a interpretazioni diverse: il protagonista ha cominciato ad adattarsi ai tempi nuovi. La precarietà diventa quasi un’arma vincente. L’illegalità diffusa è un campo di battaglia. Il licenziamento può non essere il male peggiore, lascia capire l’ormai ex metalmeccanico: forse erano peggiori gli anni della produzione, dell’etica del lavoro, della sottomissione di officina. Eppure, mentre esibisce questo nuovo cinico ardore, traspare il rimpianto: puoi diventare spregevole e spietato, ma non puoi cancellare la nostalgia di ciò che poteva essere. Il racconto non svela quasi nulla della vita in fabbrica; le vicende narrate mostrano piuttosto come essa si propaghi al di fuori dei cancelli, come plasmi la vita del protagonista al di là delle otto ore, tanto che lo stesso romanzo, pur evitando la vita “dentro” l’officina, scandisce la narrazione titolando i diversi capitoli con altrettanti tipi e momenti di produzione: “Lapidatura”, “Rullatura”, “Rettifica”, “Maschiatura”, “Estrusione”… Paradossalmente se il luogo di lavoro può, in alcuni frangenti, anche dare conforto al protagonista, la sua vita al di fuori dei cancelli pare condannarlo ad un “fine pena mai” scandito da una colonna sonora che non conosce alternative al ritmato “produci, consuma, crepa” e quando si interrompe la “produzione ufficiale” perché le fabbriche chiudono, bisogna pur trovare nuove strade, ed a quel punto poco importa se lecite od illecite. Concludendo, Giovanni Iozzoli, con I buttasangue, sembra voler affrontare con le armi della narrativa, ciò che di profondo e terribile si cela dietro la “vita grama” dei tempi nostri.
Gioacchino Toni
Giovanni Iozzoli, I buttasangue, Edizioni Artestampa, 2015, € 16,00

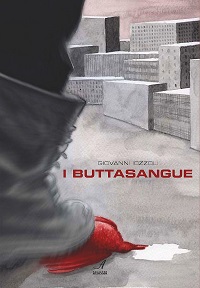
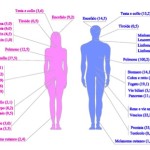

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!