Il gioco dello sfruttamento
La tendenza alla gamification è l’apice della fantasia neoliberista, trasforma il lavoro e il tempo libero per spingerci a produrre di più e costruire forme di classificazione e competizione permanente tra le persone
Una delle promesse del neoliberismo era che sarebbe stato in grado di creare un mondo del lavoro creativo e appagante, in cui i lavoratori e le lavoratrici non fossero più estensioni dei macchinari di fabbrica come lo erano stati sotto il taylorismo. I lavoratori erano immaginati come artisti e questi benefici sarebbero senza dubbio ricaduti anche nella vita personale di tutti. La tendenza alla gamification potrebbe essere l’apice del lavoro di fantasy rendering neoliberista con una serie di giochi fini a sé stessi che presumibilmente ci divertiamo a giocare.
Ma la gamification è uno schema vuoto – offerto da manager, economisti comportamentali, psicologi industriali e consulenti, nessuno dei quali ha in mente i nostri interessi – che ci distrae dalla fatica del lavoro e dall’infinito auto-miglioramento limitando le capacità umane che esso finge di sviluppare.
Il gioco e il lavoro
Quando si definisce la gamification, la maggior parte dei documenti accademici usa la stessa definizione: l’uso delle caratteristiche del game design in contesti non ludici. Ma che aspetto ha effettivamente quando viene messa in pratica? Ovunque sia stata implementata, la gamification è più o meno la stessa: una costellazione di avatar, nomi utente, badge, premi incrementali, barre di avanzamento e classifiche in cui le persone vengono classificate rispetto ai loro pari. Spesso è incluso un grado di interattività. Le persone possono progredire premendo pulsanti, spostando le leve, collegando punti, tirando su per aggiornare o qualsiasi altro movimento motorio adatto ai touch screen. Non tutte queste funzionalità devono essere presenti affinché la gamification sia tale, ma spesso si uniscono.
Tuttavia, mentre la «ludicizzazione» potrebbe essere una cosa inedita, l’introduzione delle meccaniche di gioco nel processo lavorativo precede di decenni la diffusione dei touch screen e del web. Nel 1979, Michael Burawoy scrisse di The Labor Process as a Game, descrivendo come i lavoratori avrebbero trasformato i loro lavori in una fabbrica in giochi per passare il tempo e rendere il loro lavoro più sopportabile. Burawoy cita Donald Roy, che descrive come l’introduzione di tariffe frammentarie – in cui gli operai venivano pagati in base alla produzione, non con una paga giornaliera standard – diede il via a una competizione implicita tra lavoratori non basata su quote o risultati ma su punteggi e risultati. I lavoratori in questione potevano esercitare le loro abilità sul posto di lavoro, come destrezza e resistenza, e un certo grado di incertezza e fortuna si aggiungevano al livello di eccitazione. «Non è tanto l’incentivo monetario che coordina concretamente gli interessi del management e del lavoratore, ma piuttosto l’azione stessa del gioco», scrive Burawoy, in una dichiarazione che col tempo è diventata solo più profetica.
Come mostra l’esempio sopra, la gamification non richiede necessariamente la tecnologia di Internet per funzionare, ma l’introduzione della tecnologia dell’informazione ha sicuramente aiutato la gamification a proliferare nei luoghi di lavoro. Ciò ha meno a che fare con la tecnologia dei videogiochi e più con il grado in cui la direzione può monitorare la velocità e la competenza dei dipendenti e quantificare le loro azioni.
Per attingere dalla mia storia di lavoro nei supermercati, ogni sistema di cassa contava quanti articoli ogni lavoratore scansionava all’ora, a volte al minuto, e a volte una classifica reale veniva posizionata in luoghi visibili ai dipendenti, consentendo loro di sapere esattamente dove si trovavano in concorrenza tra loro, in modo simile a varie app ludiche.
Un sistema analogo esiste nei luoghi di lavoro dei colletti bianchi: la produttività dei dipendenti può essere monitorata da vicino alle loro scrivanie, sia da Microsoft Viva che dal software di keylogging installato dalla direzione. Uno spirito di aperta competizione è meno diffuso in ambienti professionali come questi (con notevoli eccezioni), ma il fatto che si ricevano spesso aggiornamenti sulla propria produttività incoraggia non solo una competizione implicita contro altri dipendenti ma anche contro sé stessi, sempre alla ricerca di migliorare e ottimizzare.
Come era prevedibile, la gamification ha preso d’assalto la gig economy. TaskRabbit, Uber, Lyft e Airbnb hanno tutti incorporato le valutazioni dei consumatori nei loro sistemi su una scala da una a cinque stelle, di solito con qualche forma di demerito o vantaggio rispettivamente se gli utenti scendono al di sotto o superano una certa valutazione. I tasker con valutazioni e affidabilità dei clienti elevate, ad esempio, ricevono badge che li riconoscono come «élite» e preferenza nelle ricerche dei clienti, entrambi vantaggi in un campo così precario e competitivo. I tasker d’élite ottengono anche un supporto più attivo della comunità da TaskRabbit stesso e un invito a un gruppo Facebook esclusivo con altri come loro. Gli host di Airbnb che superano le 4,8 stelle e raggiungono la soglia di dieci ospiti all’anno vengono riconosciuti come «Superhost» e ricevono anche la preferenza nelle ricerche dei clienti.
Dall’altro lato, se la valutazione dei propri servizi è troppo bassa, le loro preferenze di ricerca ne risentiranno gravemente. E nel caso di Uber e Lyft, se la valutazione di un conducente rimane al di sotto di 4,6 per un certo tempo, perde l’accesso all’app. Per i gig worker di queste piattaforme, il sistema di valutazione dei consumatori è un promemoria onnipresente, il solo fatto che non abbiano un capo nel senso tradizionale del termine non significa che siano liberi dalla sorveglianza. Tutt’altro, le app della piattaforma tengono traccia di ogni movimento dei lavoratori e mappano i loro comportamenti, e la gestione è in gran parte scaricata sui loro clienti, con scarso supporto da parte delle aziende stesse se un lavoratore o un cliente ha un problema.
Ma questi sistemi di valutazione danno anche ai gig worker il senso di ricompensa così cruciale per la retorica della gamification. In un articolo sul Guardian, l’autista di Lyft Sarah Mason scrive che questi sistemi di valutazione dei clienti fanno leva sul «nostro desiderio di essere utili, di essere apprezzati, di essere bravi» e che, indipendentemente dal fatto che abbia una valutazione alta o scarsa, entrambi la mantengono più motivata a guidare per Lyft.
Oltre il lavoro
Ma la gamification non si esaurisce sul posto di lavoro. Si è diffusa da app per l’apprendimento delle lingue come Duolingo ad aiutanti come Fitbit. Per parafrasare Guy Debord, che a sua volta parafrasava Marx, tutta la vita si presenta come un’immensa accumulazione di giochi.
Su Duolingo, gli utenti non sono solo soggetti alle famigerate notifiche dell’app; sono inseriti anche in una graduatoria e classificati tra gli altri utenti. Se la propria posizione nella classifica di Duolingo non è abbastanza convincente di per sé, ci sono anche le notifiche relative alla propria serie di utilizzo dell’app ogni giorno, punti da raccogliere e avatar da creare per sé stessi. Fitbit incoraggia i suoi utenti a connettersi con persone che conoscono personalmente e competere con loro su cose come frequenza cardiaca, ore di sonno, passi registrati al giorno o distanza percorsa, corsa o bicicletta.
Anche se il discorso che circonda la gamification implica un’intrinseca somiglianza con i videogiochi, francamente non c’è molto che colleghi le due sfere. In effetti, la gamification rappresenta gli aspetti peggiori dei videogiochi con poco di positivo da trovare, se non niente.
Mentre i videogiochi hanno elementi della storia, scelte significative da fare e occasionalmente scelte grafiche interessanti, le convenzioni della gamification mancano di tutte queste cose. L’unico stile di progettazione grafica che si trova è la stessa estetica «Corporate Memphis» che permea tutto, dalle startup fintech alle pubblicità sui trasporti pubblici, e l’interattività offerta è solitamente bassa come fare clic su un pulsante, guardare una barra di avanzamento espandersi e ascoltare un effetto sonoro. La gamification è molto meno interessata ad affermare le nostre capacità ludiche che a sfruttare i meccanismi di assuefazione e dipendenza delle nostre menti. E piuttosto che concederci la libertà che i videogiochi mirano a creare, la gamification ci vincola all’interno di pochi movimenti e processi selezionati. I sistemi gamificati sono molto più vicini alle slot machine rispetto, ad esempio, a Red Dead Redemption 2.
Giochi senza divertimento
La gamification, sostiene Ian Bogost, non è affatto uno stile di game design. Piuttosto, «è uno stile di consulenza che prende i giochi come soluzione». Pone l’accento molto di più sul suffisso «-ificazione» che sul «gioco». Come scrive una coppia di luminari del business della Wharton School, la gamification consiste nel dare a un compito altrimenti poco piacevole una motivazione intrinseca, un senso di divertimento che ci fa desiderare di svolgere il compito fine a sé stesso. Gli operai dell’esempio di Burawoy sono più disposti a lavorare, e a lavorare più duramente del solito, se hanno una motivazione che va oltre il semplice guadagno di uno stipendio alla fine della settimana. Nel caso dell’utilizzo volontario di un’app gratuita come Duolingo, la gamification funziona per garantire che vogliamo continuare a prestarle la nostra attenzione, nonostante le critiche sincere secondo cui la gamification mina gli obiettivi dichiarati dell’app di acquisizione del linguaggio.
E infine, la presunta creatività che la gamification dovrebbe concederci è minata dal fatto che la creatività in questione è totalmente subordinata alla risoluzione utilitaristica dei problemi. I giochi sandbox come Zelda, Minecraft o il già citato Red Dead Redemption 2 consentono una vera creatività offrendo al giocatore una serie di strumenti e risorse e facendoli muovere liberi in un ambiente. Il divertimento più grande in questi giochi non viene quasi mai dalle missioni della storia, ma dal girovagare nei mondi aperti dei giochi. La creatività presumibilmente prodotta dalla gamification, come altre forme speciose di creatività nelle società neoliberiste economiciste, è quella di soluzioni creative o intuizioni creative nella propria vita personale o professionale. L’implicazione è che la creatività non è buona a meno che non sia utile o, meglio ancora, redditizia. Questa strumentalizzazione della creatività non è affatto specifica della gamification – l’istruzione soffre gravemente dello stesso problema – ma entrambi sono un sintomo della stessa economia neoliberista.
È chiaro che la gamification fallisce in diverse forme, ma dove ha successo? In poche parole: fornendoci avvincenti distrazioni. Sia che siamo al lavoro o nei nostri brevi momenti di svago, la gamification è sempre lì per garantire che non ci sentiamo mai negativi riguardo al compito da svolgere.
Nelle opere del famigerato pessimista Arthur Schopenhauer, i sentimenti negativi sono una costante minaccia esistenziale da cui dobbiamo distrarci con ogni mezzo necessario (Anche la «gamificazione dal basso» delineata da Jamie Woodcock e Mark Johnson si basa sul distrarre i lavoratori dalla miseria del loro lavoro. È ovviamente preferibile a quella che chiamano la «gamificazione dall’alto» offerta da Fitbit e dai nostri capi, ma è comunque una distrazione). Tuttavia, se la concezione di Schopenhauer fosse corretta, la gamification ci darebbe più di quanto ci serve per sentirci soddisfatti e realizzati, perché basterebbero semplici distrazioni per garantire la nostra felicità. Tutto ciò di cui avremmo bisogno è la mancanza di questa negatività fondamentale. Ovviamente non è così. Ciò di cui abbiamo bisogno, allora, è una concezione non dei sentimenti negativi e della loro negazione, ma del gioco e della sua affermazione.
All work and no play
Per una descrizione del gioco che non lo consideri come una mera distrazione dalla negatività, possiamo rivolgerci a un saggio che David Graeber ha scritto per il Baffler quasi un decennio fa. Graeber suggeriva che «esiste un principio di gioco alla base di tutta la realtà fisica», dal movimento casuale degli elettroni a gruppi di uccelli che volano in formazioni complesse senza un posto dove andare. «Il libero esercizio dei poteri o delle capacità più complesse di un’entità – dice Graeber – tenderà a diventare fine a se stesso». Cani che si rincorrono in un cortile, bambini che inventano giochi di ruolo assolutamente imperscrutabili per chiunque li controlli, stoner che ipotizzano esperimenti mentali senza alcuna applicazione nel mondo reale: sono tutti esempi di giochi intrapresi per nessun motivo se non perché qualunque entità stia giocando si diverte e ha la capacità di farlo. Piuttosto che crogiolarsi nel pessimismo schopenhaueriano, l’affermazione di Graeber conferisce al gioco un contenuto affermativo, una qualità che va ben oltre la semplice distrazione. Questo è il tipo di gioco che rende la vita degna di essere vissuta.
La gamification e il gioco differiscono in quanto il primo deve dare al dipendente o all’auto-ottimizzatore uno scopo unico. C’è un motivo per cui la persona sta svolgendo un’attività che è presumibilmente così sconvolgente da richiedere la gamification per renderla tollerabile, che si tratti di imparare una lingua, scrivere e-mail alla scrivania, esercitarsi o svolgere lavori umili. Il gioco, come abbiamo visto, non richiede alcun motivo se non l’abilità e il divertimento del giocatore. «Il gioco ha solo uno scopo interno – ci ricorda il filosofo tedesco Eugen Fink – non correlato a qualcosa di esterno a sé stesso». L’acchiapparella tra bambini ha uno scopo, ma questo scopo ha senso solo all’interno del processo di gioco e finisce quando suona la campanella della scuola. In modo simile, i suricati trascorrono molto del loro tempo lottando tra loro, portando gli zoologi alla conclusione che ci deve essere una ragione fisica o sociale più ampia per farlo. Ma finora gli studi hanno escluso che i giochi di combattimento dei suricati abbiano alcun effetto sulla loro coesione sociale, sui livelli di aggressività o sul loro futuro successo nel combattimento. Questo sembra suggerire che, in linea col pensiero di Fink e Graeber, i suricati stiano giocando per il gusto di farlo, e forse solo per questo motivo.
La gamification non può mantenere le sue promesse di creatività, realizzazione e divertimento. Per sua stessa natura, può solo distrarci da un compito che senza di essa sarebbe insopportabile: una soluzione inadeguata a un problema più complesso. Il gioco reale – attività svolta per nessun altro scopo se non quello di esercitare le proprie capacità – fornisce ciò che la gamification promette ma non può offrire.
Bill Peel scrive dal New South Wales, Australia. Il suo primo libro, Tonight It’s a World We Bury: Black Metal, Red Politics, è uscito di recente per Repeater Books. Questo articolo è uscito su JacobinMag. La traduzione è a cura della redazione.
1/7/2023 https://jacobinitalia.it




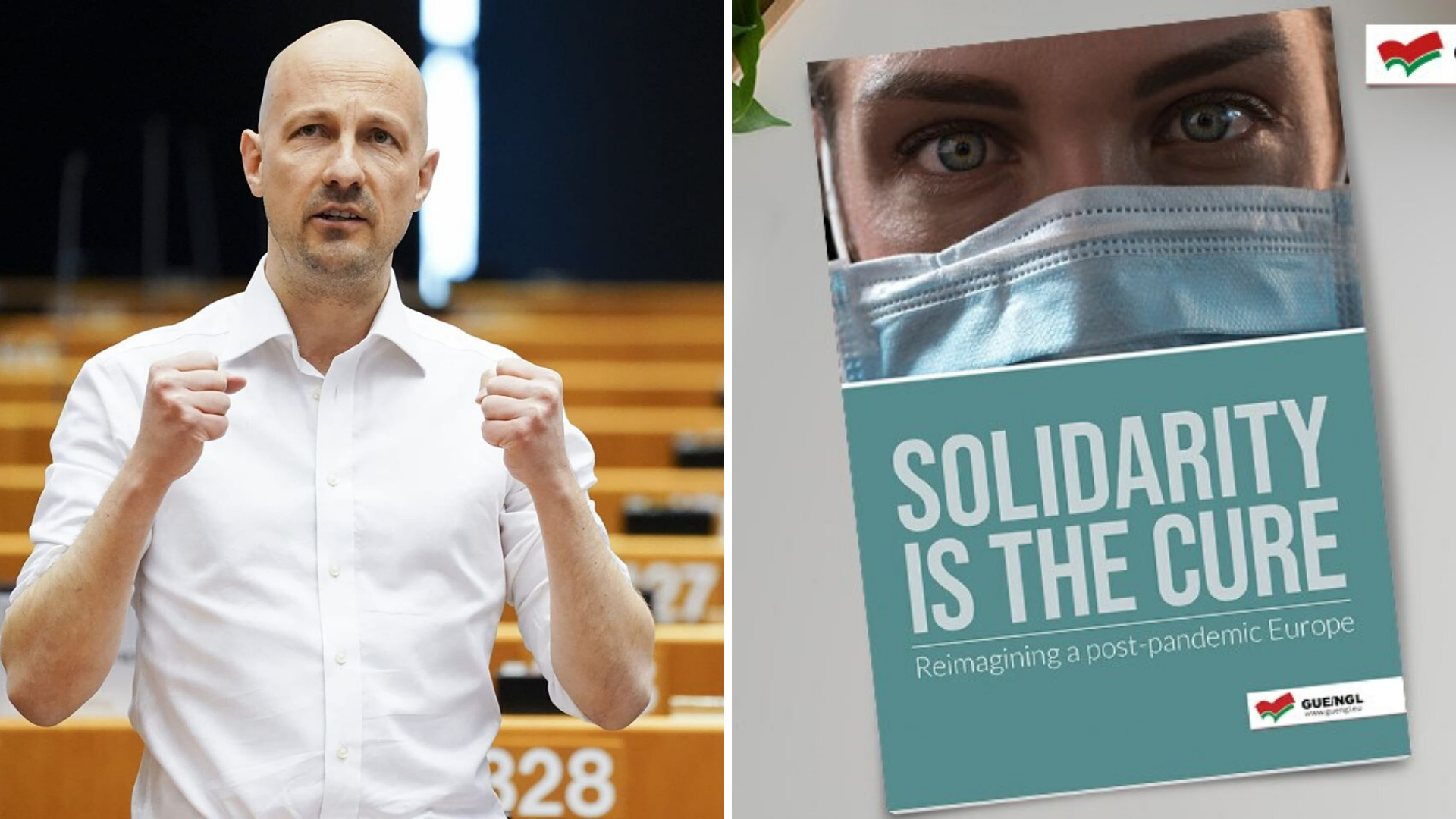




Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!