La casa come laboratorio. Finanza, abitativo e lavoro essenziale
La contesa attribuzione di lavoro essenziale, il lavoro improduttivo, le vite messe al lavoro o le “vite lavorate”, i corpi lasciati a casa e le case che prendono corpo, diventando luoghi privilegiati di estrazione di profitto, i terminali economici della finanza: nel libro La casa come laboratorio. Finanza, abitativo e lavoro essenziale, uscito per Tinta Limón esattamente un anno fa (2022), Luci Cavallero e Verónica Gago raccontano come la pandemia abbia normalizzato una nuova “domesticazione” che mette a valore la totalità della vita, attraverso l’implosione definitiva della distanza tra spazio pubblico e privato, produzione e riproduzione, e l’aggressione del debito familiare tramite la guerra mossa dai proprietari di case nei confronti dei locatari. Ne presentiamo un estratto, nella traduzione e cura di Maddalena Fragnito.
In queste pagine si ritrovano riflessioni importanti su come il capitale abbia approfittato della pandemia per intensificare lo sfruttamento dello spazio domestico. “Possiamo allora pensare che l’imperativo del telelavoro, della scuola e dell’ufficio confinati nelle case stia esacerbando la domanda di iperproduttività della casa-fabbrica”. Quindi la crisi pandemica non va intesa tanto come “sospensione generalizzata”, quanto piuttosto come acceleratore di logiche di profitto all’interno di alcuni specifici settori. Particolarmente significativo l’accento posto sul “modello di valorizzazione finanziaria applicato all’edilizia abitativa” che “si configura come una forma di estrattivismo dei territori urbani guidato dal capitale immobiliare in alleanza con il capitale finanziario. La finanziarizzazione della casa, sia nel mercato formale sia in quello informale, è uno degli effetti prodotti dalle manovre speculative degli investitori che collegano la rendita immobiliare con i circuiti della finanza globale”.
Quello che, nel frattempo, abbiamo vissuto è stato anche il progressivo smantellamento del settore pubblico, cosicché la salute pubblica si è trasformata in un problema di condotta individuale e il lavoro di mantenimento della vita è ricaduto sugli identici soggetti di sempre (donne, immigrati…). A distanza di pochi mesi dai processi descritti, immerse ormai dentro una concatenazione di crisi che sembra non finire mai, il quadro è talmente preoccupante da mostrare come la battaglia per il reddito incondizionato di autodeterminazione e per il potenziamento del Welfare sia sempre più uno snodo centrale per uscire dalle sacche del presente.
Traduzione di Maddalena Fragnito
[…]*
Essenzialità e remunerazione: due questioni separate
Ipotizzare che la casa abbia funzionato come un laboratorio durante la pandemia ci conduce direttamente alle domande che l’organizzazione e le mobilitazioni femministe hanno sollevato negli anni passati: come si calcola una giornata lavorativa che non ha durata fissa? Cosa viene “prodotto” all’interno della casa? Come si calcola il valore di questo prodotto? Chi deve pagare questo lavoro? Chi svolge i compiti di riproduzione? Come si riversa questo lavoro al di fuori delle quattro mura domestiche? Tuttavia, se partiamo dal presupposto che la condizione di possibilità del profitto capitalistico si basa sulla gratuità del lavoro domestico, la questione si sposta: non si tratta più di definire se il lavoro domestico produce o meno valore (perché ovviamente lo produce) quanto piuttosto capire perché è necessario che questo sia nascosto e costretto alla gratuità, ovvero capire quali dispositivi politici lo mantengono tale, di volta in volta. Infine, definire quali sono le strategie per il suo riconoscimento, la sua remunerazione e, soprattutto, la sua ri/organizzazione.
È importante qui ricordare che esiste un grosso dibattito sulla necessità di ripensare la “misura del valore” e la crisi della forma-valore associata al salario: riflessioni che ci permettono di discutere ciò che accade nel lavoro domestico contemporaneo. Sulla scia delle teorizzazioni femministe sulla dismisura (Morini 2010), diverse analisi hanno addirittura incorporato concetti come valore-affetto e valore-comunità per pensare altre forme di produzione di valore, per misurare altre modalità produttive, che eccedono quella del salario. La difficoltà di misura che si dà in certi ambiti non significa infatti che questi ambiti non producano valore. Potremmo allora dire che sono femministe quelle analisi che destabilizzano il calcolo e la misura secondo la razionalità del capitale. La “dismisura” che include forme di lavoro invisibile, non contabilizzato e persino la storia soggettiva delle oppressioni qualifica tanto il lavoro riproduttivo quanto il lavoro nelle periferie. In quanto eccedenza, questa dismisura esprime anche la potenza (indeterminata) del lavoro come lavoro vivo. In altre parole, i problemi a cui ci conduce il lavoro riproduttivo ci permettono di leggere le dinamiche generali del lavoro, connesse con la dinamica patriarcale-coloniale di precarizzazione e segmentazione della forza lavoro.
La stessa dismisura viene sfruttata dai dispositivi finanziari che si appropriano della ricchezza collettiva attraverso diverse forma di cattura. La finanza si incorpora nello spazio domestico, ovvero nel luogo in cui si pratica una “pedagogia microscopica” che è capace di riprodurre le nostre abitudini (Murard and Zylberman 1976). Secondo Toni Negri, sono due gli elementi in cui vengono elaborate all’interno delle case “le attitudini che diventano forme, e gli elementi architettonici che diventano macchine”. Dal punto di vista soggettivo, Negri sostiene che forme e macchine sono “la digitalizzazione della società e l’informatizzazione della città”. Entrambe rendono infatti “possibile lavorare a casa in una situazione in cui gli elementi architettonici e le reti comunicative sono innestati nel tessuto della stessa abitazione” (Tomasello and Negri 2015). Se l’”economia del debito” si esprime in diverse forme di guerra, per dirla con Maurizio Lazzarato ed Eric Alliez (2016), ci interessa allora riflettere sul modo in cui l’economia aggredisce la riproduzione sociale e stabilisce al suo interno un campo di battaglia. Questo perché lo fa anche attraverso una forma di conflitto tra soggettività che agisce sul piano della formazione microscopica e ripetitiva delle nostre abitudini, nella gestione quotidiana della vita caratterizzata dalla precarietà.
Negli ultimi anni, come effetto delle mobilitazioni di massa del femminismo, l’occupazione delle piazze è stato un aspetto fondamentale per “sconfinare” la casa, per criticarne i confini e confrontarsi con le forme di invisibilizzazione e privatizzazione delle attività che si svolgono al suo interno. Come sostiene Silvia Federici, il femminismo ha spostato il focus della spazialità produttiva: ha permesso di contabilizzare la durata della giornata lavorativa includendo le cucine e le camere da letto – e i quartieri e gli spazi comunitari, aggiungiamo noi.[1] In questa trama di spazialità laboriosa, si svolge il compito di riprodurre la vita: un insieme di lavori che mescolano l’autogestione con la scarsità delle risorse pubbliche, dispiegando compiti sociali che integrano e sostituiscono servizi pubblici carenti o inesistenti e, insieme, sostengono la forza lavoro sempre più precarizzata. Non è un caso che, all’interno di alcuni quartieri, troviamo case che si trasformano in asili nido per l’insufficienza del servizio pubblico; mense popolari che si estendono nello spazio privato perché incapaci da sole di coprire il totale della domanda; stand di fiere che vengono adibiti all’occorrenza in studi medici; riparazioni di strade e scuole che sono effettuate dagli abitanti stessi del quartiere e reti sociali che si professionalizzano per gestire la violenza di/del genere. Questo mondo del lavoro associato al “sommerso”, e spesso nascosto (tanto quanto lo spazio domestico stesso), è ciò che permette l’organizzazione della vita quotidiana anche nella crisi attuale. Una tipologia di lavoro sfaccettata e poliedrica, per lo più guidata da donne, lesbiche, persone trans e travestis,[2] che impiegano un’enorme quantità di lavoro gratuito, o appena retribuito, “non registrato” e precario.
Con la crisi accelerata dalla pandemia, gli stessi confini della precarietà sono diventati più labili. Il punto di non ritorno è stato marcato dalla “comparsa” di undici milioni di persone che hanno fatto domanda per ricevere gli aiuti offerti dal governo attraverso il cosiddetto Reddito Familiare di Emergenza (IFE).[3] Lo Stato aveva stimato di ricevere circa tre milioni di domande ma un quarto della popolazione del paese ne ha fatto richiesta (circa quattro volte le previsioni iniziali). L’IFE è un sussidio che si è aggiunto a quelli già in essere e che ha evidenziato forme di precarietà ancora non riconosciute come “povertà” negli indici standard impiegati dal governo. Questo ha mostrato la profonda ristrutturazione in corso della nostra capacità quotidiana di ottenere un reddito. L’IFE è stato tuttavia un terreno di lotta per il riconoscimento, e dunque la possibilità di accedere al sussidio, del lavoro domestico, uno dei settori più colpiti dalla quarantena,[4] storicamente sottopagato e il principale punto di ingresso delle donne nel mercato del lavoro.[5] La discussione su quali settori, lavori e attività dovessero essere aiutati durante l’emergenza non si pertanto è svolta in astratto, è stata bensì inquadrata all’interno delle lotte per il riconoscimento e la retribuzione dei lavori informali, precari e femminilizzati. Per queste ragioni, proprio a partire dagli usi della categoria di lavoro essenziale che si sono polarizzati durante la pandemia, ci domandiamo se si possa mappare una paradossale riqualificazione della crisi del lavoro salariato e una tendenza all’intensificazione del lavoro non o meno riconosciuto in quanto tale. Quali sono i corpi che sostengono il lavoro essenziale? E a quali costi (fisici e psicologici)?
Quando parliamo di lavoro riproduttivo ci riferiamo al lavoro svolto nei territori domestici, che non sono solo le case ma anche gli spazi di riproduzione collettiva, territoriale e di quartiere, moltiplicatisi a fronte dell’espropriazione sistematica che ha privato questi luoghi delle forme di sostentamento di base. L’attività svolta in questi territori domestici, che estendono il concetto dello spazio domestico, risponde alle urgenze quotidiane: dall’emergenza alimentare a quella sanitaria, dalla violenza di genere all’emergenza abitativa. Questo lavoro è svolto principalmente da donne, lesbiche, persone trans, travestis, piccoli agricoltori e migranti: lavorat* storicamente non riconosciut*, e disprezzat* nelle proprie capacità produttive, che tuttavia hanno conquistato il centro della scena durante la pandemia. Si è infatti definita essenziale la giornata di lavoro senza limiti, caratterizzata dalla disponibilità totale di fronte all’emergenza, dall’invenzione di risorse in mezzo alla scarsità e dall’uso di quei saperi accumulati nel tempo per sopravvivere alla spoliazione quotidiana. Questa essenzialità ha messo sullo stesso piano anche le lavoratrici della sanità e dell’istruzione pubblica, chi lavora nel sociale e chi svolge lavoro domestico.
Sul piano del lavoro riconosciuto, definito come produttivo e salariato, la categoria di lavoro essenziale ha invece portato a un conflitto sui criteri per la sua definizione. In Argentina, la rivendicazione di non essere lavorat* essenziali, promossa ad esempio da operai* di aziende che producono bevande alcoliche, snack e tubi per gli oleodotti, ha portato a un conflitto con quei datori di lavoro che non hanno mai concesso di fermare la produzione (Basualdo and Peláez 2020). In Cile e in Brasile, questa stessa battaglia si è connessa al ritardo e alla riluttanza dei governi di dichiarare la quarantena. Per citare un caso eclatante, la British American Tobacco cilena ha sostenuto di essere una produzione essenziale pur registrando un alto tasso di contagio tra i suoi lavorat*. In definitiva, quali voci rientrassero nella categoria di produzione essenziale e quali no è diventata una prova dei rapporti di forza tra aziende di affermare la propria capacità di lobbying, di affrontare quelle misure che obbligavano a non licenziare lavorat* per ottenere sussidi statali e persino di forzare accordi sui tagli salariali tra sindacati e datori di lavoro, tutto ciò all’interno di un retorico “quadro pacificato”. Un ulteriore momento è stato segnato da quei lavorat* essenziali che hanno richiesto condizioni di sicurezza e salute nei loro luoghi di lavoro, organizzando una traduzione del concetto di essenzialità in termini di diritti e di tutele. Questa richiesta è emersa particolarmente da quei sindacati che si occupano di lavoro nei campi della salute e dei supermercati.
Dalla prospettiva femminista sul lavoro, ci sono state due importanti battaglie. Anzitutto la richiesta di includere come essenziale l’attività di accompagnamento nei casi di violenza di genere, che implicava la necessità di effettuare spostamenti nel quartiere e nella città. Attività che è stata riconosciuta come essenziale nel giro di pochi mesi da parte del governo. Infine, la lotta per il riconoscimento dell’essenzialità del lavoro di cura svolto nei quartieri e nelle case private, che ha dato origine a slogan come “Siamo noi in prima linea” o “Siamo essenziali”. Tuttavia, la contraddizione che il nominare il lavoro di cura e di comunità come essenziale ha prodotto è complessa. In larga misura, questo lavoro è stato riconosciuto codificandolo in termini di abnegazione, eroismo o mandato di genere, in contrasto con il tipo di riconoscimento che il femminismo ha messo all’ordine del giorno in questi ultimi anni di mobilitazioni, dibattiti e organizzazione, rivendicandone diritti e salari e la necessità di una loro autorevolezza politica e territoriale. Di conseguenza, il lavoro essenziale condensa un forte paradosso: dà il nome a un processo di rinaturalizzazione di queste attività e dei corpi che se ne occupano, talvolta anche applauditi ma mai sufficientemente remunerati. Questo produce una distorsione: da una parte si parla di lavoro, dall’altra, proprio definendolo come lavoro essenziale, sembra non essere più un lavoro. Il suo valore viene quindi riconosciuto in termini sostanzialmente simbolici ed emergenziali.
Assistiamo su larga scala allo storico processo di naturalizzazione del lavoro riproduttivo esercitato in molti ambiti che, come abbiamo detto, includono l’istruzione, la sanità, tutte le tipologie di lavoro di cura, la produzione agro-ecologica, finanche rispondere al centralino telefonico per l’emergenza. La differenza è che, oggi, questo processo accade a cielo aperto e non più all’interno dello spazio confinato e nascosto delle case. Contestualmente, si assiste al “ritorno” alla casa sotto forma di espansione del telelavoro e di nuovi compiti riproduttivi di cura e di assistenza. Tuttavia, se da un lato si può leggere che l’accezione di lavoro essenziale legittima la gratuità e/o l’insufficiente remunerazione di alcuni compiti svolti nella spazialità dei territori domestici, dall’altro lato si possono anche leggere le stratificazioni delle lotte portate avanti dal femminismo: sarebbe stato infatti possibile collegare in modo esplicito il carattere essenziale dei compiti riproduttivi senza la previa politicizzazione della cura che i femminismi hanno messo in agenda negli ultimi anni? Da una prospettiva femminista, il lavoro eccede chi percepisce un salario perché evidenzia diverse esperienze comuni di sfruttamento e di oppressione, al di là della misura del salario e del terreno privilegiato della fabbrica. Ma anche perché evidenzia la subordinazione e lo sfruttamento di un’enorme quantità di lavoro necessario alla riproduzione del lavoro salariato, riconosciuto e sindacalizzato. Oggi più che mai non si tratta di optare per l’una o l’altra prospettiva, quanto piuttosto di tracciarne i circuiti.
In conclusione, siamo in un momento in cui il conflitto sulle forme del lavoro è fondamentale perché la tensione tra essenzialità-riconoscimento-retribuzione è l’agenda che i femminismi hanno messo al centro con gli scioperi internazionali degli ultimi anni. È un modo di organizzare le rivendicazioni sul lavoro che assume seriamente la sua definizione ampliata dai femminismi e che mette al centro la riproduzione sociale. In seguito all’accelerazione dei processi di precarizzazione della pandemia, le analisi femministe sull’impoverimento delle condizioni del lavoro salariato, domestico e migrante sono state tra le più accurate, sia perché hanno ampliato la nozione di lavoro (al punto da permetterci di comprenderne l’essenzialità) sia perché hanno incluso strategie sindacali per intervenire all’interno di questo allargamento.[6] Aver esplicitato la moltiplicazione della giornata di lavoro all’interno della stessa giornata, la fatica di mettere il corpo nella crisi – dal telelavoro in contemporanea con la scuola nelle case, al destreggiarsi con redditi che si riducono a ritmo d’inflazione, fino alla necessità di rimpiazzare il ruolo dello Stato con reti sociali richiestissime e scarse di risorse – ha allargato il campo delle lotte, evidenziando la quantità di lavoro gratuito e rivendicando riconoscimento e risorse che includono, e allo stesso tempo eccedono, la misura del salario.
Risulta dunque necessario ripensare la spazialità e la conflittualità del lavoro (i modi di intenderlo, misurarlo, renderlo visibile) per comprendere le dinamiche delle lotte, di resistenza e di contestazione, che si danno intorno alla produzione di ricchezza collettiva e alla cooperazione sociale – anche ora che la nozione stessa di lavoro essenziale sembra essere stata accantonata.
La casa-fabbrica
Ci interessa riflettere su come lo slogan “le case sono le nostre fabbriche”, utilizzato negli anni ’70 dalla campagna Salario per il Lavoro Domestico, si possa riconfigurare in un contesto attuale in cui la domanda di produttività si fonde con la casa stessa, producendo una vera e propria “casa-fabbrica”. Si tratta di una spazialità produttiva-riproduttiva che lavora nel domestico tutti i giorni della settimana senza limiti di orario, rielaborando a sua volta le forme storiche del lavoro domestico. Questo processo è tuttavia anche legato al divenire fabbrica dei territori, in un senso più ampio del domestico, come abbiamo nominato prima riferendoci ai “territori domestici”.
In Argentina, ci sono diversi studi pionieristici che mettono in discussione le definizioni del domestico. In questo senso, Elizabeth Jelin e María del Carmen Feijoó (1980), analizzando le unità domestiche dei settori popolari, propongono di pensare alla “domesticità” come a un concetto in movimento in base alle attività associate a questo ambito e alla loro divisione sesso-genere. Contestualmente, il lavoro di Paula Aguilar analizza la domesticità “come effetto complessivo di molteplici pratiche e discorsi, forme di problematizzazione, che convergono nella definizione di attributi morali, spazi sociali e compiti specifici come appartenenti ‘al domestico’”. La sociologa argentina si sofferma su un punto molto rilevante e si chiede se “esiste qualcosa come un modo specificamente neoliberale di rendere il domestico intelligibile, e quindi governabile, nella progettazione di politiche sociali nel quadro di una nuova questione sociale”. (2014: 12–15). A partire da queste riflessioni, è facile intuire come il capitale approfitti della crisi attuale sfruttando lo spazio domestico. Possiamo pensare che l’imperativo del telelavoro e della scuola e dell’ufficio confinati nelle case stia esacerbando la domanda di iperproduttività della casa-fabbrica? Inoltre, questa richiesta supererà la temporalità della pandemia? Infine, di case stiamo parlando? Stiamo parlando di interni con poco spazio, saturi di carichi familiari, che adesso devono essere produttivi attraverso attività che fino a qualche tempo prima venivano svolte negli uffici, nelle fabbriche, nei laboratori, nei negozi, nelle scuole e nelle università. Una richiesta di iperattività che arriva in un contesto in cui ci si muove sempre meno e in cui la mobilità è sempre più segmentata. In questo modo, il capitale minimizza i suoi costi: siamo noi lavorat* che paghiamo l’affitto e le utenze del “nostro” posto di lavoro, perché lavorare a distanza non richiede spostamenti, cosa che rende la nostra “disponibilità” ancor più scontata e flessibile. Ci offrono tariffe e crediti per “equipaggiarci” e le piattaforme digitali ci costringono a pagare un “abbonamento” o a fare contratti smart per poter lavorare meglio da casa. In questo panorama, le piattaforme di delivery garantiscono una logistica di consegna precaria e alimentano parte dei consumi di queste nuove case iperproduttive, che non hanno più tempo per occuparsi di bisogni primari come quello di cucinare.
Siamo state proletarizzate tra le mura delle nostre stesse case, con sempre meno aria a disposizione anche nello spazio pubblico. Non è un caso che durante la pandemia, in Argentina, sia stato fatto il conto delle ore di lavoro di cura domestico totali, dimostrando come questo “settore” si sia espanso più degli altri negli ultimi mesi.[7] Se si è parlato di una triplice giornata lavorativa svolta delle donne, lesbiche, persone trans e travestis (il lavoro retribuito, il lavoro domestico e il lavoro comunitario), è quasi impossibile adesso distinguere le ore in cui si svolge ciascuna di queste diverse giornate lavorative. Da una parte c’è un’indistinzione spaziale che mescola tutto insieme, dall’altra la giornata lavorativa non si è solo espansa in termini di ore, ma anche intensificata a causa del fatto che non ha più ambiti di separazione e che viene caricata di sempre più necessità e compiti. Ogni ora che passa è di per sé una tripla giornata lavorativa: mentre si telelavora ci si prende cura; mentre si svolge il lavoro comunitario ci si occupa della famiglia; mentre si lavora da casa si compilano pratiche per accedere alle forme di protezione sociale disponibili. Infine, si cucina. Per questo motivo, le case sono diventate i luoghi di sperimentazione di nuove dinamiche del capitale. Nella casa sembra essersi radicato un continuum del lavoro che sfida persino la divisione tra pubblico e privato alla base del mercato del lavoro tradizionale. La nostra ipotesi è che ci troviamo di fronte a una ristrutturazione dei rapporti di classe che ha come palcoscenico principale la sfera riproduttiva.
Passata l’emergenza sanitaria e i suoi momenti più estremi, i processi di flessibilizzazione del lavoro, che atomizzano ulteriormente chi lavora e che ci rendono ancora più precarie, non stanno regredendo. Al contrario, sembrano essere diventati la nuova norma. Lo confermano eecenti dati sulla ripresa dell’occupazione negli ultimi mesi del 2021, sottolineando come una parte significativa di tale ripresa sia caratterizzata da lavori sempre più precari.[8] In un recente articolo, Ursula Huws traccia un “circolo vizioso” piuttosto evidente che connette il lavoro di piattaforma con quello rinchiuso all’interno dello spazio domestico in cui si produce sempre di più perché c’è sempre più bisogno più denaro e, dall’altra parte, si ha sempre meno tempo a disposizione per le faccende domestiche, per ciò comprate attraverso delivery. Huws scrive che “alla ricerca disperata di soldi, lavoriamo sempre più ma ci accorgiamo di non avere più tempo per cucinare, mantenere la casa o occuparci della famiglia. Esaust*, ci rivolgiamo alle piattaforme di pasti pronti e a servizi di aiuto domestico e di assistenza. Si crea così una spirale negativa in cui la scarsità di denaro insegue la scarsità di tempo. Tuttavia, gli estremi non si incontrano mai e il capitalismo trae vantaggio tra un estremo e l’altro” (2021).
Pur sembrando contraddittorio, possiamo parlare di una forma di esternalizzazione della domesticità, anche se di fatto si tratta di una riqualificazione del luogo in cui i compiti domestici vengono esternalizzati mentre alcune dinamiche produttive, quelle tipicamente estranee allo spazio domestico, vengono internalizzate. Un problema spaziale e politico che chiede di tornare a interrogare lo spazio domestico e le sue riconfigurazioni. Ma andiamo oltre: a partire dalla casa, proponiamo di leggere ciò che accade nei circuiti di speculazione finanziaria più ampi. La nostra ipotesi cerca di analizzare le forme in cui il luogo di confinamento domestico è diventato spazio di valorizzazione finanziaria, e come questo processo si sia accelerato durante la pandemia. Invertiamo quindi la lettura dal basso verso l’alto: lo spazio della casa è diventato un “terminale” finanziario (verso cui si dirigono dispositivi di indebitamento, di intermediazione tra reddito e consumo e di estrazione tramite la riscossione dell’affitto) ma si è anche intensificato come luogo di produzione di valore (lavoro riproduttivo, telelavoro e nuove forme di lavoro a domicilio) sfruttato da diversi circuiti speculativi.
Vogliamo analizzare quella che ipotizziamo essere una domesticità sempre più sfruttata e precaria, trasformata da lunghi mesi di sospensione ineguale del reddito e degli affitti. Combinando in forme inedite lo spazio domestico con le tecnologie finanziarie, il meccanismo del debito evidenzia il paradosso tra il tentativo di risoluzione dell’emergenza (come indebitarsi per pagare l’affitto ed evitare uno sfratto) e l’aumento delle forme di estrazione del valore durante l’emergenza (come l’intensificazione dello sfruttamento e della governance del lavoro che verrà).
L’indebitamento della casa
Durante la quarantena, abbiamo sentito la necessità metodologica di pensare alla crisi pandemica non tanto come “sospensione generalizzata”, quanto piuttosto come acceleratore di logiche di profitto all’interno di alcuni specifici settori (Gago and Cavallero 2020). La speculazione immobiliare non solo non si è mai fermata, ma è anche aumentata in seguito alla crescita generale del costo degli affitti (sia nel mercato formale sia in quello informale) e all’incremento degli sfratti dovuti all’accumulo dei debiti da parte de* inquilin*. Questo processo si è intrecciato a quello di finanziarizzazione della riproduzione sociale descritto in precedenza. In questo senso, pensiamo che un aspetto centrale del divenire laboratorio della casa, e in particolare un laboratorio di intensificazione dell’esproprio tramite la riscossione degli affitti, è stato il risultato di due problemi: da una parte l’aumento dell’indebitamento domestico, dall’altra l’aumento del prezzo dell’abitare causato dalla deregolamentazione del mercato.
Il modello di valorizzazione finanziaria applicato all’edilizia abitativa si configura come una forma di estrattivismo dei territori urbani guidato dal capitale immobiliare in alleanza con il capitale finanziario. La finanziarizzazione della casa, sia nel mercato formale sia in quello informale, è uno degli effetti prodotti dalle manovre speculative degli investitori che collegano la rendita immobiliare con i circuiti della finanza globale. Ma come funziona questo meccanismo? Attraverso una serie di dispositivi intrecciati: 1) la necessità di indebitarsi per assicurarsi la proprietà di una casa in un processo di urbanizzazione; 2) l’aumento degli affitti e persino la loro “dollarizzazione” come effetto delle speculazioni sul suolo abitabile, vista l’assenza di uno Stato non ne regoli il valore a metro quadrato e il costo delle case; 3) la concezione dalla casa come “bene finanziario”, come titolo che viene comprato e venduto attraverso fondi di investimento, un processo ancora embrionale in Argentina; 4) gli sfollamenti e gli sgomberi per convertire determinate aree in nuovi investimenti immobiliari.
[…]
* Il testo, presentato qui nella traduzione italiana di Maddalena Fragnito, è tratto dal libro La casa como laboratorio. Finanzas, Vivienda y Trabajo esencial, Editorial Tinta Limón y Fundación Rosa Luxemburgo, Buenos Aires, luglio 2022
RIFERIMENTI
Aguilar, P. (2014) El Hogar Como Problema y Como Solución: Una Mirada Genealógica de La Domesticidad a Través de Las Políticas Sociales. Argentina 1890-1940 [online] Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. vol. 42. CLASCO. available from <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0252-18652015000200006&lng=es&nrm=iso&tlng=es> [17 July 2023]
Alliez, E. and Lazzarato, M. (2016) Guerres et capital. 1° edizione. Paris: Editions Amsterdam/Multitudes
Basualdo, V. and Peláez, P. (2020) Procesos de Conflictividad Laboral En El Marco de La Pandemia Del COVID-19 En Argentina (Marzo-Mayo 2020). FLASCO. available from <https://www.flacso.org.ar/publicaciones/procesos-de-conflictividad-laboral-en-el-marco-de-la-pandemia-del-covid-19-en-argentina-marzo-mayo-2020/> [17 July 2023]
Gago, V. and Cavallero, L. (2020) ‘Contra El Extractivismo Financiero: Extender La Cuarentena a Las Finanzas’. Instituto Tricontinental de Investigación Social [online] available from <https://thetricontinental.org/es/argentina/fp-cavalleroygago/> [17 July 2023]
Huws, U. (2021) ‘Un círculo vicioso que no se aguanta más’. [8 November 2021] available from <https://jacobinlat.com/2021/11/08/un-circulo-vicioso-que-no-se-aguanta-mas/> [17 July 2023]
Jelin, E. and Feijoó, M. del C. (1980) ‘Trabajo y familia en el ciclo de vida femenino: el caso de los sectores populares de Buenos Aires’. Estudios Cedes;3(8/9),1980 [online] available from <http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3477> [17 July 2023]
Morini, C. (2010) Per amore o per forza: femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del corpo. Ombre corte
Murard, L. and Zylberman, P. (1976) Le petit travailleur infatigable: ou, Le prolétaire régénéré : villes-usines, habitat et intimités au XIXe siècle. Recherches
Tomasello, F. and Negri, T. (2015) ‘L’abitazione del general intellect. Dialogo con Antonio Negri sull’abitare nella metropoli contemporanea’. [16 July 2015] available from <http://www.euronomade.info/?p=5228> [17 July 2023]
NOTE
[1] Non è un caso che durante il governo Macrista le operazioni di sorveglianza negli spazi di organizzazione e di potere politico dei quartieri si siano moltiplicate: https://www.pagina12.com.ar/397058-gestapomacrista-un-ejercito-de-espias-para-controlar-el-ter.
[2] Nota di (non) traduzione: mentre la parola “travestito” in Italia ha una connotazione più spesso dispregiativa, in Argentina il termine travesti è usato dalle soggettività stesse e dalle mobilitazioni collettive.
[3] In Argentina, l’IFE è stato il supporto economico erogato durante l’emergenza a lavorat* dell’economia informale, contribuenti unici sociali, contribuenti unici delle prime categorie, disoccupat* e lavorat* domestici: https://www.anses.gob.ar/informacion/ingreso-familiar-de-emergencia. Tuttavia, secondo il rapporto “Políticas públicas y perspectiva de género” della Direzione Nazionale per l’Economia, l’Uguaglianza e il Genere, circa 8,9 milioni di persone hanno ricevuto solo i primi due versamenti IFE: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/analisis_de_politicas_publicas_ppg_2020_.pdf.
[4] http://www.unla.edu.ar/novedades/estudio-de-la-unla-y-el-conicet-revela-que-apenas-un-tercio-de-las-trabajadoras-domesticas-sigue-cobrando-su-salario-en-cuarentena.
[5] In Argentina, circa 1,4 milioni di persone sono impiegate nel lavoro domestico in case private. Si tratta di un’attività svolta quasi esclusivamente dalle donne (99,3%) e concentrata in una fascia di età superiore ai 35 anni. In totale, queste rappresentano l’8,1% della popolazione che lavora del Paese e il 17,4% del totale delle donne impiegate.
[6] https://ctaa.org.ar/la-federacion-nacional-territorial-lanza-la-campana-somos-esenciales/.
[7] La Direzione dell’Economia, dell’Uguaglianza e del Genere ha presentato il rapporto “Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto”.
[8] https://ipypp.org.ar/2021/12/23/recomposicion-del-empleo-y-aumento-de-la-precariedad/.
Luci Cavallero, Verónica Gago
2/8/2023 https://effimera.org/




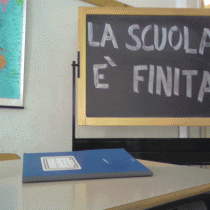





Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!