La violenza che zittisce le donne
“Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più sovversiva”, scrive Michela Murgia in Stai zitta. Una rilettura del suo libro alla luce dei più recenti fatti di cronaca per ricordarci che l’unico modo per smantellare il patriarcato è continuare a parlare
A Giulia Cecchettin, che sappiamo non sarà l’ultima.
In un libro molto bello di qualche anno fa, Michela Murgia descrive con la precisione e la ricchezza di sfumature che la contraddistinguono tutte le modalità in cui alle donne viene sistematicamente tolta la parola in ambito pubblico.
Stai zitta (Einaudi, 2021) andrebbe letto nelle scuole per la sua capacità di fare un inventario puntuale di situazioni in cui tutte ci siamo trovate almeno una volta, mettendo in fila le pratiche tipiche che vengono utilizzate per zittire le donne.
Si va dal brutale e schietto “stai zitta!” al ricorso a strategie in apparenza più sofisticate, ma in sostanza tese allo stesso obiettivo: sminuire le donne che parlano, non riconoscere loro autorevolezza, chiamarle per nome e mai per cognome (e men che mai menzionando il loro titolo di studio), riconoscerne il valore soltanto se scelgono di incarnare modalità di comportamento e di leadership tipicamente maschili.
Non ci sono donne ai vertici delle organizzazioni e delle istituzioni, dice Murgia. E quando ci sono (ad esempio ora che ci sono) sono donne sole al comando. Donne che ripropongono un modello di leadership basato sulla forza, che non mette in discussione il sistema e non prevede la decostruzione di un contesto patriarcale che penalizza le donne.
Sono donne che non fanno politiche per le donne, che non portano avanti i temi dell’agenda delle donne e dei femminismi: dall’attenzione alla salute, alle politiche riproduttive e alla definizione di azioni trasformative per il contrasto alla violenza di genere, a una visione della cura come paradigma di valori e alla genitorialità come valore sociale e condiviso.
Secondo Murgia, il sistema patriarcale concede di emergere soltanto alle “donne con le palle”, ovvero quelle donne che il sistema considera simili a sé e che mette in posizioni vicine al comando – raramente davvero di potere – in cui incarnano un ruolo di gestione e organizzazione di tutto ciò che serve per comandare: sono “vice” con una delega allle questioni organizzative più scottanti, delle relazioni necessarie, ma senza un reale potere trasformativo.
Se si azzardano a mettere in discussione il sistema, vengono espulse, riportate al silenzio.
Murgia ci ricorda inoltre che mentre i nostri giornali e le nostre trasmissioni televisive sono piene di “grandi vecchi”, negli ultimi anni solo tre donne hanno incarnato conoscenza e saggezza sulla scena pubblica italiana: Rita Levi Montalcini, Margherita Hack e Liliana Segre.
Così, se uomini poco più che mediocri possono continuare a distillare pillole di mansplaining fino alla tardissima età, senza accennare mai a un’ipotesi di pensionamento, a una donna oltre i settant’anni viene garantita autorevolezza e diritto di parola a vita solo in presenza di competenze o tratti biografici più che eccezionali.
Le donne possono ovviamente fare ma non devono rivendicare la soggettività delle proprie azioni, pena essere descritte e percepite come soggetti che turbano la quiete, guastafeste (in inglese, killjoy) come dice la scrittrice e studiosa femminista Sara Ahmed.
La scena pubblica ci insegna che le donne devono sempre saper stare al proprio posto. E anche quando escono dallo spazio privato, loro regno per eccellenza, è davvero molto raro che l’attenzione dell’opinione pubblica si focalizzi su quello che sono e fanno e non sul loro aspetto fisico o sulla relazione che hanno con qualche uomo (persino quando diventano la prima Presidente del Consiglio).
Le donne, continua Murgia, vengono costantemente percepite come esseri “relazionali”, cioè che esistono solo in quanto in relazione con qualcuno: di una donna si dice che è moglie, madre, sorella anche quando questo non ha nessuna importanza nella storia che stiamo raccontando su di lei.
Stai zitta è una fonte inesauribile di esempi e luoghi comuni che mostrano quanta violenza ci sia in quest’atteggiamento costante ed estremamente pervasivo di rimozione della soggettività femminile; quanto questa modalità violenta di ridurre le donne al silenzio permei al punto le nostre vite da sembrarci in qualche modo normale, accettabile, non irritante e fuori luogo quanto vedere, seppur raramente, un uomo ridotto al silenzio.
La continuità con cui, in ambito pubblico, è normale togliere la parola alle donne, farle tacere, è un elemento del contesto di predisposizione alla violenza sulle donne in cui siamo tutti e tutte immerse.
Se vi sembra un’esagerazione, fateci caso: guardate una trasmissione sulla Tv generalista in prima serata in un giorno qualsiasi e fate quello che ha fatto Murgia. Contate il numero delle donne presenti, guardate come vengono introdotte e come ci si rivolge a loro, quanto tempo riescono a parlare prima che un’altra persona vada sopra la loro voce.
E pensate che questo accade nonostante in questi anni – anche grazie a Murgia – siano cresciute la sensibilità e l’attenzione verso un maggior equilibrio di genere nella rappresentazione pubblica.
Ridurre al silenzio significa non soltanto non invitare le donne in qualità di esperte e/o non riconoscere l’esperienza che spetta loro nel caso in cui siano parte del dibattito, ma anche continuare a rendere difficili i percorsi di studio, a contrapporre le scelte di genitorialità a quelle di lavoro e di carriera – alzi la mano chi non si è sentita dire almeno una volta frasi del tipo: “ma a un certo punto dovrai scegliere tra il tuo lavoro e la famiglia?”; “non vuoi avere dei figli? Guarda che poi a un certo punto è troppo tardi. E una donna senza figli perde una parte importantissima della sua vita”.
Ce lo fa vedere bene Paola Cortellesi nel suo C’è ancora domani: nella Roma del secondo dopoguerra l’estrazione sociale della famiglia in cui si vive non conta. “Stai zitta, tu” è la frase che le donne si sentono dire ogni volta che tentano di esprime un’opinione, a maggior ragione se politica e in merito al diritto di voto, due ambiti decisamente “da maschi”.
E se c’è una possibilità di riscatto questa passa inevitabilmente per lo studio, che i ragazzini subiscono svogliatamente, non cogliendo le potenzialità di un’opportunità data per scontata, e che le ragazze vorrebbero e saprebbero invece sfruttare, ma che viene loro sistematicamente negata.
Ma è vero ancora oggi, a distanza di settant’anni dalla fine del dopoguerra: le cronache recentissime ci ricordano che basta davvero poco perché l’intimazione verbale a “stare zitta” possa trasformarsi in un atto violento in tutta la sua forza distruttrice. Ad esempio quando diventa una delle motivazioni profonde che portano un ragazzo poco più che ventenne a uccidere la persona con cui per un breve periodo ha avuto una relazione, colpevole, ai suoi occhi, non soltanto di voler vivere una vita libera e indipendente, ma anche di mostrare maggior talento e capacità di impegno, raggiungendo prima il traguardo degli studi.
Da sempre le donne pagano a carissimo prezzo il diritto di parola, nella migliore delle ipotesi passando per pazze – ce lo ricorda anche Viola Ardone nel suo Grande meraviglia (Einaudi, 2023): i manicomi sono stati per anni pieni di donne rinchiuse perché, fra tanti crimini di intraprendenza e libertà, hanno osato parlare; nella peggiore, venendo zittite per sempre.
Se il sistema patriarcale ci chiede di stare zitte, quindi, non possiamo che continuare a parlare. E se siamo in una posizione che ce lo permette, non possiamo che usare il nostro privilegio per creare spazi perché altre donne non debbano (più) star zitte.
Barbara De Micheli
22/11/2023 http://www.ingenere.it/

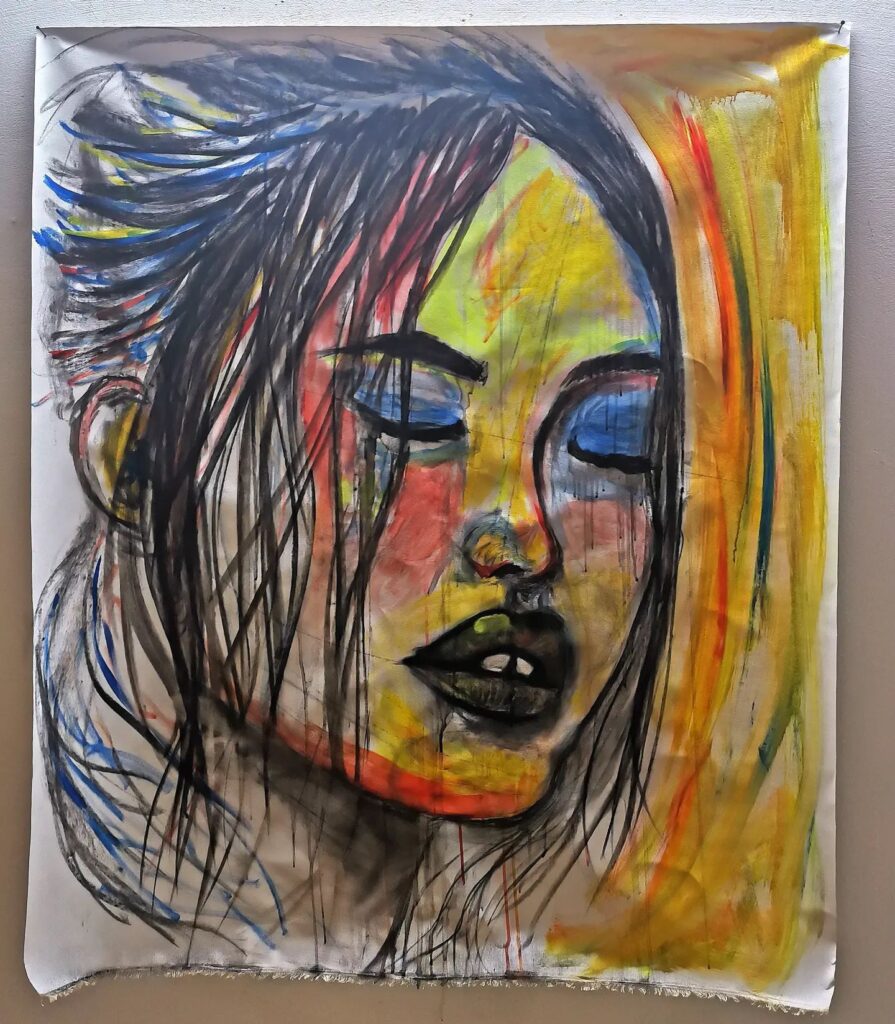








Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!