Le lotte delle invisibili

Il 20 ottobre 2021, una ventina di hostess Alitalia si sono date appuntamento per un singolare flash-mob in Piazza del Campidoglio a Roma per protestare contro le manovre di dismissione della loro azienda. Rimanendo sempre in silenzio, ma seguendo una coreografia di gesti ben concordata, si sono dapprima tolte con cura gli inconfondibili cappottini colorati e la classica divisa in tailleur gonna blu. Una volta rimaste tutte in sottoveste, si sono tolte il trucco e infine le scarpe col tacco che hanno lasciato in terra, andando via alla fine della protesta.
Attraverso espliciti richiami alle coreografie di strada utilizzate dal movimento femminista Non Una di Meno, con questa modalità di protesta le hostess puntano dritte all’essenza di un lavoro che, come dice Arlie R. Hochschild nel celebre saggio The Managed Heart del 1983, mette a servizio «il cuore» delle lavoratrici tramite una sequenza di tattiche di commercializzazione di comportamenti femminilizzati. Hanno detto basta all’obbligo di sorridere, di essere belle e gradevoli in qualsiasi condizione, dalla turbolenza in volo allo smantellamento dell’azienda per cui lavorano, con licenziamenti e riduzione degli stipendi. «Nude», nelle loro parole, davanti agli accadimenti.
L’invisibilità delle lotte delle lavoratrici
La protesta di lavoratrici è un fatto tutt’altro che nuovo: mobilitazioni di donne, incluse molto spesso donne migranti, hanno spesso attraversato piazze e posti di lavoro. In anni recenti, ricordiamo la vertenza contro Italpizza, iniziata a fine 2018 proprio da 9 donne straniere; nel 2015-16, la vertenza contro la Saeco ha visto le donne in prima linea contro processi di deindustrializzazione in aree pedemontane dove il lavoro industriale sta scomparendo, donne oggi nuovamente in lotta contro la chiusura annunciata dalla Saga Coffee dello stabilimento di Gaggio Montano; nel 2012 c’è stata la protesta delle operaie della Golden Lady.
E poi gli scioperi globali che dall’8 marzo del 2017 in poi invitano tutte le donne a lasciare il proprio lavoro – sia questo in fabbrica, nelle scuole o nelle case – per scendere in piazza contro il femminicidio gridando «Se le nostre vite non valgono allora ci fermiamo» e «Senza di noi il mondo si ferma». Sono lotte che portano assieme donne cis e trans con background diversi, concretizzando nelle pratiche di lotta l’ideale dell’«intersezionalità politica» di cui parla Kimberlé Crenshaw. Quella stessa frammentazione in classi, gruppi razziali, livelli di età ed educazione che l’organizzazione capitalista del lavoro divide e contrappone, ha trovato la sua ricomposione in piazze eterogenee ma unitarie.
Quello che osserviamo in questi anni non viene dal nulla. Eppure, le lotte delle donne sembrano cogliere sempre un po’ di sorpresa, come se fossero un fatto particolare, insolito. Tale mancanza di riconoscimento politico fa il paio con la difficoltà del lavoro femminile nella sua specificità di genere a trovare adeguato riconoscimento all’interno di una nozione neutra (e quindi implicitamente declinata al maschile) di classe operaia e lavoratrice (Alessandra Pescarolo, Il lavoro delle donne nell’Italia contemporanea, Viella, 2019). Ma fonti fotografiche novecentesche riportano alla luce con forza il lavoro delle donne nella sua materialità, all’interno delle fabbriche, nei campi e, più raramente, anche nelle case, come lavoranti a domicilio o domestiche.
In Italia, le donne lavoratrici hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo economico-industriale degli anni Cinquanta e Sessanta, non solo in comparti più tradizionalmente femminilizzati come il tessile-abbigliamento, ma anche in contesti produttivi dove la presenza delle donne era storicamente limitata come l’industria metalmeccanica. Proprio questo comparto era divenuto la prima fonte di occupazione per le operaie bolognesi e milanesi all’indomani del Sessantotto, con una crescita quantitativa che spiega perché le metalmeccaniche furono tra le più attive nelle lotte degli anni Settanta e le prime a creare strutture femminili di nuova concezione all’interno delle organizzazioni sindacali di riferimento.
La stampa politico-sindacale è però la prima a non riconoscere pienamente il contributo delle operaie o delle braccianti nelle imponenti lotte della fine degli anni Quaranta e Cinquanta, ricomprendendole in una nozione di classe operaia che non tiene conto dei corpi e della specificità delle mobilitazioni femminili. Le fotografie delle operaie durante i picchetti e le occupazioni delle fabbriche, spesso con al seguito figli piccoli o addirittura lattanti, sono emblema della tenacia di donne andate al di là dello stereotipo che le voleva più docili e meno sensibili alla propaganda sindacale. Giovanna, il primo film di Gillo Pontecorvo del 1955, esemplifica come il protagonismo delle operaie in lotta costituisse nell’Italia degli anni Cinquanta una rottura dei tradizionali ruoli di genere, mal vista non solo dalla controparte padronale ma anche da parte dei mariti delle stesse operaie, che per la prima volta si erano trovati alle prese con compiti di cura mentre le loro mogli occupavano la fabbrica.
Anche le operaie che occuparono le fabbriche nell’Autunno caldo del 1969 sono state difficilmente riconosciute e tanto meno messe al centro delle molteplici narrazioni che hanno ricostruito una delle fasi di maggior conflittualità sociale del secolo scorso. Una nuova soggettività femminile nei luoghi di lavoro balza agli onori della cronaca solo negli anni Settanta, in concomitanza con l’emergere sulla scena di nuovi movimenti delle donne e di rivendicazioni che affrontano il complesso nesso tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo. Se con delle pionieristiche conferenze, nel 1965 e 1967, l’Unione Donne Italiane pone al centro i diritti delle donne per un «lavoro stabile e qualificato» nonché per la salute sul posto di lavoro, negli anni Settanta operaie e sindacaliste danno un contributo fondamentale affinché nella più ampia riflessione sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro si tenga conto anche della specificità del corpo fertile delle donne. Ma una critica più radicale all’organizzazione (maschile) del lavoro viene portata avanti da sindacaliste e delegate che gravitano nell’alveo del cosiddetto femminismo sindacale, una riflessione che si svilupperà ulteriormente negli anni Ottanta in concomitanza con una rinnovata discussione sui tempi di lavoro e di vita, in relazione non solo al contesto della fabbrica ma anche della città.
Per rompere l’isolamento del lavoro di cura
Spostando lo sguardo dal lavoro femminile nell’industria a quello nel lavoro di cura e riproduttivo, la questione dell’invisibilità è certamente legata alle caratteristiche proprie di questo tipo di lavoro, da compiere nelle case e quindi in ambienti privati, chiusi in cui queste mansioni vengono svolte in solitudine. Con l’eccezione di alcuni esempi di collettivizzazione, l’isolamento caratterizza le mansioni riproduttive e di cura solitamente svolte gratuitamente dalle donne all’interno delle proprie famiglie, quella gratuità contro cui si battevano i Comitati per il Salario al Lavoro Domestico. Le stesse caratteristiche si estendono anche al lavoro domestico retribuito, quando questo viene assegnato a una persona esterna al nucleo familiare. Difatti, i processi di mercificazione che hanno modificato gradualmente l’ambito del lavoro riproduttivo non sempre hanno comportato la sua fuoriuscita dallo spazio domestico e privato. Ciò è valso per alcuni casi (l’accudimento di bambini nei nidi, l’assistenza ad anziani e malati in strutture residenziali, la preparazione di pasti nei servizi di ristorazione, ecc.) ma una gran porzione del lavoro di cura e riproduttivo continua ad avvenire all’interno delle case, con circa 2 milioni di persone attualmente impiegate in Italia per svolgere questi lavori. È quindi un lavoro assente, in senso fisico, da uno spazio pubblico e di condivisione.
A tale invisibilità in senso fisico è comunemente associata un’invisibilità anche sul piano discorsivo. Del lavoro di cura non si parla, è un «problema» privato, a cui ogni famiglia o persona trova soluzioni di tipo privatistico: i panni sporchi si lavano in famiglia. Tale assenza dal discorso politico vale anche quando si tratta di lavoro retribuito e svolto da una persona esterna alle relazioni familiari. Come questo lavoro è organizzato, retribuito o negoziato rientra nel rapporto spesso «a due» fra la donna che fa questo lavoro e colei che la paga per questo.
In ambito sindacale, la difficoltà nel raggiungere queste lavoratrici nel loro isolamento, per informarle e per farle entrare in contatto fra di loro, è sempre stata una sfida importante. Se, come si diceva, le lavoratrici donne erano generalmente rappresentate come un obiettivo difficile per la sindacalizzazione («the unorganizable»), ciò vale ancor di più per le lavoratrici domestiche. Non avere un luogo comune di lavoro con altre rende necessario attuare strategie organizzative in tempi e luoghi diversi da quelli tipici dell’attività sindacale. Le domestiche parlano dei loro problemi e si scambiano informazioni nel (poco) tempo libero. Si incontrano nelle piazze e giardini dove vanno a socializzare, davanti alle chiese dopo la funzione religiosa, a margine di feste e attività dove si recano con le proprie famiglie. Lo scambio continua online, tramite l’uso frenetico di Whatsapp e dei social per condividere appuntamenti, problemi e consigli.
Quella delle domestiche è un’attività di lotta che entra in ogni momento della loro vita, che crea un terreno di unione fra donne di tutte le età, soprattutto nel caso delle migranti (interne in passato, internazionali oggi) altrimenti isolate nelle città in cui sono arrivate per lavorare. È una mobilitazione che va oltre i problemi lavorativi in senso stretto e investe tutte le dimensioni della solidarietà fra donne, di fronte agli abusi, alla violenza sessuale, al razzismo, nella ricerca di un alloggio, nei problemi di salute, nelle difficoltà familiari ed economiche più vaste. È un attivismo che lega fra loro donne diverse in un mondo fatto di affetti, lotte, balli e canzoni. Non a caso, come nella canzone delle lavoratrici statunitensi di inizio Novecento, oltre al pane per le proprie famiglie, le lavoratrici chiedono anche rose, per loro.
Più di ogni altra cosa, ciò che unisce le domestiche attiviste è la lotta contro lo stigma associato al lavoro domestico, come lavoro «sporco», umile, servile, di cui vergognarsi. Diventare un’attivista per i diritti delle lavoratrici domestiche significa trovare il coraggio di rivendicare pubblicamente questo lavoro, di mostrarsi fiera di farlo, di farsi vedere amica e alleata di altre «serve». Ciò che può altrimenti costituire un ennesimo scoglio per l’attività sindacale e di organizzazione, il rifiuto di unirsi e mobilitarsi in quanto domestiche, diventa ragione di forza e identità. Oggi come ieri le attiviste domestiche portano nello spazio pubblico gli strumenti di quel lavoro di cui non bisogna vergognarsi più. Scope, secchi, grembiuli e guanti da cucina vengono sbandierati nelle piazze e davanti ai parlamenti. Stessa cosa fecero negli anni Cinquanta le casalinghe italiane per rivendicare il diritto alla pensione: le domestiche si vestirono tutte uguali, con gli stessi colori, per far vedere che, anche se quando lavorano sono sole, anche loro sono una massa, un gruppo grande e unito.
Le conquiste
Mentre negli Stati uniti possiamo datare il primo sciopero delle domestiche al 1881, con una protesta di lavoratrici afro-americane ad Atlanta, in Italia le proteste delle domestiche si intensificarono soprattutto nel secondo dopoguerra. Grazie a strategie di lotta dentro e fuori il parlamento, in alleanza con organizzazioni sindacali e associazioni religiose, le domestiche italiane hanno ottenuto nel 1958 una legge speciale per la loro categoria, prima assente, e nel 1969 un’importante sentenza della Corte costituzionale che rese possibile nel 1974 la prima stipula di un contratto collettivo nazionale (Beatrice Busi, Separate in casa, 2020).
Lungo tutto il percorso delle lotte delle donne, non manca il riscontro sul piano internazionale, anche in ambito istituzionale. In particolare, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Oil) si è attivata a più riprese per promuovere condizioni di lavoro più eque, per eliminare le discriminazioni che pesano più significativamente sulle donne, specie quelle con compiti familiari, e per proteggere specifiche categorie di lavoratrici. La Convenzione Oil n. 100 del 1951 sull’uguaglianza di retribuzione divenne un punto di riferimento a livello internazionale, rafforzando anche nel caso italiano le mobilitazioni per l’applicazione del principio della parità salariale, già contenuto nella Costituzione del 1948. Tra gli anni Novanta e Duemila le Convenzioni Oil hanno affrontato la specificità delle condizioni delle lavoranti a domicilio e delle domestiche. Nel 1996, dopo oltre un decennio di discussioni e mobilitazioni a livello globale, venne approvata la Convezione n. 177 che stabiliva la parità di trattamento tra lavoranti a domicilio e lavoratrici dipendenti, cosa che in Italia era garantita già dal 1973 con la seconda legge di tutela delle lavoranti a domicilio. Nel 2011, è stata promulgata poi la Convenzione n. 189 per i diritti delle lavoratrici domestiche attorno alla quale si coagula un movimento internazionale per la sua ratifica e implementazione.
Parlare di convezioni internazionali ci riporta a uno dei punti di partenza, ossia la battaglia delle donne lavoratrici contro la violenza e le molestie sul lavoro, una causa che non conosce distinzioni, che accomuna donne che lavorano in casa, in fabbrica e in ufficio. La recente Convezione Oil n. 190 sull’eliminazione delle molestie e violenze nel mondo del lavoro è stata ratificata formalmente dall’Italia lo scorso 29 ottobre, dopo l’approvazione da parte del parlamento italiano nel gennaio di quest’anno. Si apre quindi una nuova stagione di lotta per tutte le lavoratrici perché alla ratifica formale faccia seguito un intervento ampio e profondo per il contrasto alla violenza di genere in tutte le sue forme.
Eloisa Betti, Università di Bologna, è autrice di Le ombre del fordismo. Sviluppo industriale, occupazione femminile e precarietà del lavoro nel trentennio glorioso (Bononia UP, 2020).
Sabrina Marchetti, Università Ca’ Foscari di Venezia. È autrice con Daniela Cherubini e Giulia Garofalo Geymonat di Global domestic workers: intersectional inequalities and struggles for rights, (Bristol UP, 2021).
7/3/2022 https://jacobinitalia.it







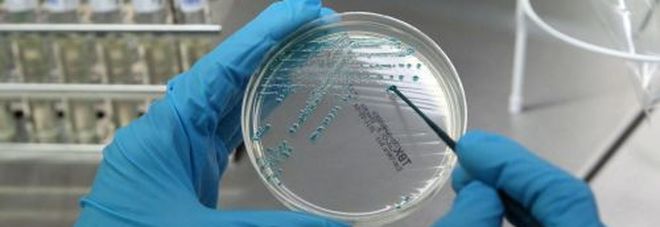


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!