Lavoro e Salute intervista Vittorio Agnoletto

In anteprima l’annuncio di un’importante iniziativa in sede europea
di Alberto Deambrogio – Collaboratore redazionale del mensile Lavoro e Salute
Vittorio Agnoletto non ha certo bisogno di essere presentato, la sua storia parla per lui.
L’impegno profuso in anni di attivismo politico e sociale sono la sua carta d’identità: medico del lavoro, impegnato nelle campagne di lotta all’AIDS e alle droghe, portavoce del Genoa Social Forum nel 2001, Europarlamentare, attivista NO-TAV, giornalista specializzato in tematiche sanitarie e d’inchiesta sui diritti negati a partire da quello alla salute, professore a contratto all’Università degli Studi di Milano dove insegna “Globalizzazione e Politiche della salute” …
si potrebbe continuare a lungo e con difficoltà si definirebbe con completezza il “prisma” del lavoro di Vittorio. Un militante “rosso ed esperto” a cui certo non è sfuggita l’importanza del tornante storico avviato dal diffondersi della pandemia da Covid 19. Da pochi giorni è in libreria il libro che raccoglie il suo enorme sforzo, portato avanti per mesi, teso ad accumulare materiali, informazioni, analisi e valutazioni intorno alla drammatica vicenda sanitaria e sociale che stiamo vivendo.
E’ intitolato “Senza Respiro” ed è uscito per i tipi di Altraeconomia e vi hanno collaborato Cora Ranci ed Alice Finardi dell’ “Osservatorio Coronavirus”, del quale Vittorio è responsabile scientifico, una struttura di servizio attivata da Medicina Democratica e da “37e2”, la trasmissione sulla salute di Radio popolare che Vittorio conduce da 5 anni.
I diritti d’autore ricavati saranno donati all’ospedale “Sacco” di Milano (struttura pubblica che svolge un importante lavoro di contrasto all’epidemia).
Abbiamo chiesto a Vittorio di rispondere alle domande che seguono. Lo ringraziamo per la disponibilità, nonostante la fatica e gli impegni di queste settimane.
- Collaborazione tecnica di Roberto Ciccarelli
Vittorio tu hai detto che “Senza Respiro” è un libro che non avresti mai voluto scrivere e invece l’hai fatto con un impegno personale gigantesco. Non è certo un instant-book fatto per guadagnare sul tema del momento. Ci vuoi dire che cosa ti ha spinto a farlo? C’entra qualcosa il fare memoria in un Paese come il nostro che tende a dimenticare tutto molto in fretta, comprese le faccende più gravi e dolorose?
È vero, avrei preferito non scrivere questo libro, perché racconta di un dramma e di una tragedia che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Ho pensato poi però che fosse mio dovere scriverlo, per raccontare quello che ho visto e ascoltato, per provare a ragionarci sopra e per avanzare delle proposte.
Gli obiettivi di questo libro sono forse ambiziosi. Il primo è quello di aiutare ciascuno di noi a non rimuovere quello che abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando. C’è una tendenza spontanea dentro ciascuno di noi, ma anche dentro i corpi sociali e collettivi, a cercare di rimuovere e mettere da parte quello che ci ha fatto soffrire e star male: è un meccanismo di difesa fisiologico e corretto, che ci aiuta a guardare in avanti; però c’è anche un altro meccanismo, più difficile, più complicato, più profondo, che però dà dei frutti importanti: è quello di rielaborare l’esperienza dolorosa – non da soli, ma con l’aiuto di qualcuno, collettivamente – per farla diventare un patrimonio dal quale partire e guardare in avanti. Il secondo obiettivo è quello di cercare di offrire una visione complessiva di quanto accaduto, mettendo in ordine anche cronologico i diversi fatti, mettendo in relazione gli episodi della vita quotidiana con leggi, circolari e delibere, sforzandoci di darne un’interpretazione per trovare un senso, fornendo una descrizione scientificamente e professionalmente corretta degli avvenimenti.
Poi c’è l’obiettivo di capire come tutto questo possa essere accaduto e quali sono le responsabilità: non c’è dubbio che il virus abbia fatto la sua parte, ma ci sono state anche grandi e gravi responsabilità umane che hanno favorito l’azione del virus, responsabilità che si sono assunti coloro che hanno il compito istituzionale, ai diversi livelli, di tutelare la nostra salute. Infine, l’obiettivo forse più importante: capire che cosa è accaduto e perché, comprendere cosa si potrebbe fare per evitare che una vicenda come questa si ripeta. Naturalmente avrei voluto evitare il ripetersi di questi fatti già adesso in autunno, ma guardo al futuro, in un mondo in cui purtroppo dovremo confrontarci con altre pandemie e con altri agenti infettivi: fare memoria di queste esperienze, capire cosa dobbiamo cambiare e per cosa dobbiamo lottare è importante per non farci trovare un’altra volta impreparati.
Io non sono un pubblico ministero e non è mio compito emettere sentenze, ma come membri attivi della società civile è nostro dovere esercitare un’analisi critica e un’attenta vigilanza sull’operato di chi ha responsabilità pubbliche, soprattutto quando questo impatta fortemente sulle nostre vite. Quanto abbiamo scritto in questo libro, i documenti che abbiamo citato – abbiamo naturalmente tutti i file con l’intera documentazione, anche quando le dichiarazioni, le segnalazioni e le denunce sono riportate in forma anonima per tutelare coloro che le hanno rilasciate – sono a totale disposizione dei magistrati ai quali ho intenzione di consegnare il libro.
Il libro è prefato da Lula da Silva. Certo è facile intuire un rapporto tra voi di lunga data, passato anche dalla stagione del Forum di porto Alegre. Trovo davvero significativo che ora, dopo vari rovesci e traversie, la sua voce torni a farsi sentire anche grazie al tuo lavoro; d’altro canto, così come l’ex vicepresidente Boliviano Alvaro Garcia Linera, egli pare capire molto bene il fatto che le sconfitte non sono mai definitive. Qual è il terreno di ricerca e lotta che Lula prospetta per questi tempi difficili?
Conosco Lula dai tempi del Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre e degli incontri avuti con lui all’interno del Consiglio Internazionale del FSM. Ho pensato di chiedere a lui di scrivere la prefazione perché una delle caratteristiche positive di Lula è sempre stata quella di riuscire a tenere insieme lo sguardo al cielo, alle stelle che indicano la strada anche di notte quando in montagna non devi perdere il sentiero, con lo sguardo a terra, al sentiero, per vedere se ci sono dei sassi e non inciampare: la sua capacità di far ballare lo sguardo dalla terra al cielo, dal cielo alla terra, di avere insomma un orizzonte globale che non finisce ai confini del peraltro immenso Brasile. Il secondo motivo è perché il Brasile è uno dei Paesi maggiormente colpiti da questa pandemia, e anche lì la potenza del virus è il risultato dell’azione del virus e della non azione e dei disastri del presidente Bolsonaro. Il terzo motivo è perché anche in questa vicenda ha sempre prestato attenzione a come la pandemia colpisce i diverse strati e le diverse classi sociali: se da un lato non c’è dubbio che il virus non guarda in faccia nessuno e può infettare ricchi e poveri, dall’altro non c’è altrettanto dubbio sul fatto che la possibilità di evoluzione dell’infezione alle fasi più avanzate fino eventualmente al decesso dipende molto anche dalle condizioni sociali, dal lavoro che si fa e dalla possibilità di svolgerlo da casa, dalle condizioni abitative e dalla promiscuità nella quale si è obbligati a vivere, dai mezzi di trasporto a propria disposizione… Questo virus aumenta le distanze sociali e aggrava le condizioni di difficoltà sociale e povertà di coloro che già vivono una condizione di povertà e di difficoltà sociale. Lula ha colto questo aspetto immediatamente.
Ci sono tanti passaggi interessanti nella sua prefazione, una vera e propria riflessione e non quattro righe di circostanza. Vorrei però sottolinearne due aspetti. Il primo è il riferimento immediato alle grandi istituzioni internazionali: si chiede perché l’ONU non abbia convocato un’Assemblea Generale straordinaria, anche virtuale, per coordinare gli sforzi mondiali per far fronte la pandemia; si chiede perché il Fondo Monetario Internazionale non stia concedendo prestiti agevolati ai Paesi che ne hanno una maggiore necessità. Restituisce insomma la responsabilità principale a quelle strutture internazionali che pretendono di governare il mondo, ma che nel momento in cui c’è un bisogno generale e collettivo si ritraggono oppure prendono decisioni – nel caso dell’FMI – sempre a favore dei più potenti. Il secondo passaggio vorrei citarlo direttamente: “Il futuro post pandemia non è garantito per nessuno, è oggetto di conflitto. Coloro che si affrettano ad annunciare il ritorno alla vecchia normalità si riferiscono con tale espressione alla piena restaurazione dell’iniquità di un passato ed un presente caduco, che la pandemia ha squadernato e ingigantito”. Questa è una grande consapevolezza che dobbiamo avere tutti: non si torna alla normalità tornando indietro, perché quella normalità è quella che ha permesso che accadesse tutto quello che stiamo ancora vivendo adesso. È quel modello di sviluppo, quel modello di sfruttamento della natura fatto di deforestazioni, allevamenti intensivi e cambiamenti climatici, ad aver favorito il passaggio di specie degli agenti infettivi con tutto quello che ne è conseguito.
Mi sembra inoltre importante anche la conclusione del discorso di Lula: “Riusciremo a cambiare, a far tornare a respirare ciascuno di noi e a far respirare il mondo, torneremo a farlo pienamente solo se sapremo aprire i nostri cuori, le nostre menti e le nostre orecchie, se sapremo riempire i polmoni di solidarietà e aprire la democrazia a nuove forme di partecipazione e azione politica che il secolo ventunesimo esige da noi e rende possibile.” Questo messaggio di speranza è anche quello che vuole dare il libro: facciamo tesoro di quello che è accaduto e vediamo cosa possiamo cambiare.
Aggiungo che questa pandemia ci fa ragionare su un tema che noi dei movimenti sociali e antiliberisti abbiamo sempre sostenuto: c’è un destino comune dell’umanità, da alcune situazioni si può uscire solo con uno sforzo collettivo. Se proviamo ad analizzare quello che sta accadendo durante questa pandemia, troviamo da un lato Paesi e Governi che, l’uno contro l’altro, corrono a fare la corte ai Big Pharma e alle grandi aziende farmaceutiche per prenotare in anticipo, ognuno per il proprio Paese, le eventuali dosi di vaccino. Trump ha addirittura prenotato alcuni farmaci lasciando sprovvisto il resto del mondo (ad esempio, ha prenotato la produzione di quattro mesi di questo autunno e inverno di Remdesivir, mettendo gli altri Paesi in ginocchio), ma anche i Paesi europei hanno ingaggiato una corsa l’uno contro l’altro per garantire se stessi, fregandosene completamente di quello che avviene e che avverrà, qualora dovesse esserci un farmaco o vaccino, in altre parti del mondo e soprattutto nel sud del mondo. Ovviamente i Big Pharma hanno giocato ad alimentare questa concorrenza, per cercare di massimizzare i loro profitti. Dall’altra parte abbiamo la solidarietà, ad esempio a Milano ci sono state le Brigate di solidarietà, composte da giovani dei movimenti, dei centri sociali e del volontariato che si sono messi a disposizione per andare nei quartieri popolari a portare il cibo e beni di prima necessità a chi viveva in difficoltà e isolamento. Abbiamo avuto anche la solidarietà internazionale: non dimentichiamoci che in Italia, in Lombardia, in Piemonte, sono arrivati i medici dalla Cina, dal Venezuela, da Cuba, dalla Romania e dall’Albania, Paese tra l’altro che è venuto in nostro aiuto nonostante quello che i nostri Governi passati avevano detto contro i suoi emigranti. Si tratta proprio di due modelli culturali opposti: uno che rappresenta il liberismo, Big Pharma e la concorrenza, e l’altro rappresenta invece la solidarietà e lo sforzo collettivo.
È bene sottolineare che l’atteggiamento dei Governi dell’Unione Europea sarebbe potuto essere totalmente diverso: potevano ad esempio – alleandosi con alcuni Paesi del Sud del mondo che già l’hanno proposto, come l’India o il Sudafrica – chiedere la convocazione straordinaria dell’Organizzazione Mondiale del Commercio per mettere in discussione gli accordi TRIPs sulla proprietà intellettuale e sui brevetti, che garantiscono il monopolio della produzione per vent’anni a chi arriverà per primo ad individuare un farmaco utile o un vaccino, con enormi profitti assicurati dato che potrà decidere il prezzo e, di conseguenza, quante persone potranno beneficiarne. In una tale situazione di emergenza globale si sarebbe dovuto mettere in discussione quegli accordi, ma non c’è stato nessuno sforzo in tal senso da parte del nostro Paese. Vige la logica per cui il più forte riuscirà a sopravvivere, gli altri periranno.
Dato che sono un medico, parlerei brevemente anche di alcuni aspetti di politica sanitaria: questa pandemia è arrivata quando il paziente stava già male, la sua salute e la sua condizione di benessere erano già state messe a dura prova ed era già in una fase critica. Non sto parlando della singola persona, ma del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che dal 1981 ad oggi ha subito tagli e attacchi da ogni parte (parlo del 1981 perché il nostro SSN è stato istituito con una riforma sanitaria dalla legge n°833 del 1978 come un servizio sanitario universale e gratuito, sostenuto dalla fiscalità generale in proporzione con i guadagni di ciascuno). Dunque, nel 1981 avevamo circa 530.000 posti letto, oggi poco più di 200.000: un taglio superiore al 50%, anche considerando che tra quei 530.000 c’erano circa 60.000 posti della psichiatria nei manicomi, per fortuna chiusi con la legge Basaglia. Negli ultimi decenni abbiamo assistito a un taglio concentrato sui posti letto e sulle strutture ospedaliere pubbliche, mentre contemporaneamente aumentavano le strutture private. Nel libro spiego che le strutture private, quando si convenzionano col servizio sanitario pubblico, scelgono i settori per loro maggiormente produttivi, per esempio la cardiologia, l’alta chirurgia, le patologie croniche: non sono minimamente interessate a gestire il pronto soccorso o i dipartimenti di emergenza, dove i profitti sono minori a fronte di uno sforzo organizzativo tecnologico e di personale molto alto.
C’è poi l’altro aspetto: la distruzione totale della medicina territoriale. Ad esempio, la medicina del lavoro all’interno delle ASL (che in Lombardia si chiamano ATS) è rimasta quasi solo una sigla, con il personale ridotto ai minimi termini… Sembra incredibile, ma in questi mesi in Lombardia la medicina del lavoro ha lavorato quasi unicamente tramite dei questionari, mandati ai dirigenti delle varie aziende, in cui si chiedeva se venissero o meno applicate le misure di precauzione all’interno dell’azienda stessa: è stata praticamente inesistente l’attività di sorveglianza intesa come andare fisicamente a vedere cosa succede nei luoghi di lavoro. Medicina territoriale vuol dire anche epidemiologia, per seguire l’andamento del virus, che è fondamentale per cercare di ridurne poi la velocità di diffusione, ma che oggi esiste solo nei corsi universitari, mentre è inesistente sul territorio. Un altro esempio è l’assistenza domiciliare con le USCA, cioè le Unità Speciali di Continuità Assistenziale messe in piedi all’inizio di marzo per fronteggiare il Covid, che avrebbero dovuto andare a casa delle persone positive ma con sintomatologia ancora ridotte, per fornire assistenza domiciliare, misurare l’ossigenazione del sangue, eventualmente somministrando farmaci di prima necessità o procurandosi velocemente una bombola d’ossigeno… Le USCA avrebbero dovuto essere una ogni 50.000 abitanti, ma in tantissime regioni sono un numero ridottissimo: in Lombardia ce ne dovrebbero essere 200 e ce n’è meno di un terzo. Sono stati inoltre completamente abbandonati a sé i medici di medicina generale che, sebbene siano il primo presidio sul territorio, sono stati lasciati senza Dispositivi di Protezione Individuale e senza istruzioni (ricordiamo a tal proposito che la Lega con Giorgietti, quando era Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha detto chiaramente che i medici di famiglia sono ormai assolutamente inutili e che andavano aboliti). Un altro aspetto importante riguarda il sistema di “alert”, ovvero quel sistema di allarme, che ogni Regione dovrebbe avere, composto da una serie di medici sul territorio che, nel momento in cui si verifica la comparsa di nuove patologie oppure un incremento abnorme di patologie già conosciute, effettuano una segnalazione alla Regione, che poi deve intervenire per capire cosa sta accadendo e prendere tutte le dovute precauzioni. Ebbene, oggi sappiamo che il virus circolava già a dicembre, tanto in Lombardia quanto in Liguria e probabilmente anche in altre regioni. Sappiamo che a Bergamo e non solo c’erano centinaia di polmoniti interstiziali già a dicembre e parecchie già a novembre. Mi risulta che queste segnalazioni siano state fatte: dove sono finite? come mai la Regione non è intervenuta? Abbiamo chiesto di poter intervistare i responsabili delle strutture nelle quali i medici hanno notato e segnalato queste polmoniti anomale, per chiedere loro a chi le hanno segnalate, a quali uffici regionali: a questi medici non è stato dato il permesso di parlare con noi. Ecco, noi abbiamo documentato e spiegato tutto ciò, e pensiamo che debba intervenire la magistratura perché qui ci sono responsabilità enormi che, a mio parere, sfociano anche in responsabilità penali. Nel libro raccontiamo tutto.
Questa riduzione dei posti letto ospedalieri, questa distruzione della medicina territoriale si inserisce all’interno di una logica per cui la medicina è tutta orientata sulla cura e, in particolare, sulla cura di alto livello. In Lombardia questa tendenza è estremizzata, ma è una tendenza nazionale ed europea, per cui se c’è la necessità di una visita o un controllo, oggi (ma anche in epoca pre-Covid) ci si trova davanti a liste d’attesa di mesi e mesi, a volte si arriva anche a un anno. Una tale forma di medicina è totalmente disarmata di fronte a un agente infettivo che si trasmette con dei comportamenti umani, perché considera la medicina territoriale una medicina di serie Z, poco utile e poco interessante. A tutto ciò bisogna aggiungere il fatto che il SSN ha attivato tutta una serie di costosissime convenzioni con strutture private (in Lombardia il 40% della spesa sanitaria pubblica va a strutture private convenzionate). Il privato convenzionato però si comporta come qualunque altra azienda privata: per loro più ci sono malati, più aumentano i profitti. La struttura sanitaria pubblica invece dovrebbe ragionare esattamente nel modo opposto: più c’è prevenzione, meno persone si ammalano e più c’è risparmio di soldi pubblici. Il dramma è che, in Lombardia ma non solo, la struttura sanitaria pubblica ha interiorizzato e fatto sua la logica del privato e quindi gestisce la sanità pubblica come se fosse un’azienda privata, finalizzata a costruire profitto sulla cura e ignorando tutto quello che è prevenzione, sorveglianza sanitaria ed epidemiologia. Oltre alle strutture convenzionate, abbiamo poi tutte le strutture sanitarie strettamente private e non convenzionate (spesso è una stessa struttura privata che decide di convenzionare alcuni settori convenienti, da un punto di vista del potenziale profitto, e di mantenerne altri totalmente privati) che non hanno partecipato e non stanno partecipando minimamente allo sforzo generale nazionale contro il coronavirus. Anzi, da questa tragedia stanno traendo profitti enormi, perché per mesi e mesi alcune regioni hanno stabilito che, oltre ai pazienti Covid, venivano assistiti solo i pazienti che avevano bisogni urgenti, sospendendo tutte le altre visite ed esami. Ecco, tutte queste altre persone, o almeno coloro che, avendo soldi, potevano permetterselo, dove andavano? Al privato, e gli altri rimanevano senza assistenza. E qui si configura un altro problema: in questa situazione di emergenza bisogna avere il coraggio politico di obbligare queste strutture ad entrare dentro lo sforzo collettivo e, se non ci stanno, a requisirle, cosa che non è assolutamente stata fatta.
Un altro problema, ben precedente al Covid, è la defiscalizzazione delle assicurazioni private sulla sanità e il loro inserimento all’interno dei Contratti Collettivi Nazionali, un vero e proprio disastro su cui mi auguro che i sindacati ci ripensino: significa portare centinaia di migliaia e forse milioni di persone fuori dal servizio sanitario nazionale e dentro una logica assicurativa. Il rischio che si corre è quello di intraprendere la strada che ci porta al modello sanitario statunitense, per cui l’assistenza sanitaria dipende da che assicurazione hai sul luogo di lavoro: chi non ha un lavoro in una grande azienda con un contratto a tempo indeterminato, non ha l’assicurazione sanitaria e ha solo l’assistenza sanitaria di base. È ciò contro cui si sono battuti Obama e i movimenti americani e noi, che avevamo il Servizio Sanitario Nazionale, stiamo andando proprio in quella direzione.
La vicenda del Covid 19 ha messo a nudo le storture portate avanti da quasi 40 anni di controriforma sanitaria. C’è un pubblico che resiste, a volte quasi per inerzia, uno Stato che fatica enormemente a porsi all’altezza della situazione e un sistema regionale pure incapace di fare il suo mestiere; su tutto domina la tragica dialettica negativa tra i due livelli. Si mettono a disposizione alcune risorse in più per la salute, ma manca una visione complessiva in grado di parlare un linguaggio nuovo. Nessuno, tanto per fare un esempio, mette in discussione il sistema dei fondi, del welfare aziendale, dello spazio al privato. Tu nel libro dedichi un ampio spazio ad una possibile riforma complessiva. Come pensi sia possibile creare un movimento generale, anche partendo da elementi confusi, particolari, da sprazzi di ribellione, in grado di porre questioni vitali (diritto alla salute, suo nesso con modelli produttivi ecc.) per un ampio spettro sociale? Non è forse questa l’occasione per democratizzare le politiche sanitarie, fuori dal mito ampiamente falsificato del decentramento regionale?
Dobbiamo riuscire a costruire una grande vertenza nazionale per il diritto alla salute. Dobbiamo riuscire a tornare a un Servizio Sanitario Nazionale universale e gratuito, sostenuto dalla fiscalità generale in relazione ai guadagni e ai profitti di ciascuno, un servizio sanitario fondato anche sulla partecipazione della popolazione, perché gli eventi problematici dal punto di vista sanitario che noi dovremo affrontare nel prossimo futuro e nei prossimi anni saranno sempre più simili a quelli che stiamo vivendo in questi mesi. Un’epidemia che si trasmette attraverso dei comportamenti umani ha bisogno della partecipazione delle persone, della consapevolezza, della formazione, di uno sforzo collettivo: c’è bisogno di ripensare anche la medicina, che non può essere sempre solo delega agli specialisti. Abbiamo la necessità di avere maggiori finanziamenti per il servizio sanitario nazionale, ma non è sufficiente: bisogna discutere dove questi finanziamenti vengono allocati e quali sono le priorità. Queste priorità vanno modificate, l’abbiamo detto. Probabilmente oggi le condizioni per costruire un grande movimento ci sono perché l’insieme della popolazione italiana ha sperimentato e sta purtroppo sperimentando su se stessa che cosa vuol dire avere un servizio sanitario che ha trasformato la salute in un profitto, il nostro corpo in una merce a disposizione di interessi privati nelle mani ovviamente di pochi. Serve una vertenza nazionale per ottenere che i LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza, siano sempre e comunque garantiti dal servizio sanitario pubblico.
Questa pandemia, inoltre, testimonia il fallimento totale della richiesta di trasformare la sanità in una materia di pura titolarità regionale: durante i mesi più critici è stato necessario lo sforzo nazionale e il supporto di una regione con l’altra; come dicevo prima, siamo addirittura dovuti ricorrere a medici che arrivavano dall’altra parte del mondo. Questa pandemia testimonia che il servizio sanitario deve essere nazionale.
Per quanto riguarda la Lombardia, è doveroso ricordare che, quando è arrivata la pandemia, si stava già sperimentando un altro passaggio di privatizzazione: la Regione Lombardia ha tentato di privatizzare tutto quello che riguarda le patologie croniche, invitando 3.150.000 cittadini (sui 10 milioni della Lombardia, ovvero tutti coloro che soffrono di patologie croniche) a sottoscrivere un contratto privato con dei “gestori” – la maggioranza dei quali assolutamente privati (abbiamo trovato per esempio fondi finanziari con sede negli Emirati Arabi, in Sudafrica, …) o con grandi cooperative di centinaia di medici che si stanno trasformando in aziende vere e proprie – affidando loro la gestione delle loro patologie croniche, espropriando di tutto questo il loro medico di medicina generale che a sua volta è invitato a entrare a far parte di questi gestori. È una campagna che la Regione Lombardia ha lanciato ormai da oltre due anni ma, grazie lo sforzo di tantissime associazioni, Medicina Democratica in primis, sono riusciti a coinvolgere solo il 10% delle persone con patologie croniche; ci fa tuttavia capire che cosa intenda la nostra Giunta quando pensa all’autonomia regionale nella gestione della sanità, ovvero la totale trasformazione della salute in oggetto di mercato e la sua consegna al capitale privato. Oggi esce rafforzata l’opinione di chi sta difendendo il Servizio Sanitario Nazionale.
Durante questo periodo molto complicato è emersa sempre più chiaramente per molti la divaricazione tra produzione e riproduzione sociale complessiva. Su questo fondale si possono rintracciare altre contraddizioni notevoli, certo non nuove, ma rese molto evidenti dentro la crisi. Te ne propongo all’attenzione due.
La prima riguarda il terreno spinosissimo del rapporto non lineare tra tecnoscienza, potere, capitale, informazione: ne abbiamo viste e sentite delle belle non credi?
Un altro aspetto molto triste al quale abbiamo assistito e stiamo assistendo in questi mesi è la rinuncia da parte della maggioranza del mondo scientifico italiano a difendere le ragioni e le evidenze scientifiche e la sua disponibilità a adattarsi e piegarsi alle richieste di chi in quel momento è al potere e governa nei diversi ruoli istituzionali. Da un punto di vista scientifico è stato vergognoso, direi addirittura ridicolo, vedere ogni sera, alle 18, la Protezione Civile fornire gli aggiornamenti numerici con a fianco i dirigenti dell’Istituto Superiore di Sanità: lavorando sull’epidemiologia sanno benissimo che un’epidemia si gestisce con modalità totalmente diverse e che non ha senso sparare a casaccio il numero di tamponi e il numero di persone positive se contestualmente non si spiega quali sono le strategie adoperate, qual è la popolazione sottoposta a tampone, quanti sono i tamponi effettuati come prima volta per verificare se una persona è infettata o meno, distinguendoli da quelli realizzati su una persona già positiva per verificare se è ancora positiva o se è diventata negativa. Non ha nessun senso dare dei numeri, inoltre, se non c’è un’indicazione nazionale uguale per tutte le Regioni su quale parte della popolazione va sottoposta a tampone, con quali criteri, se non si spiega che i risultati comunicati giorno per giorno non corrispondono ai tamponi realizzati esattamente quel giorno. Ho portato questo esempio banale per non parlare di coloro che hanno riempito i talk show televisivi, più attenti a pavoneggiare se stessi che alla responsabilità
sociale che hanno quando vanno a dare messaggi e informazioni, magari smentiti molte volte dagli stessi protagonisti il giorno dopo o due settimane dopo, come se nulla fosse. Questo comportamento di gran parte del mondo scientifico è speculare al comportamento di gran parte del mondo mediatico, sempre alla ricerca dello scoop, non importa poi verificare se quella notizia è vera o falsa o il suo l’impatto sulla popolazione: è diventato tutto spettacolo. Non c’è nessun senso di responsabilità sociale. Naturalmente ci sono le eccezioni ed è importante sottolinearlo, ma purtroppo lo spettacolo offerto da gran parte del mondo della comunicazione e da gran parte del mondo scientifico è uno spettacolo che mi rattrista molto e mi suscita anche vergogna.
C’è inoltre una parte del mondo scientifico che lavora seriamente, ma che non è riuscita a farsi sentire e forse non ha nemmeno osato intervenire in modo forte per chiedere ai responsabili politici di assumersi fino in fondo le loro responsabilità. Io sono in una serie di mailing list riservate a ricercatori e vedo documenti interessantissimi, ma non vedo poi questi ricercatori uscire con dichiarazioni collettive e rivendicare le loro affermazioni scientifiche, chiedendone conto alla politica. Si tratta di timidezza e della tendenza, ancora troppo forte, che ha il mondo universitario a parlarsi al suo interno, a scambiarsi le opinioni e a non assumersi fino in fondo anche la responsabilità sociale di cui comunque è investito.
Sono assolutamente consapevole dei limiti di Internet e dei social, dei disastri che le fake-news possono produrre; devo però dire che, oltre nelle radio e in particolare Radio Popolare, sui social, tramite le dirette su Facebook, Instagram, ho trovato uno spazio in cui esporre la mia posizione di analisi, di riflessione critica, di elaborazione dei dati – magari molte volte limitandomi a dire “su questo non c’è certezza, non c’è ancora certezza, si sta lavorando” – e assumendo il dubbio come elemento scientifico, che è una cosa assolutamente fondamentale. In questo modo ho anche potuto scavalcare quel muro di gomma rappresentato dal mainstream: d’altra parte mi pare che sia sotto gli occhi di tutti che nessuno mi abbia invitato a parlare del mio libro. E certo! O fai spettacolo o i ragionamenti interessano poco! Ecco, il mio è un libro che non guarda in faccia a nessuno: individuo delle responsabilità, segnalo delle situazioni che non sono andate come avrebbero dovuto e non mi interessa se le persone di cui parlo appartengono a uno schieramento o ad un altro. Risulto indigesto a tutti quanti e, dall’insieme dello schieramento politico, vengo messo in un angolo perché do fastidio. Una tale situazione l’avevo già sperimentata con libro “L’eclissi della democrazia: la verità sul G8 2001 a Genova”: anche in quel caso non abbiamo fatto sconti a nessuno, abbiamo raccontato i fatti e i fatti poi si commentano da soli.
La seconda è relativa al rapporto tra “Big Pharma” e la salute collettiva, non solo a livello italiano, ma planetario. Tu su questo hai lavorato molto in passato. Quale è secondo te il futuro che tentano di prospettarci le grandi aziende farmaceutiche che competono sul terreno della ricerca per il vaccino anti-covid?
Non può esistere diritto alla salute senza uno scontro frontale con Big Pharma e con gli interessi delle grandi multinazionali farmaceutiche, il cui comportamento è stato e continua ad essere assolutamente indecente e vergognoso. Faccio presente solo una cosa, che probabilmente non tutti sanno: alcune delle grandi aziende che, anche grazie a ingenti fondi pubblici, stanno partecipando, ognuna per conto suo, alla ricerca sul vaccino hanno chiesto all’FDA statunitense (che è l’ente che deve approvare o meno l’immissione sul mercato di un vaccino o di un farmaco, quello che l’EMA fa in Europa) di approvare, quando sarà l’ora, anche un vaccino con un’efficacia del 60%. È una follia dal punto di vista della sanità pubblica: abbiamo sempre studiato e spiegato nei corsi universitari, e lo ha sempre detto anche l’OMS, che un vaccino deve avere un’efficacia molto alta, sopra il 90% ma comunque non sotto l’80-85%, o rischia di diventare controproducente. Il motivo è molto semplice. Se abbiamo un farmaco senza effetti collaterali con un’efficacia del 60% e lo somministriamo a 100 persone ammalate, semplificando, ne guariscono 60, le altre 40 persone non guariscono ma nemmeno subiscono danni. Se non ho altri farmaci, tanto vale provare. Nel caso di un vaccino invece il ragionamento è diverso: le persone vaccinate abbassano la soglia di attenzione e le misure di precauzione, pensando di essere invulnerabili grazie al vaccino. Ora, se vaccino 100 persone negative e non ancora infettate, e se nel 40% di queste il vaccino non funziona, queste si infetteranno e diventeranno poi a loro volta dei trasmettitori del virus, pensando di essere sicuri e senza essere neanche sottoposti a sorveglianza sanitaria: otterremmo il risultato esattamente opposto! Di questi però che sono ragionamenti di sanità pubblica a Big Pharma non interessa assolutamente nulla.
Sono stati poi lanciati vari appelli, ad esempio a livello nazionale dal professor Garattini, ma anche a livello internazionale, che chiedono che in questa emergenza vengano messi in discussione gli accordi TRIPs sui brevetti: chiedono che si rinunci ai brevetti, che si stipuli un accordo economico con le aziende (che comunque avrebbero garantito di non lavorare in perdita e di ricavare i loro profitti) secondo cui, nel momento in cui si scoprisse un farmaco utile o si producesse un vaccino, anche altre aziende e anche le strutture pubbliche possano contribuire con i propri laboratori ad aumentare immediatamente la produzione, dando quindi una risposta immediata. Non c’è stata nemmeno una risposta, né dai Big Pharma nè dai governi delle Nazioni occidentali.
Secondo me dobbiamo lavorare per rilanciare la costruzione di un’industria farmaceutica pubblica, di dimensione europea, che lavori per dare una risposta ai bisogni della popolazione, a differenza di molti nuovi farmaci messi in commercio negli ultimi vent’anni che sono destinati a quelle fasce di popolazione che dispongono di grandi risorse economiche e che quindi possono permettersi, per esempio, una cura con un farmaco oncologico che aumenta la sopravvivenza di qualche settimana o al massimo di qualche mese e che costa 100.000 € a ciclo.
Colgo l’occasione di questa intervista per dare un annuncio in anteprima: sono tra i proponenti di un’ICE (ovvero Iniziativa dei Cittadini Europei, una raccolta di un milione di firme in diversi Paesi dell’UE che fa scattare un meccanismo istituzionale che obbliga la Commissione Europea a proporre un’iniziativa legislativa che vada incontro alla richiesta di questi cittadini) che partirà tra qualche settimana. Noi che cosa chiediamo? Esattamente una revisione delle direttive e delle legislazioni rispetto ai brevetti. Per ora lo anticipo solamente, entreremo poi nel merito, ma insomma, è una cosa molto importante che partirà a breve.
Un’ultima domanda. “Senza respiro”, oltre ad essere il titolo del tuo libro, potrebbe essere anche un modo per descrivere le settimane di lavoro “in apnea” che ci sono volute per realizzarlo. Ti conosco e so che sicuramente stai già guardando oltre. Ci puoi dire quali sono i tuoi immediati progetti per il futuro? Intanto continua il proficuo lavoro con Radio Popolare con una vera trasmissione di servizio come “37 e 2”…
In relazione a questa domanda, un traguardo futuro che mi sono posto è proprio l’ICE di cui parlavo prima. Nell’immediato ho due obiettivi: cercare di rafforzare l’Osservatorio Coronavirus costruito da Medicina Democratica e da 37 e 2, la trasmissione sulla salute in onda tutti i giovedì mattina dalle 10:37 alle 11:30 su Radio Popolare e che si può ascoltare in tutta Italia anche in diretta web o in podcast. Come Osservatorio stiamo cercando infatti anche dei fondi, perché, basandoci sul volontariato come ora, non riusciamo a rispondere a tutte le sollecitazioni che ci vengono rivolte: la giornata spesso è dedicata a fornire delle risposte a centinaia di mail, di messaggi WhatsApp, di telefonate, di richieste di spiegazioni, a organizzare le dirette Facebook. Mi piacerebbe allargare un po’ l’attività dell’Osservatorio e cercare di renderlo un punto di riferimento a livello nazionale, rispondendo a esigenze che già ora ci arrivano da fuori la Lombardia. L’altro obiettivo è contribuire alla costruzione di una rete nazionale, che adesso si chiama “Coordinamento nazionale per il diritto alla salute”, che si batte per la costruzione di un SSN differente da quello attuale, universale, partecipato e sostenuto da una fiscalità generale progressiva e che sia in grado di mettere al centro della propria iniziativa la medicina territoriale. Soprattutto, però, mi piacerebbe che questo coordinamento nazionale non durasse una stagione o l’epoca dell’emergenza, ma che, superando le ataviche contraddizioni all’interno dei movimenti sociali, all’interno della sinistra, tra le associazioni, si riesca a costruire un Coordinamento che sia capace di durare nel tempo… Alla fine dobbiamo essere chiari: la salute è un bene comune che sta al primo posto nei bisogni e nelle esigenze di qualunque cittadino.

Intervista pubblicata sul numero di novembre del mensile Lavoro e Salute
In versione interattiva https://www.blog-lavoroesalute.org/lavoro-e-salute-novembre-2020/








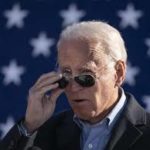

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!